“Lettera a un bambino che è nato”, il duro viaggio della fecondazione assistita
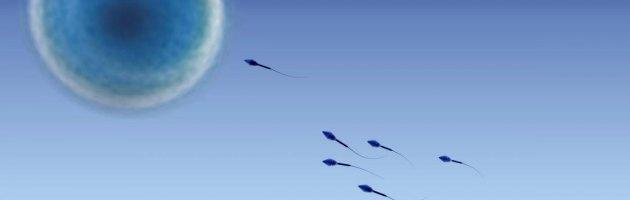
Altro che “un supermercato dove si sceglie il colore degli occhi, i capelli o l’altezza” e in cui “donne in carriere fredde e calcolatrici che antepongono alla voglia di maternità quella di diventare manager d’assalto” vanno a scegliere i propri figli. La fecondazione assistita è piuttosto il viaggio nella “terra dell’inferno” che si attraversa quando ci si scopre affetti dalla “malattia del vuoto”: l’infertilità, quell’ “l’assenza che cattura ogni pezzo di te lacera come un lutto e ti fa perdere la proiezione di te nel futuro”.
Rovesciando il titolo di uno dei libri più privati di Oriana Fallaci, in “Lettera a un bambino che è nato” (appena uscito per Imprimatur Editore), Raffaella Clementi, racconta a suo figlio – nato attraverso la procreazione medicalmente assistita – il suo lungo calvario: non solo medico-burocratico, ma soprattutto emotivo. Gli sussurra di quella “subdola maledetta ostinata voglia, che ti prende alla gola e ti toglie il respiro, di voler dare la vita e non poterlo fare”. Gli rivela come l’infertilità abbia rischiato di distruggere non solo la sua vita, ma anche il suo legame più prezioso, perché “essere sterili è una frattura che comincia come una crepa lungo le pareti della coppia e provoca la sensazione di essere stati traditi, esclusi dall’ordine naturale delle cose”. Sparite l’intimità e l’aspetto giocoso del sesso, resta solo un senso di vergogna e fallimento.
Parlare di fecondazione assistita significa soprattutto parlare di tempo: quello che i genitori si trovano di colpo affannosamente a calcolare, guardando con angoscia ai soli dodici cicli fertili l’anno. Quello delle liste d’attesa dei centri pubblici, che costringono la maggioranza delle coppie a rivolgersi a privati. Quello, infine, che si “si restringe e si dilata, diventa verticale”, mentre si aspettano i risultati di un ciclo di fecondazione (ma il cui risultato bisognerà comunque tollerare, “visto l’enorme investimento in termini emotivi ed economici”).
Di fronte a questo devastante vissuto, ci si sarebbe aspettati, scrive l’autrice (tra l’altro ha il blog “Mammamimmononsolo“), che legislatori e istituzioni tendessero una mano a chi è stato così duramente colpito, “con comprensione ed empatia, invece che giudizio”. E che chi si professava cristiano “cingesse in un abbraccio le donne così duramente colpite”, benedicendo ogni tentativo di mettere al mondo un figlio. Invece no: perché la legge 40, approvata nel febbraio 2004 grazie alle pressioni del mondo cattolico, ha complicato l’arrivo di un figlio, ponendo ostacoli (fortunatamente in parte arginati dalle numerose sentenze da tribunali e Consulta), che l’autrice racconta direttamente nelle loro disumane conseguenze.
Perché, ad esempio, impedire a chi è stato colpito da un tumore dell’apparato riproduttivo di ricorrere alla fecondazione eterologa (quando la donazione di seme quasi ovunque è considerata “pari della donazione di organi o midollo”)? E come si fa a giudicare “raccapricciante” il desiderio di una coppia di avere un bimbo sano, negando la diagnosi preimpianto salvo poi consentire l’aborto tardivo per lo stesso motivo? In che modo risarcire quelle donne costrette, a causa del divieto di produrre più di tre embrioni per volta, a sottoporsi a continue stimolazioni ormonali, molte delle quali hanno avuto come esito gravidanze plurigemellari di cui lo stato poi non si è fatto carico?
“Lettera a un bambino che è nato” è un libro che parla a tutti gli uomini e le donne che desiderano un figlio o stanno cercando di averlo. Spiega loro di non aspettare troppo, perché la scienza è un magnifico strumento ma con dei limiti, “e la vita sempre un dono”. Suggerisce a chi sta vivendo il duro percorso della procreazione medicalmente assistita di “dire la verità, senza vergogna” condividere il dolore con chi è più vicino, cercare medici attenti ed empatici.
Infine invita le donne, con parole poetiche e delicate, a non restare così concentrate su se stesse da credere che gli uomini “siano in grado di combattere i propri e i nostri demoni”, quasi fossero impermeabili di fronte ai fallimenti. Anche loro, conclude, sono sulla nostra stessa barca, provano lo stesso dolore. Ricordarlo nei momenti più difficili significa essere un po’ più forti. E soprattutto sentirsi meno soli.

