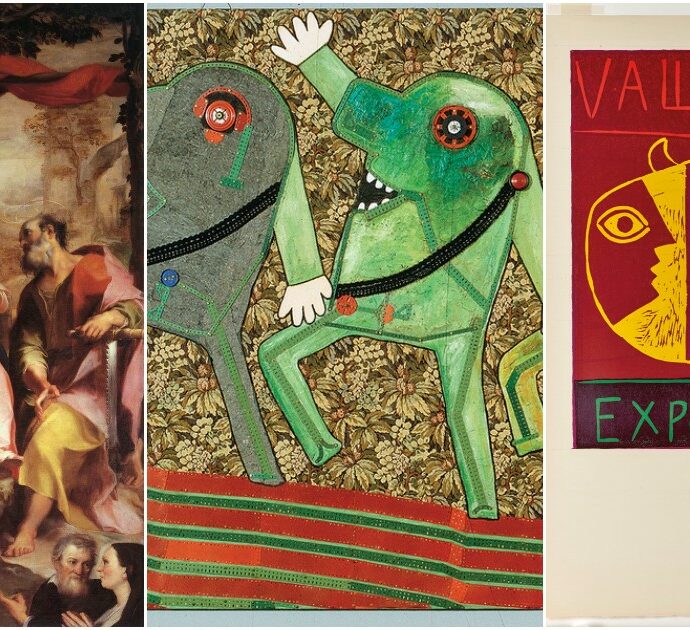Quando Bernardo Bertolucci nel 1983 presiedette per la prima volta la giuria del Concorso del Festival di Venezia premiò Prenom: Carmen di Jean-Luc Godard dicendo che uno dei suoi maestri della Nouvelle Vague non aveva mai vinto e che era giunta l’ora. Leone d’Oro per diritto di carriera per un Bertolucci che potrebbe ripetere l’exploit anche nel 2013 insistendo coi colleghi giurati per quel Philippe Garrel, classe ’48, autore del film in Concorso, La jalousie, amico di lunga data del regista parmigiano e proveniente da quella corrente storica della cinematografia francese a cui entrambi si sono devotamente rapportati.
Il plot de La jalouise, girato nel solito bianco e nero garrelliano, vede il trentenne, squattrinato attore teatrale (il figlio di Philippe, Louis, già interprete di The dreamers di Bertolucci) vivere una storia d’amore con una donna. L’uomo ha una figlia nata da una relazione con un’altra ed ora è follemente innamorato della nuova compagna (Anna Mouglalis), anche lei attrice, ma senza lavoro. L’uomo fa di tutto per trovarle una parte, ma invano. La donna, intanto, lo tradisce, così l’uomo si sparerà un colpo al petto, ma la pistola gli sfugge di mano e, invece di colpire il cuore mortalmente, finirà con un polmone perforato.
“L’idea era di far recitare mio figlio Louis nella veste di suo nonno all’età di trent’anni, la stessa età che Louis ha oggi sebbene la vicenda sia ambientata nel presente – ha spiegato Garrel – Il film racconta la relazione che mio padre ebbe con una donna quando io ero bambino (nella finzione filmica sono una bambina) e l’impegno di farmi crescere gravava sulle spalle di mia madre. Ammirando l’amante ho fatto inconsciamente ingelosire mia madre”.
E tutto fila liscio in questo piccolo gioiello di immediata resa filmica. Un Garrel quasi mai così composto, sintetico e commerciale: non più durate fiume o esposizione di un concetto basico come la “gelosia”, tanto che la sua naturale esclamazione filosofica sull’industria del cinema ripetuta in conferenza stampa pare essere divenuta improvvisamente obsoleta: “possono continuare ad esserci nell’industria della distribuzione cinematografica di oggi film come i miei?”
Cinema autoriale quanto “estremo” nel Concorso veneziano è Stray dogs del taiwanese Tsai Ming-Liang. Storia minimale di un uomo-sandwich a Taipei che vive con due figli piccoli in una baracca lontana dalla città, si lava in un bagno pubblico e vive con silente disperazione un’emarginazione che da sociale, come in tutti i film di Tsai, attraverso un filo narrativo ridotto all’osso e la dilatazione temporale e visiva di intere sequenze, si fa isolamento individuale.
Opera definitiva quella di Tsai, tanto che le sue parole “veneziane” suonano identiche a quelle del collega Garrel: “Il cinema mi ha stancato. Negli ultimi anni, il cosiddetto “valore di intrattenimento” dei film, i meccanismi del mercato e la tendenza ad andare costantemente incontro ai gusti popolari, mi hanno disgustato. Non sento più l’esigenza di continuare a fare film, o meglio, per essere più schietto, di fare un genere di film che vuole compiacere il pubblico cinematografico. Continuo a domandarmi: che cos’è il cinema? Perché realizzare dei film? Per chi lo sto facendo? Chi è il pubblico di massa? È quello che guarda i film di Spielberg?”