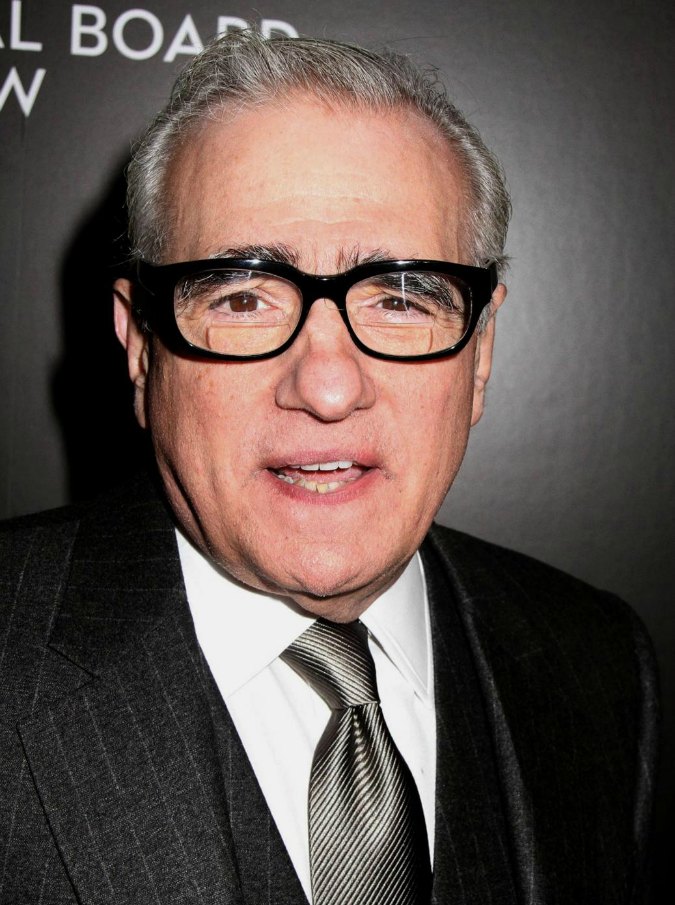Premiato dalla Giuria Ecumenica al Festival di Cannes, esce il 12 febbraio Timbuktu, il film di Abderrahmane Sissako candidato all’Oscar per il miglior film straniero. Con stile paragonabile al nostro neorealismo fotografa la jihad nell’omonima città simbolo di cultura e preghiera musulmane. Fatti di sangue realmente accaduti, religione e interpretazione violenta di essa si mescolano in piccole, tragiche storie di vita.
Le immagini e i panorami contemplativi che ne vengono fuori hanno il sapore di quella meraviglia desertica che spesso va di moda per lasciarsi alle spalle lo stress cittadino almeno per qualche giorno. Invece Abderrahmane Sissako scava in un recente passato, anzi dipinge il presente, portando sullo schermo alcune uccisioni dimenticate. E di più, le vite che c’erano dentro, quelle delle vittime e quelle dei carnefici.
Timbuktu respira l’occupazione del villaggio africano per mano dei fondamentalisti islamici jihadisti. Pratiche più elementari della vita vengono vietate da un’improvvisata polizia armata. Il giovane padre di una famiglia di pastori si macchia di un accidentale omicidio, mentre la nuova legge punisce con lapidazioni adulteri e con nerbate il semplice canto. “L’occupazione della città nel 2012 è durata un anno, durante il quale tutta la popolazione è stata presa in ostaggio. Mentre i media – ha affermato il regista – si sono soprattutto focalizzati sugli ostaggi occidentali rapiti in questa parte del mondo”.
Come un moderno Carlo Lizzani l’artista indaga tra le ferite della sua terra, portandoci il pubblico e svelando qualche retroscena ha aggiunto: “Quando Timbuktu è stata liberata dalle truppe francesi sono andato lì. Avevo intenzione di rivedere la sceneggiatura incontrando la gente del posto. Mi avevano consigliato di parlare con una venditrice di pesce che aveva accettato di indossare il velo contro la sua volontà ma aveva osato sfidare i jihadisti: erano rimasti così sorpresi dalla sua reazione, che l’avevano lasciata stare. È il genere di personaggio che non si può immaginare scrivendo la sceneggiatura a Parigi. Ho visto anche quelle ragazze stuprate che chiamano vergognosamente ‘sposate con la forza’. Esattamente come le studentesse nigeriane rapite da Boko Haram. Ho raccolto tutte queste testimonianze, con attenzione, cercando di restituirle in modo genuino, pudico, senza amplificarle. A che serve aggiungere qualcosa? La realtà è già di per se così terribile. La gente che incontravo parlava poco, voleva lasciarsi tutto alle spalle e passare oltre”.
E quel passare oltre Sissako lo imprime nella scena madre che probabilmente avrà conquistato l’Academy per la nomination: quella della partita di calcio senza pallone, perché pratica vietata. Una sequenza vitale e pungente di resistenza reale tra dribbling immaginari e clandestini. La lavorazione in pericolose location tra Mauritania e Mali non ha impedito all’autore di portare a termine un’opera che mette a nudo alcune novità: quotidiano, indecisioni e intimi segreti dei soldati jihadisti.
“Abbiamo girato per sei settimane nella tensione. Il luogo delle riprese era in una zona pericolosa. C’erano francesi nella troupe. Eravamo protetti dall’esercito della Mauritania. Ma anche se ci dicevano ogni giorno che nessuno sarebbe stato rapito e che la situazione era sotto controllo, non eravamo al riparo da qualche attentato suicida”. Stralci di umanità nel disumano stimolano l’interrogativo più inquietante di tutti: chi finanzia, chi desidera davvero che queste squadre omicide dominino parte del mondo islamico e non solo?
Asciutto e neorealista, Timbuktu rappresenterà l’Africa alla Notte degli Oscar del 22 febbraio insieme a tre film europei e mezzo – Ida dalla Polonia, Tangerines dall’Estonia, Leviathan dalla Russia e Storie Pazzesche dall’Argentina ma prodotto dallo spagnolo Almodovar – tutti e cinque in lizza per il miglior film straniero. Vinca il migliore.
Il trailer di Timbuktu