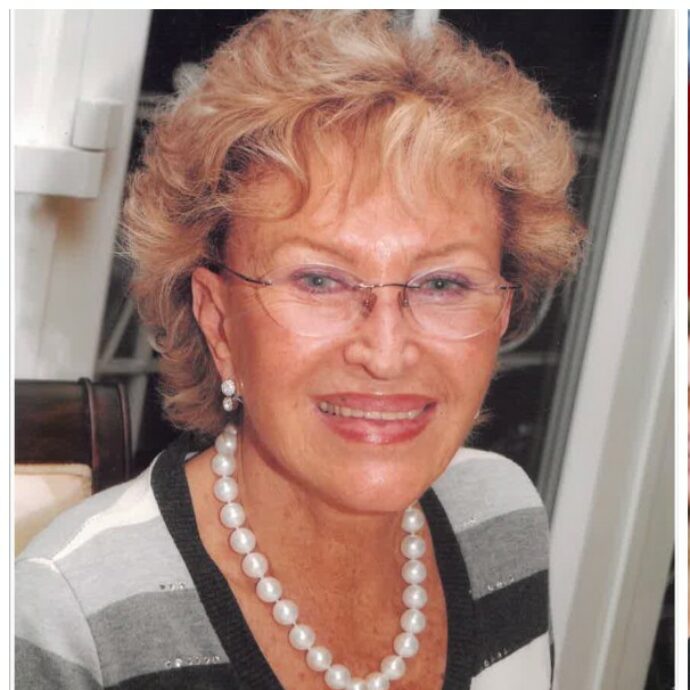Ghost in the shell, buona anche la seconda. Sarà che la schiera di nostalgici della versione Mamoru Oshii sono da mesi pronti con la doppietta per impallinare critici e spettatori ignari che esista un’originaria versione cinematografica del manga di Masamune Shirow datata 1995, ma a noi l’impellente sforzo produttivo di Dreamworks/Paramount/Reliance/Amblin in live action non è dispiaciuto affatto. Intanto le polemiche che hanno preceduto il film riguardo un prepotente whitewashing, l’imbiancatura di personaggi e interpreti qui originariamente asiatici, si attenuano di fronte ad una oramai classica operazione di casting internazionale che mescola pigmentazioni, culture e modalità espressive (qui ci sono Scarlett Johansson, ma anche Takeshi Kitano, Juliette Binoche, “Pilou” Asbæk, e Chin Han) con una sbarazzina necessità più che di colonizzare razzialmente l’anima di un’opera, quanto di incastonare la distribuzione e la visione in più mercati. Secondo: Scarlett Johansson è una delle poche dive hollywoodiane che prova a modulare le proprie interpretazioni in una vasta gamma di generi senza sfiorare vette impossibili ma nemmeno sfigurando in pacchianate madornali. Scarlett versione dark, con caschetto di capelli a scalare verso la nuca, e una magnifica tutina cibernetica che ne marca le forme sinuose, è The Major, Motoko Kusanagi, un cyborg elegante e incredibilmente sexy che con il suo collega Batou (Asbæk) fa parte della Section 9 e risponde ai comandi del laconico Aramaki (un inarrivabile Takeshi Kitano che ruba la scena non alzandosi mai dalla sua scrivania se non sul finale), a sua volta legato agli ordini provenienti dalla società ipertecnologica che si occupa di cibernetica e intelligenza artificiale, la Hanka Corporations.
La sequenza della ricomposizione del corpo di Motoko – di umano Scarlett ha infatti solo… il cervello – apre il film collocandosi in una magnetica vertigine di cavi, cavetti, seni, braccia, mani sintetiche, con relativo abbattimento della normale visione in sala grazie ad un 3D dinamico e avvolgente. La robot hi-tech whitewashed è turbata dal fatto che il suo cervello sia l’unico pezzo “umano” che le è rimasto in quanto battito cardiaco ed esistenza hanno cessato la loro presenza terrena in una spedizione di immigrati annegati dopo un attacco terroristico. Ed è su questa possibile consapevolezza di un ricordo, di memoria di una vita umana (quel “fantasma di un’anima nascosta nel guscio” del titolo), che si dipana il segreto personale della protagonista come contemporaneamente il mistero che ruota attorno a Kuze (Michael Pitt, toh chi si rivede), mefistofelica mantelletta con cappuccio alla Kylo Ren, villain filosoficamente matrixiano che sta attentando alla sicurezza della Hanka Corporations intromettendosi nei circuiti di programmazione dei robot aziendali. Rupert Sanders (Biancaneve e il cacciatore) non ci sta troppo a pensare e appena accennata la ri-nascita di Motoko in Maggiore, fa scattare Ghost in the shell come del resto Oshii facendo tuffare da un tetto, letteralmente in azione, la protagonista per sventare l’omicidio di un funzionario della Hanka durante una cena di lavoro.
Immersa in uno skyline distopico e disumanizzante, megalopoli che mescola grattacieli, asfalto, e caos urbano modello Tokyo, Hong Kong, e Los Angeles alla Blade Runner, la ricerca di Kuze da parte della Section 9 si sviluppa in orizzontale con una sequela di azioni sparatutto, scontri corpo a corpo, esplosioni che non lasciano tregua all’occhio dello spettatore; ma anche in una verticalità disvelatrice di dettagli della protagonista che permettono una detection filosofico-esistenziale al di sotto del senso della sua vulnerabilità e oltre l’opposizione buoni/cattivi di un tipico action movie. Chiaro che la capacità espressiva a livello evocativo e poetico, e anche un tantino ermetica e parecchio culturalmente fine a se stessa, del film di Oshii qui non ne rimane granché traccia; ma non è sul piano della ripetizione pedissequa delle atmosfere originarie che Sanders vuole imporsi. Bensì in quella dimensione stilisticamente spettacolarizzante dove in frantumi finiscono corpi cyborg e porcellane (magnifica la presenza canagliesca del robot geisha nel primo assalto armato) e all’improvviso s’impone la suggestione di alcuni dettagli digitali compenetrati nella carne dei protagonisti con estrema naturalezza (le protesi metalliche al posto degli occhi di Batou, o le scene di massa con umanoidi attaccati nel collo a tubi penzolanti come un deformato Brazil alla Gilliam negli incubi del Maggiore).
Ghost in the shell versione Dreamworks ha quindi nel comparto tecnico un robusto dato caratterizzante: fluorescente production design che solo nella trovata delle giocose figure pubblicitarie tridimensionali grandi come grattacieli merita la visione delfilm; comparto VFX e fotografia coordinati su una levigata tavolozza cromatica che va a succhiare la sua luminosità da fonti e lampi di luce sia da pavimenti/pareti in interni che da squarci insperati in esterni. Dicevamo, infine, di Scarlett Johansson. Questa recitazione volutamente sfuggente e spigolosa lontana anni luce dal personaggio del capolavoro Under the skin di Glazer, non mette in risalto l’intima drammaticità del personaggio come poteva avere fatto la cyborg Alicia Vikander nel sottovalutato Ex-Machina, ma ne recupera una sorta di dimensione seriale utile e funzionale per una catena di sequel che probabilmente non tarderanno ad arrivare