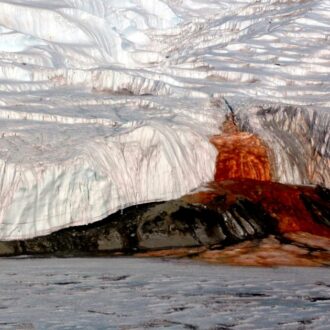La mitopoiesi di una Lega Nord che imitando il vecchio PCI ne avrebbe imitato la pratica del radicamento sul territorio, ha contagiato anche la sempre faticosa immaginazione del PD che ha realmente “sloganato” la formula del “porta a porta”, come se questo ottimistico virus potesse attecchire ai corpi sociali immunizzati dagli antibiotici (etimologicamente) della pervasività mediatica.
L’espressione radicamento nel territorio presuppone un territorio in sé fertile e degno di fiorire e fruttificare nella rappresentanza fotografica di una politica che si metterebbe al servizio della sua immediatezza. Purtroppo il territorio è ampiamente inquinato. Occorre dunque cominciare a dissodarlo e a piantare nuovi semi per frutti più civilmente commestibili.
Un esempio di dissodamento riguarda la bonifica del linguaggio, le cui formule antiche sono portatrici di equivoci e danni simbolici pericolosi per sé e per gli altri.
Ne è un esempio il tema strategico della sicurezza che nel discorso pubblico si articola costantemente nei termini di un supposto diritto alla sicurezza. Tenterò di mostrare la pericolosità sociale enorme di questa espressione, il cui uso ormai consolidato genera aspettative socialmente e tecnicamente insostenibili. A partire dal Leviatano di Hobbes, la sicurezza è un bene (final cause, end, or design of men), non un diritto. Il diritto naturale per Hobbes coincide con l’esercizio della propria potenza ai fini della propria preservazione, a cui si rinuncia liberamente per paura dell’altro (libertà e paura sono per Hobbes compatibili) a favore del Sovrano. Il libero conferimento del potere al Sovrano comporta da parte sua, in cambio, null’altro che la tutela della sicurezza: verso il nemico esterno, con la milizia armata, e all’interno dello Stato con l’amministrazione delle controversie. E tuttavia anche nel paradigma del patto politico più radicale dove il popolo conferisce al Sovrano il potere assoluto, ciò che esso riceve in cambio – la sicurezza – non è per nulla la garanzia di un diritto, ma la tutela di un bene.
Solo se si affronta la sicurezza come un bene, cioè come uno scopo, un fine, un obiettivo sociale, – e quindi solo parzialmente ottenibile -, e non come un diritto soggettivo, cioè formalmente esigibile, è possibile sdrammatizzare la percezione allarmata della sua scarsità. Viceversa ci troviamo di fronte a paradossi insuperabili. Il primo è la pretesa folle che l’insicurezza sia sottratta alla Vita. Su questa pretesa si sono costruite intere cattedrali metafisiche, religiose e mercantili. La vita sicura è un ossimoro, in qualche modo grottesco. La sua pericolosità le è intrinseca. Le vie di fuga da questa evidenza sono frutto delle promesse di imbroglioni e illusionisti di varia estrazione. Il secondo è che tale eliminazione di ogni insicurezza sia un diritto e non un progetto, sempre precario e reversibile, e sempre da sperimentare in ordine al massimo della tutela possibile. Chiedere allo Stato il massimo della tutela possibile della propria sicurezza è ragionevole, e comporta che si percepiscano le offese e i danni patiti non come un diritto negato, di cui si darebbero garanti assoluti, ma come un bene sottratto, del cui riacquisto occorre farsi carico con il realismo dell’intelligenza. Qualsivoglia progetto sicurezza mai garantirà sicurezza assoluta, e questo senso del limite dovrebbe impedire che di ogni potenziale evento rischioso, pericoloso o dannoso, venga pretesa la sparizione, e che di ogni aggressione subita da chiunque si faccia un caso inaudito e inconcepibile.
Nessuna politica, nessun ordine sociale può garantire l’assoluta sicurezza dei suoi cittadini. Può garantire (quando può) l’impegno sia preventivo che repressivo rispetto ai crimini, nei limiti della contingenza del vivere insieme. Lasciare circolare, enfatizzare e strumentalizzare l’idea che esista un vero e proprio diritto alla sicurezza fa sì che la spirale fra innalzamento delle pretese soggettive ed escalation delle soluzioni promesse produca un corto circuito disastroso fra delusione sociale permanente e deliri d’onnipotenza politica. Emendare il linguaggio sarebbe già un primo passo verso una ragionevole e civile impostazione di un problema peraltro coestensivo con l’esistenza stessa di una società. Ad esso dovrebbero naturalmente seguire più difficili e impegnative iniziative politiche in grado di disarticolare i vari registri e tipologie della domanda sociale di sicurezza in una visione collaborativa capace di far maturare aspettative razionali e risposte efficaci.
Articolo Precedente
Somewhere: polvere di Hollywood

Articolo Successivo
La narrazione e le scene tagliate