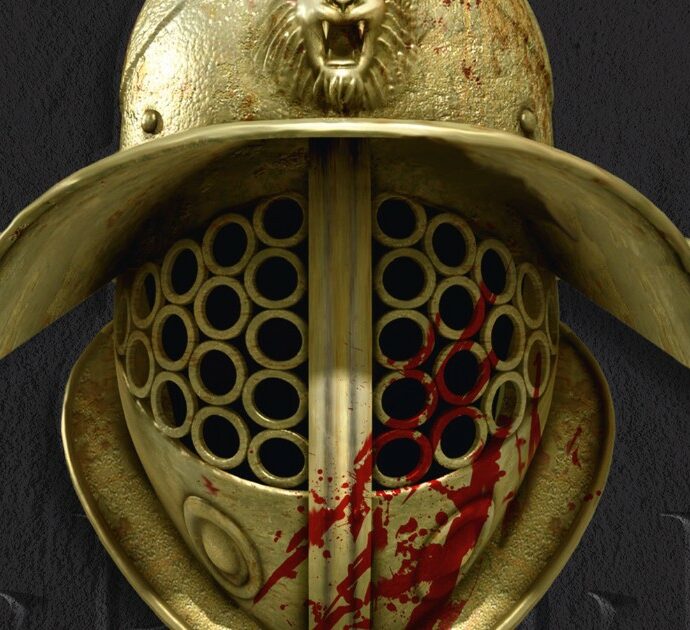In quella New York “al collasso, pericolosa, sudicia, dove spesso latitavano i servizi essenziali” e “i gay portavano al collo dei fischietti per poter chiedere aiuto ad altri gay in caso di aggressioni” lui c’era. E c’era in una Roma dove “tutti sembravano eleganti … il vigile dai guanti bianchi sembrava un direttore d’orchestra”, ma la gente tirava la cinghia cenando con “solo pane alla luce di una nuda lampadina”. C’era nella Venezia di Peggy Guggenheim (“un fuoco estinto, un tempo fuoco e fiamme”) dove “i camerieri dell’Harry’s Bar sembravano personaggi di Goldoni”. E nella San Francisco bucolica, vegetariana e salutista post beat, e pre Aids.
Ma, soprattutto, c’era durante la rivolta di Stonewall, data di nascita del movimento gay: lui che pure andava dallo psicanalista per “cambiare stato”, che non sapeva nemmeno cosa fosse l’orgoglio gay perché “all’epoca c’era solo il terrore gay, l’isolamento gay, la sfiducia gay e l’odio di sé gay” improvvisamente capì di far parte di “una minoranza, con diritti, una cultura, degli obiettivi politici”.
Lui è Edmund White, 70 anni, autore di Un giovane americano, L’uomo sposato, La sinfonia dell’addio, delle biografie di Genet, Proust e Rimbaud (premio Mondello 2010) e dell’avvincente memoir che presenta, oggi, al Festival della Letteratura di Mantova: Ragazzo di città (Playground, 18 euro).
Erano i Sessanta e Settanta ed Edmund White attraversava quegli anni cruciali con gli occhi ben aperti sul mondo che cambiava. E sui ragazzi che gli piacevano. Teatro principale dei suoi ricordi è New York, riportata ai fasti e alle miserie di allora con ricchezza di aneddoti, informazioni, intuizioni e un brio straordinario. Non c’è nostalgia nel racconto. Piuttosto, un tardivo stupore nel rievocare una giovinezza sfrenata e difficile fatta di sesso (molto), pasti saltati, romanzi rifiutati, lavori aborriti. E case sudice, strade insicure, rapine subite. Ma anche cultura a portata di metrò, la possibilità d’incontrare e diventare amici di poeti e pittori, coreografi e scrittori già acclamati o “famosi domani”: James Merril e John Ashbery, Jasper Johns e Robert Rauschemberg, Bob Wilson, Gorge Balanchine, Vladimir Nabokov e Susan Sontag e molti altri ancora.
Di loro White racconta vezzi e vizi con levità e, talvolta, squisita perfidia: come quella che mette nel ritratto di una odiosa e bugiarda Lillian Hellmann. Ma nel ricordo di quegli anni prevale il disincanto: l’analisi dei dogmi politici e culturali dell’epoca è spesso impietosa, sia che rievochi la new left, così attenta ai diritti dei neri e pochissimo a quelli delle donne, o la “nuova critica letteraria”, dove i vecchi critici “provvisti di tre cognomi e vecchi completi in tweed” venivano sostituiti da “ragazzotti ambiziosi che non sapevano nulla”. Categoria, quest’ultima, della quale White confessa di aver fatto parte. Ed è, anche questo, un vezzo, perché l’autore avrà pure “fatto parte dei barbari” come scrive, ma si è ampiamente riscattato con una letteratura lodata da Nabokov e premiata dalla critica. E molto fruibile, almeno in questo Ragazzo di città, da un pubblico giovane interessato a sapere da dove veniamo. Ottimo esercizio per capire come siamo diventati.
di Valeria Gandus