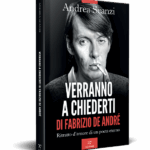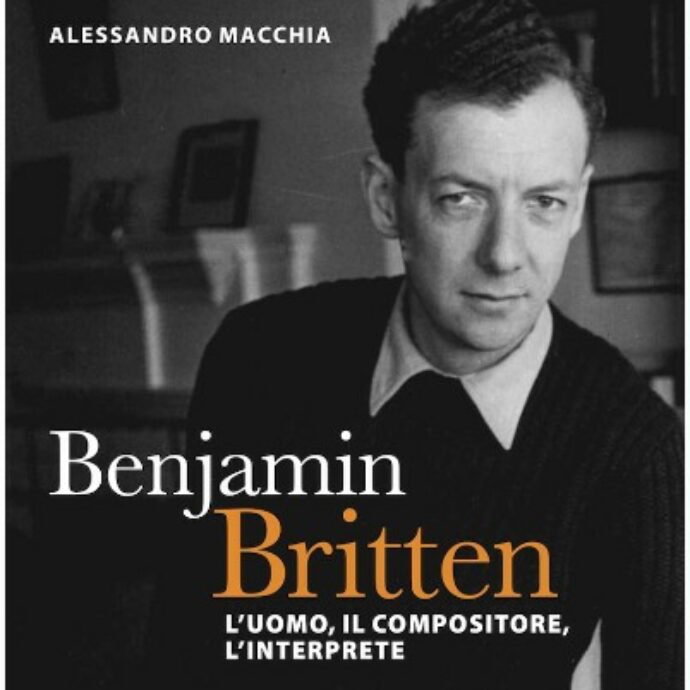Quanti gaberiani sono spuntati fuori, dopo la sua scomparsa. Tutti pronti a sgomitare per appropriarsi di un intellettuale che faceva già fatica ad appartenere a se stesso. Sabato e domenica ha avuto luogo a Viareggio la settima edizione del Festival Gaber. Maniera garbata, benché perfettibile, di ricordare una figura urticante e non etichettabile. Sandro Luporini, pittore e co-autore del Gaber teatrale, si aggirava per la Cittadella del Carnevale compiacendosi per l’esibizione di Andrea Mirò e non apparendo esattamente entusiasta di Marco Mengoni (trionfatore della terza edizione di X Factor). Come non lo era parso, negli anni scorsi, per le Pausini e i Baglioni.
Quanti gaberiani sono spuntati fuori, dopo la sua scomparsa. Tutti pronti a sgomitare per appropriarsi di un intellettuale che faceva già fatica ad appartenere a se stesso. Sabato e domenica ha avuto luogo a Viareggio la settima edizione del Festival Gaber. Maniera garbata, benché perfettibile, di ricordare una figura urticante e non etichettabile. Sandro Luporini, pittore e co-autore del Gaber teatrale, si aggirava per la Cittadella del Carnevale compiacendosi per l’esibizione di Andrea Mirò e non apparendo esattamente entusiasta di Marco Mengoni (trionfatore della terza edizione di X Factor). Come non lo era parso, negli anni scorsi, per le Pausini e i Baglioni.
Il pubblico è in gran parte nazionalpopolare. Per questo la figlia Dalia Gaberscik, direttrice di una potente agenzia di comunicazione, suole alternare nomi d’élite a scelte mainstream. Per avere più gente (11mila persone) e permettere ai più giovani, accorsi per ascoltare Emma Marrone (vincitrice della nona edizione di Amici), di scoprire “per caso” Gaber. Sensato, ma sarebbe auspicabile vedere prima o poi su quel palco anche Samuele Bersani, Elio, Caparezza, Vinicio Capossela, Petra Magoni, Paolo Benvegnù, Vasco Brondi, Max Gazzè, Carmen Consoli, Pan Del Diavolo. Eccetera.
Livello discreto. Di gran lunga i migliori Cristiano De André e Daniele Silvestri. Il primo, commosso, ha riproposto Buttare lì qualcosa, manifesto programmatico di Gaber-Luporini: sintomatico come, in sette edizioni, nessuno prima di lui l’abbia eseguita. Brava Andrea Mirò. Lodevole Enrico Ruggeri con Un’idea. Coraggiosa la Pfm nell’affrontare Quando è moda è moda. Poco centrato il presentatore Enzo Iacchetti, che – fuori scaletta – ha invitato sul palco un’Alba Parietti esondante labbra e retorica: momento agghiacciante. Emma e Mengoni, al di là della bolsa querelle khomeinista sui reality, hanno esibito un talento manierista: se a Emma togliessero le urla e a Mengoni i birignao, forse resterebbe giusto il fard.
Ricordare Gaber è difficile. La memoria di Fabrizio De André poggia sulla santificazione. Quella del Signor G è spesso all’insegna del pressappochismo e del disinnesco: o lo si fraintende o lo si edulcora. Due anni fa Repubblica sparò la scoperta di un inedito (E tu Stato) che tale non era. Ieri il Corriere della Sera ha condensato la due giorni soffermandosi sulla esiziale rivelazione di Ornella Vanoni, che ha raccontato di una lontana avance (respinta) di Giorgio: notizia avvincente, non meno di una prolusione sulla psoriasi. Anche lo speciale televisivo di giovedì scorso su RaiDue era incentrato sul Gaber dei Sessanta: quello televisivo, encomiabile ma minore. Focalizzare l’attenzione su Non arrossire equivarrebbe a sostenere che il vero De André è quello de La canzone di Marinella. Se Faber si fosse fermato lì, oggi lo ricorderemmo come un Vecchioni qualsiasi; se Gaber si fosse fermato alla Torpedo Blu, non avrebbe scorticato le nostre coscienze.
Il Gaber irrinunciabile è quello del Teatro Canzone, dal 1970 al 2000. Un percorso discograficamente atipico, oltraggiosamente libero e lontano dai riflettori (se non quelli dei datori di luci). Sentire Vittorio Feltri che lo elegge a maestro mette imbarazzo. Il “giornalismo” alla Feltri, Gaber lo mitragliava di continuo, ad esempio nella feroce Io se fossi Dio: “Maledirei i giornalisti e specialmente tutti, che certamente non son brave persone e dove cogli cogli sempre bene”. Gaber è unicamente accostabile, per capacità profetica e approccio problematico, a Pier Paolo Pasolini. Anche il suo approdo ultimo – la dittatura del mercato – è analogo. A differenza di Dario Fo, che non ha mai abbandonato la visione un po’ manichea, Gaber e Luporini buttavano lì qualcosa per poi andare via. Non alimentavano certezze, bensì dubbi. Ferivano la morale per tenerla in vita. Accusati di qualunquismo, non erano più né compagni né femministaioli militanti. Cani sciolti anarcoidi, casomai. Il contenuto era contenitore e l’interpretazione riverberava il testo. Oggi che non c’è, esistono solo due strade: o lo reinterpreti male, e in questo caso Morgan dà ottime garanzie, o lo rifai identico. Ne è prova il Polli di allevamento di Giulio Casale, bello e più vero del vero, ma accusabile di eccessiva adesione filologica.
Il neosindaco di Milano Pisapia ha scelto Gaber come colonna sonora delle sue elezioni: un segnale distensivo, da parte di una sinistra che lo aveva scomunicato. Perché non faceva sconti, perché la moglie Ombretta Colli è berlusconiana di grido e perché il dissenso è per certa intellighenzia lesa maestà. Se il centrodestra ha nuovamente usato Lucio Battisti per darsi uno spessore (che non ha) culturale, financo Gianfranco Fini aveva provato a fagocitare lo slogan – mai troppo amato dagli autori – del “libertà è partecipazione”. Brani arcinoti come La libertà o Destra e sinistra, proposti non a caso anche da Emma e Mengoni, sono ammirevoli ma con quel retrogusto ridanciano che li rende quasi mansueti. Esattamente ciò che non era Giorgio Gaber. L’uomo che abbandonò tutto per inventare un genere. L’italiano che non si sentiva tale, ma per fortuna o purtroppo lo era. L’intellettuale morto il Primo Gennaio 2003 a neanche 64 anni, che tutti dicono di conoscere e pochi conoscono davvero. Meritorio insegnarlo nelle scuole (sarebbe l’unica cosa buona compiuta dal Ministro Gelmini). Ma che il ricordo sia storicamente rispettoso. Anche a costo di risultare fastidiosi. Proprio come a volte era lui, tra un palpito del cuore e un alambicco della ragione. Proprio come ci sarebbe bisogno oggi, se solo gli intellettuali volessero dare cenno di sé.
Il Fatto Quotidiano, 26 luglio 2011