Pakistan, operai bruciati vivi. Ma la fabbrica aveva certificazione italiana
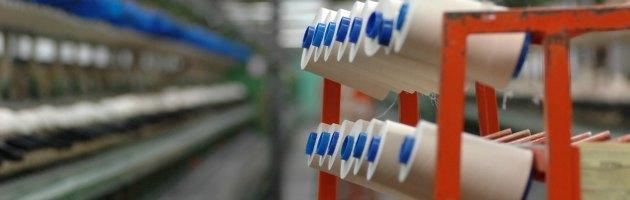
Il Registro Italiano Navale di Genova (Rina) aveva concesso alla Ali Enterprises di Karachi il SA8000, a garanzia della salute e della sicurezza dei lavoratori. Eppure un mese fa sono rimasti soffocati dal fumo o addirittura annegati negli scantinati. L'ente risponde: "Stiamo facendo accertamenti"
Quasi 250 operai bruciati vivi nello stabilimento in fiamme, appena certificato come ‘sicuro’. L’inferno della Ali Enterprises, il settore tessile dei poveri: a poco più di un mese dalla terribile tragedia di Karachi, il peggiore incidente industriale della storia pakistana, non è ancora stata fatta chiarezza. Neppure sulla validità dei sistemi di controllo che, solo un mese prima, avevano dato all’azienda l’ambita certificazione SA8000. Nato nel 1997 per garantire i requisiti etici delle imprese verso i lavoratori, questo prestigioso attestato internazionale era stato rilasciato all’azienda il 20 agosto, meno di un mese prima. Da chi? Dal Rina, il Registro Italiano Navale di Genova, una società di ispezione accreditata a livello mondiale: da anni il gruppo ligure tiene sotto controllo centinaia di aziende in tutto il pianeta, per conto di una struttura di New York. Sigle remote e anonime, che parlano la lingua franca della globalizzazione: come il Saas, Social Accountability Accreditation Services, l’ente che accredita il Rina, o come lo stesso Sai, Social Accountability International, con sede nella Grande Mela.
Un organismo finanziato dalle maggiori multinazionali, che non fa nulla per rivelare le conclusioni dei revisori accreditati, come l’azienda italiana. Né tanto meno i marchi i cui prodotti provenivano dallo stabilimento asiatico devastato dalle fiamme, in un contesto già in partenza tragico. Corruzione, malagestione, ricatti, omertà: è il sistema dell’industria tessile pakistana. Che, da sola, vale il 53% delle esportazioni del Paese. E che vede consumarsi una strage dopo l’altra. Compresa quella dello scorso 11 settembre a Karachi: una tragedia evitabile, avvenuta in uno stabilimento in cui, su oltre mille impiegati, solo 250 erano assunti regolarmente. Già passato alla storia come uno degli incidenti industriali peggiori di sempre, l’incendio che ha distrutto la Ali Enterprises rappresenta un notevole smacco per le imprese del “primo mondo” ed i factory monitoring system che ne garantiscono l’eticità: verifiche e attestati di buona salute alle fabbriche situate nei Paesi in via di sviluppo, sempre più attive nel produrre capi di abbigliamento, apparecchi elettronici e centinaia di altri prodotti destinati ai mercati occidentali. Lavoratori perfettamente tutelati, secondo i certificatori internazionali della Sai: nello stabilimento di Karachi, scrive il Rina nel suo sito web, gli estintori erano “visibili e accessibili a tutti”, nonché “disponibili in sufficiente misura”. Le vie di fuga? “Libere da ostacoli”. Perché, allora, 247 persone sono rimaste bloccate in una fabbrica le cui uscite erano sbarrate dall’esterno? Operai rimasti senza estintori e bruciati vivi, soffocati dal fumo o addirittura annegati negli scantinati dalle tonnellate di acqua riversate sull’edificio per spegnere le fiamme. Ma non doveva essere tutto in regola? “È la prima domanda che tutti ci siamo posti”, ci dice Giulia Faravelli dell’ufficio stampa del Rina. Che, proprio per questo, “sta portando avanti indagini interne legate a questo evento e collaborerà appieno agli accertamenti avviati dalle autorità competenti”, oltre a condurre “un audit interno straordinario in Pakistan, dove ha inviato un Senior Auditor”.
“Al momento della visita le cose erano effettivamente a posto. Purtroppo il nostro lavoro non è di vigilanza giorno per giorno”, aggiunge Faravelli: “C’è poi una effettiva parte di responsabilità dell’azienda, che dal giorno dopo la visita può scegliere di non rispettare più le norme”. Un’eventualità che, in sostanza, potrebbe anche portare a rivedere daccapo lo schema. “L’audit che abbiamo avviato subito dopo la vicenda è un processo ancora in corso che sta interessando alcune aziende da noi certificate in Pakistan, ispezionandole senza preavviso”, conclude Giulia Faravelli che puntualizza: “I primi risultati mostrano che la pratica di sbarrare volontariamente le porte per impedire ai lavoratori di uscire da una fabbrica non è assolutamente diffusa”. Per Nasir Mansoor dalla National Trade Union Federation, in Pakistan, “le famiglie dei lavoratori deceduti e feriti meritano piena trasparenza in merito al ruolo delle organizzazioni di controllo dei marchi che hanno fatto profitti a discapito della sicurezza dei lavoratori”. Non è solo un problema del Pakistan: “Al Rina e alla Sai – afferma Francesco Verdolino della campagna Abiti Puliti – chiediamo la lista degli acquirenti della fabbrica che è andata a fuoco, in modo da provare a portare queste aziende a risarcire le vittime di questa tragedia: cosa che non vogliono fare, per un loro vincolo di segretezza”. Inoltre, aggiunge, “chiediamo i report dei loro vecchi audit, per sapere con chi hanno parlato in quei posti”. Probabilmente, sottolinea Verdolino, gli ispettori del Rina hanno sentito solo il management, e non i lavoratori, facendo così decadere la validità dei controlli: “Ma il vero problema rimane il fatto che queste verifiche possano essere concordate in anticipo”.