Spiegava a modo suo il grande Massimo Troisi, nel film Le vie del Signore sono finite, di non volerci neanche provare a leggere dei libri ”Che i libri so’ milioni, milioni, non li raggiungo mai, capito? pecché io so’ uno a leggere, là so’ milioni a scrivere, cioè un milione di persone e io uno mentre ne leggo uno…”.
Parlando di fotografie si potrebbe, oggi, fare più o meno lo stesso ragionamento.
Si stima che, solo nel 2011, le nuove fotografie prodotte siano state circa 400 miliardi; ogni giorno 200 milioni di foto vengono caricate su Facebook.
Qualcuno, come Troisi, può legittimamente arrendersi di fronte allo tsunami iconico che tutto travolge.
Non voglio qui ripetere le cose mille volte sentite sul ruolo che, in questa bulimia d’immagini, hanno avuto l’avvento del digitale (semplicità, agilità, immediatezza, economicità, integrazione tra device…) e i social network con il loro imperativo alla condivisione (ovviamente anche fotografica).
Non voglio analizzare il cambiamento di prospettiva, dal fotografo verso il mondo al fotografo verso il suo mondo, spesso ridotto al suo ombelico.
Mi interessa piuttosto capire come ci si può difendere, come ci si può mettere a dieta. Come evitare di scoppiare, di ubriacarsi, di finire stesi, di ricorrere a due dita in gola dietro la porta del bagno. In sintesi, come evitare l’indigestione riscoprendo la capacità di discernere, scegliere e valorizzare un buon piatto di alta cucina – cibo per gli occhi – rispetto a vagonate di junk food.
Tanto il fenomeno è interessante in chiave sociologica, quanto è insostenibile in termini estetici.
Nessuno vuole colpevolizzare una foto di compleanno twittata dal telefonino a beneficio degli amici assenti, ma è appunto un frammento visivo che assume senso solo per chi condivide quel “preciso qualcosa” che tale foto rappresenta. Per gli altri, per tutti gli altri, è rumore di fondo. E sappiamo che il rumore può condurre alla pazzia.
Vi invito a rileggere il racconto di Italo Calvino ‘L’avventura di un fotografo’: Calvino – che la sapeva lunga – aveva intuito in tempi non sospetti (1955) quel rischio compulsivo che, in qualche modo, dilaga oggi su Facebook e non solo.
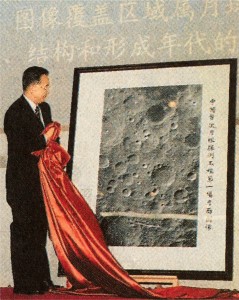 Che fare dunque?
Che fare dunque?
Joachim Schmid già nel 1989, in occasione del 150° anniversario dell’invenzione della fotografia, ha buttato il suo sasso nello stagno, proclamando: “Nessuna nuova fotografia finché non saranno utilizzate fino in fondo quelle già esistenti!”, e questo è stato il suo credo fino ad oggi. Egli le foto non le fa: le studia e le colleziona. Già così non contribuisce al loro aumento. Ma soprattutto le vuole valorizzare, riproporre, dare vita nuova e occhi nuovi a foto di altri ormai dimenticate, prelevate qua e là.
Con un’operazione postmoderna di ridestinazione egli “ruba” immagini anche da libri, poster, figurine e poi le manipola, le assembla arbitrariamente dimostrando che possono continuamente rinnovarsi e che dunque, paradossalmente, non c’è bisogno di farne altre, di farne nuove.
E’ chiaro l’intento provocatorio e radicale dell’operazione, ma c’è di che riflettere.
Un blob che cuce insieme visioni passate per dare nuovo senso e nuove letture, un racconto modernissimo in salsa retrò.
Sono le nuove consapevolezze a dar valore a ciò che spesso fu trascurato: succede nell’antiquariato, succede quando in tv, tra una velina ed un politico ululante, irrompe dagli archivi un minuto di Studio Uno, succede con la panzanella.
Joachim Schmid usa le foto, e il frutto del suo lavoro potete vederlo nella mostra appena aperta a Cinisello Balsamo (fino al 5 maggio 2013) presso il Museo di Fotografia Contemporanea, dal titolo Joachim Schmid e le fotografie degli altri.
Se poi le “operazione recupero” vi appassionano, allora buttate un occhio anche a questa mia collezione in progress di foto trovate.
Tutto un po’ passatista – dirà qualcuno – e pure vagamente paternalistico. In verità c’è anche molto gioco: con ironica contraddizione Joachim Schmid, oggi, va dicendo a tutti “Per favore non smettete di fotografare”.
Articolo Precedente
Daria Bignardi è un uomo. E scrive da Dio

Articolo Successivo
Battisti, Martelli e un’autorità che non c’è









