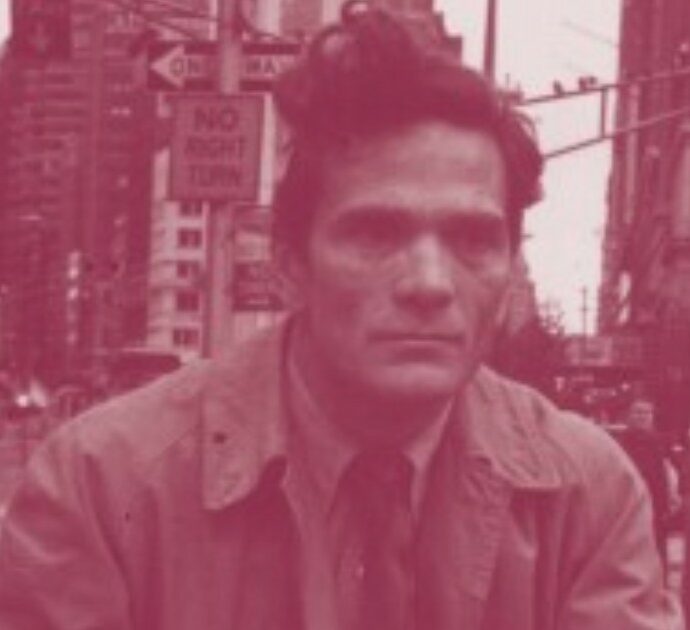“La guerra in Siria? Forse ci sarà, certo nessuno lo spera ed io per primo. Però stiamo attenti, le guerre ci sono sempre state e purtroppo sempre ci saranno, il vero problema è che non si possono mai prevedere le conseguenze che comportano. Neppure nell’era delle tecnologie più raffinate come quella contemporanea”. Errol Morris, documentarista americano premio Oscar nonché bestia nera per la malapolitica made in Usa quasi quanto Michael Moore, arriva al concorso di Venezia 70 con l’aria dell’eroe senza preconcetti. Perché ogni verità vive di vita propria, da verificare sul campo e non nella propria testa.
Per questo il suo ritratto di Donald Rumsfeld ha riempito di aspettative il Lido, e non solo in quanto uno dei due documentari concorrenti (l’altro è quello dell’italiano Gianfranco Rosi che arriverà a Venezia il 5 settembre). Il titolo è già ammantato di curiosità linguistiche: The unknown known, che in un macchinoso italiano potrebbe suonare come “ciò che si pensa di sapere e che poi si scopre di non sapere”. E l’elemento intrigante è che la definizione arriva dallo stesso “architetto della guerra in Iraq”, come Rumsfeld viene spesso etichettato. Un personaggio di nota potenza ma che fino al ritratto di Morris non si era mai manifestato un tale showman. Al punto da indurre il cineasta/reporter americano a definirlo come “il personaggio finora più difficile da intervistare di tutta la mia carriera.
Rumsfeld è un maestro di comunicazione. Si esprime alla perfezione e si presta a soddisfare e compiacere le pretese di chi sta dietro alla videocamera. Per questo diventa urgente capire cosa ci stia dietro alle sue parole”. Questo a giustificare il fatto che nel documentario di Morris “parole e definizioni” (prese dal Dictionary of the Pentagon, di rumsfeldiana invenzione) sono al centro del dispositivo linguistico/espressivo messo in campo. L’ex segretario della Difesa sotto George W. Bush che già a 30 anni nel ’62 entrava al Congresso di recente si è espresso contro l’intervento di Obama in Siria. “Certo, oggi può farlo – chiosa Morris – all’epoca della guerra nel Golfo non poteva. Però tentò di dimettersi davanti all’inasprimento del dibattito sui detenuti di Guantanamo e i trattamenti disumani contro quelli di Abu Ghraib”.
Il tema, non caso, è uno dei punti nevralgici del documentario/intervista, ovvero uno di quelli in cui le capacità dialettiche di “Don” Rumsfeld emergono con maggior incidenza. “Cerchiamo sul vocabolario termini come ossessione, capro espiatorio, guerriglia, brutalità, conflitto, ricatto” sembra il mantra dell’astuto politico repubblicano che con abilità è riuscito in anni di carriera a raggirare l’opinione pubblica meno attrezzata alla comprensione delle strategie politiche americane. E lo fa anche quando Morris tenta di metterlo al muro: “Non ritiene che gli americani ci siano andati per nulla in Iraq, cioè che le armi chimiche non siano mai esistite come è stato più volte dimostrato?” “Ritengo che solo il tempo lo dirà. Di certo se avessimo ucciso prima Saddam Hussein forse avremmo potuto evitare la guerra”.
La conversazione con Rumsfeld è mostrata da Morris per il tempo di due ore di film, con una preziosa ricognizione sulla storia degli Stati Uniti, da Pearl Harbour in poi. Se il personaggio Rumsfeld emerge, e come sovente accade con gli “scomodi” suscita ammirazione per arguzia, fantasia e intelligenza nelle risposte (“Pearl Harbour è stato solo un fallimento di immaginazione”) il documentario del pluripremiato Morris (Oscar per l’indimenticabile The fog of war nel 2003, mentre il suo Gates of Heaven del 1978 sul business dei cimiteri è considerato da molti critici americani uno dei migliori dieci documentari di sempre) risulta purtroppo meno incisivo e rivelatore di quanto ci si aspettasse: difficile prevedere un premio pesante quanto il personaggio che ritrae. Un vero peccato.