Viaggi, a spasso per Montevideo e Uru-guai di confine
Era una notte buia e tempestosa, e il taxista che ci preleva alla stazione rodoviaria di Montevideo ci mette subito del suo. “Non uscite quando diventa buio, non superate questa strada, non attraversate questa piazza…muy peligro in questa città anche di giorno…per ogni spostamento usate un taxi”. Vanta origini italiane e se la cava con la nostra lingua; i suoi avvertimenti, urlati da dietro il vetro antisfondamento che separa il sedile posteriore da quello anteriore, assomigliano molto a quelli già sentiti dai suoi colleghi brasiliani. Ma noi, dopo avere passeggiato senza problemi per Porto Alegre anche fino a tardi, cominciamo a chiederci se in tanto allarmismo non ci sia anche un po’ di marketing: “Non uscite mai senza taxi. Parola di taxista”. Ci piacerebbe verificare fin dalla mattina seguente, visto che abbiamo solo un giorno e mezzo per restare nella capitale dell’Uruguay, ma è impossibile. Di uscire a piedi, con il nostro guardaroba hawayano e la pioggia che è quasi nevischio, non se ne parla. Oltre il piazzale dell’hotel, l’oceano arrabbiato,”il mare giallo della portentosa dovizia del fiume”, con i gabbiani che fanno surplace giocando con le raffiche. Anche i taxi non arrivano, così nasce la solidarietà tra sequestrati alberghieri e con l’andare del tempo nella hall ci si conosce un po’ tutti; ci sono anche i componenti di una band argentina, i Tam Bionic (Youtube svela che fanno un rock pop molto interessante, venato di melodie arabeggianti); ricordano un po’ i Dissidenten, un complesso tedesco-marocchino degli anni ottanta, e in Pietro la mai sopita nostalgia di Cefchauen riprende vigore. Quando abbiamo qualcosa nel cuore, ci sembra di vederlo dappertutto.

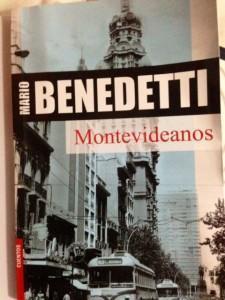
Peccato doversene andare subito, ma il tempo stringe. Domani di buon mattino dobbiamo presentarci al porto di Buenos Aires per l’annunciato sbarco della Rabmobile. Umidi dentro e imbacuccati alla bellemeglio, ci imbarchiamo sull’ennesimo onibus, quello che in poco meno di tre ore ci porterà a Colonia del Sacramento; da qui con una nave veloce si attraversa il fiume Paranà e in poco più di un’ora si arriva direttamente nella capitale argentina. Il cielo si è aperto, finalmente. La pampa, ora, è decisamente più verde e il pomeriggio è quasi azzurro. Anche le mucche hanno cambiato aspetto: non più tutte marroni ma molto più eleganti, pezzate a macchie bianche e marroncine, uguali alla celebre mucca dei Pink Floyd (foto 4).
All’imbarco tutto fila liscio, possiamo perfino liberarci della sciarpa da pochi pesos acquistata in mattinata come pronto soccorso. La doganiera a cui tendiamo il passaporto sorridenti ci sorride a sua volta, ci sorride, ci sorride…Non smette di sorridere perché continua a sfogliare le pagine del passaporto senza riuscire a trovare il visto di ingresso in Uruguay. Pian piano il sorriso si va trasformando in una smorfia perplessa. Dove diavolo è quel visto?
Prima che ce lo chieda, glielo diciamo noi. Il visto non lo trova perché non c’è. E con tipica fioritura italo-melodrammatica le raccontiamo del nostro avventuroso passaggio di due giorni prima oltre il fiume Rio Branco, nel pieno del fortunale. La doganiera prima spera di aver capito male (cosa probabile, visto il nostro spagnolo maccheronico), ma poi è perentoria. Il sorriso è diventato una maschera di ghiaccio: senza il visto di ingresso in Uruguay non si può uscire dall’Uruguay. Ci fa uscire dalla fila. E chiama il suo superiore.
(12-continua)