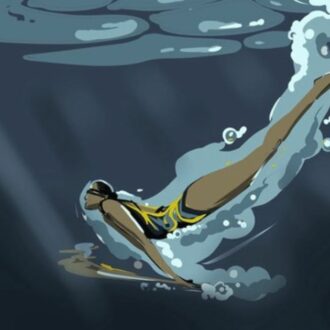Un disco dei Pearl Jam non è mai solo un disco dei Pearl Jam: ogni nuovo lavoro della storica band di Seattle porta con sè una serie di vissuti, ricordi, emozioni che vanno ben oltre la musica, in un continuum tra band e fan che – con questa intensità – appartiene veramente solo a loro. La denuncia sociale, la guerra morale all’America dei Bush e le battaglie (vinte) per l’abbassamento del costo dei biglietti dei loro concerti: in poche parole, unici.
Questo solo per spiegare quanto sia difficile per un recensore (nonché ammiratore) quale il sottoscritto parlare di quello che più che un album è, da 22 anni a questa parte, un evento mondiale: fortuna vuole che i Pearl Jamc’abbiano abituato bene, a prescindere dal fatto che (almeno secondo me) la loro vena creativa si sia evidentemente appannata da “Yield” (1998) in poi, quindi non proprio l’altro ieri. Nel mezzo, tra un ukulele e una chitarra, è stato forse il solo Eddie Vedder a tenere alto il nome del gruppo: tra un capolavoro assoluto come la colonna sonora dello splendido “Into The Wild” (2007) ed il seguente “Ukulele Songs” (2011), anch’esso un buon disco.
Ad aprire il tanto atteso “Lightning Bolt”è la solare “Getaway“, un brano energico in cui il riff quasi danzereccio di base esplode in un ritornello di una bellezza infinita, in cui il buon Vedder guadagna una terza dimensione, che è quella a lui peculiare dell’interpretazione e della profondità, qui devastanti: seguito a ruota dal casino alzato da Gossard McCready, che qui picchiano come assassini. Segue il primo singolo “Mind Your Manners“, che nelle intenzioni rimanda agli episodi più duri dei fu “Versus” e “Vitalogy”: un flash più che passabile per una canzone che non fatica ad entrare in testa ma che non credo ricorderemo da qui ai prossimi anni.
E se “Sirens” (nuovo singolo) non aggiunge moltissimo al repertorio intasato delle ballate dei Pearl Jam, abbiamo comunque a che fare con un pezzo ben sopra le righe (di molto) che ha l’unica colpa implicita di venire dopo le varie “Black“, “Betterman” e “Nothingman“. “My Father’s Son” è invece identificabile nel novero di quelle tracce che, alla lunga, non si fanno odiare ma neanche amare: sospesa tra punk e blues, con un Matt Cameron che memore della reunion dei suoi Soundgarden torna a menare anche nella sua prima occupazione ma che, a conti fatti, riserva poco altro.
“Lightning Bolt” porta con sè il pregiudizio (legittimo) dell’ascoltatore, che qui sa di trovarsi di fronte alla canzone che dà il nome all’intero disco e che quindi ne dovrebbe rappresentare (forse) la massima espressione: non è assolutamente così e anzi il brano parte incendiario, facendo quasi sobbalzare, per finire pompiere. Tutti seduti. La successiva “Infallible” suona quasi come una jam incompiuta, uscita di getto per venire poi incisa così: nuda e cruda, come mamma (e papà) l’hanno fatta. Sarebbe potuta essere un’ottima B-Side e credo poco altro. L’effetto era forse quello di lasciare sospesi nel dubbio e nella diffidenza in attesa della seguente “Pendulum“, verso la quale sarò breve e netto: la miglior composizione dei Pearl Jam dai tempi di “No Code”.
Tutti a casa. Questo disco in soldoni poteva finire qui: ed è in parte così. Ancora anestetizzati dal lavoro maestrale di Vedder specie nel finale del pezzo, ecco che veniamo catapultati nell’allegria intimista di “Swallowed Whole” che scimmiotta non senza una sua dignità le divagazioni soliste del già citato leader, scivolando via lasciando una leggera e piacevole brezza. L’inizio pretenzioso di “Let The Records Play” sfocia anch’esso nell’immaginario lato B cui avremmo relegato una parte consistente di questo album, che finirà sopra la media non certo per la sua omogeneità quanto piuttosto per le sterzate, i picchi improvvisi offerti non senza inanellare qualche passaggio non propriamente limpido e lineare.
E per quanto sia “Sleeping By Myself” che “Yellow Moon” qualcuno pagherebbe oro per scriverle, i Pearl Jam (si sarà capito) c’hanno abituato a ben altro: stesso discorso per l’ultima, definitiva, “FutureDays“, brano dal sapore un pò perbenista ma arrangiato e condotto in porto in un modo tutt’altro che banale, che alla fine pensi “ci sta”. “Lightning Bolt” non è (in ultima analisi) un grido di rabbia e neanche un disco di denuncia, quanto – specie nella sua composizione – l’album che ti aspetti dagli ultimi Pearl Jam: un disco sapiente, comunque genuino, forse una tacca sopra lo scorso “Backspacer” (2009). Si lascia nel complesso ascoltare e, cosa importante, spinge a farsi riprendere più volte: merito di qualche episodio (qualche) nettamente sopra le righe. I Pearl Jam sono tornati, questo non è assolutamente il loro testamento artistico e saperli ancora in giro fa bene: al cuore e all’anima. Vi voglio bene.
Articolo Precedente
‘Io non appartengo più’, Roberto Vecchioni sul ring senza riferimenti

Articolo Successivo
Musica, quattro chiacchiere con Bobo Rondelli