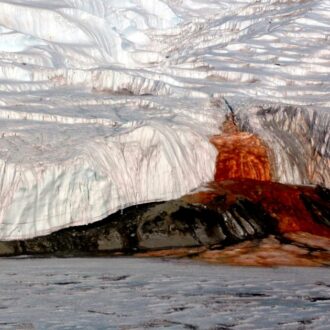Esce oggi sul sito web di alfabeta2 un interessante scritto di Cornelius Castoriadis, pensatore geniale ma poco conosciuto da noi, intitolato La distruzione del senso.
Fondatore di Socialisme ou barbarie, pensatore marginale, radicale e scomodo, anche per la sua abitudine di criticare alcuni mostri sacri della gauche istituzionale – Sartre, ad esempio – o monumenta del pensiero filosofico – Heidegger innanzi tutto – sottolineando come il ruolo ‘intellettuale’ da loro svolto sia stato essenzialmente quello di legittimare le dittature di massa, nazismo e stalinismo, il pensatore greco-francese è in realtà un autore con cui fare i conti e ben a fondo.
Lo scopo del potere, come rileva Castoriadis, non è tanto conquistare un impossibile controllo totale della mente degli esseri umani, quanto sottrarre loro lo strumento principale di autonomia: un linguaggio in grado di produrre senso. Interrompere quella che potrei definire la ‘catena di significazione’.
Di esempi odierni se ne potrebbero fare tantissimi: dalla definizione ‘peace keeping’, che sostituisce ormai quasi sempre quella di guerra, a quella, evidentemente ossimorica, di ‘guerra umanitaria’, a quella di ‘competitività’, che trasforma il significato iniziale di ‘tendere al medesimo scopo’, in un sinonimo di lecita aggressività egoistica.
O anche la costruzione di catene (apparentemente) significanti nelle quali la sostituzione di un sostantivo con un altro – ad esempio quello di azienda, o impresa, con quello di scuola, o sanità pubblica – non si limita alla produzione di monstrua logico-linguistici, ma ha effettive conseguenze sulla nostra vita quotidiana, traducendosi in scuole fatiscenti, che crollano sulla testa di alunni e insegnanti, dove di cultura non c’è più traccia, ma dove si risparmia molto e si digitalizza, o in ospedali inefficienti, sporchi, non attrezzati, ma con il bilancio attivo.
È la: «confusione generale dell’epoca – ci ricorda Castoriadis – nella quale le parole sono utilizzate in qualsiasi modo per dire qualsiasi cosa. In questa situazione, un discorso che mira alla verità diventa, socialmente e sociologicamente, quasi impossibile. (…). La riduzione del linguaggio alla sua sola dimensione di codice – termini che denotano “oggetti” ben distinti, definiti e determinati, e segnali pavloviani che producono dei comportamenti –accompagnata da una manipolazione totalmente arbitraria delle parole che veicolano le significazioni è evidentemente un tentativo di distruzione del linguaggio in quanto tale. (…). L’affermazione paradossale: words mean what I want them to mean non si può realizzare che distruggendo il linguaggio».
Né è estraneo a tutto ciò quel fenomeno d’imperialismo linguistico anglofono, su cui si sofferma a ragione Valerio Magrelli sull’ultimo numero di Reportage, ricordando che il sogno che è alla base del BASIC English (acronimo di ‘Britannico americano scientifico internazionale commerciale’, in tutto circa 600 nomi e non più di 200 verbi) non è tanto quello di una lingua ‘efficiente, o produttiva’, bensì, citando Churchill, quello di un potente strumento di dominio delle menti: «Questi piani offrono guadagni ben migliori che portando via le terre o le provincie agli altri popoli, o schiacciandoli con lo sfruttamento. Gli imperi del futuro sono gli imperi della mente». Orwelliano, se volete…
Da tempo mi capita di sottolineare quanto sia impossibile riuscire a creare, ad immaginare sogni nuovi usando parole vecchie. Ciò che intendo è esattamente quanto sostenuto dal pensatore francese. Da questo punto di vista la poesia ha una funzione ben più sostanziale di quanto immaginato per essa nella tradizionale analisi materialistica e marxista. Perché la poesia affonda le sue lunghe braccia profondamente nell’immaginario – e il potere è anche ‘immaginario’ – essa è l’arte che più di ogni altra si misura con la capacità del linguaggio umano di produrre senso, cioè di restare uno strumento efficace di cambiamento.
Sostenere che uno dei problemi fondamentali che ci troviamo ad affrontare oggi è quello di non avere un nome nuovo per definire ciò che, pur nell’infinita varietà di sfumature, una volta chiamavamo ‘comunismo’, o ‘socialismo’, o rivoluzione, è – imho – ben più che la boutade di un attempato poeta.
Ci ricorda Castoriadis che, o si « conservano delle parole come socialismo, rivoluzione, democrazia con il rischio sicuro di essere confusi» con coloro che combattiamo, o di essere costretti «a trasformare in lunga dissertazione terminologica» ogni frase che pronunciamo; oppure abbandoniamo «pezzo per pezzo, tutto il vocabolario politico e sociale irreversibilmente pervertito», con la possibilità concreta di restare «afoni».
I poeti rischiano così di scoprire per sé un ruolo assai meno marginale di quello che immaginavano, senza – temo – essere preparati a svolgerlo.
Mosche cocchiere che sono scese dal cocchio, inseguendo fumosi simbolismi, proprio quando avrebbero potuto validamente aiutare a condurlo con qualche profitto comune.
Articolo Precedente
Le voci di dentro: Toni Servillo a Parigi

Articolo Successivo
Libri, ‘La consistenza dell’acqua’ di Eleonora Carta: un legal-thriller italiano