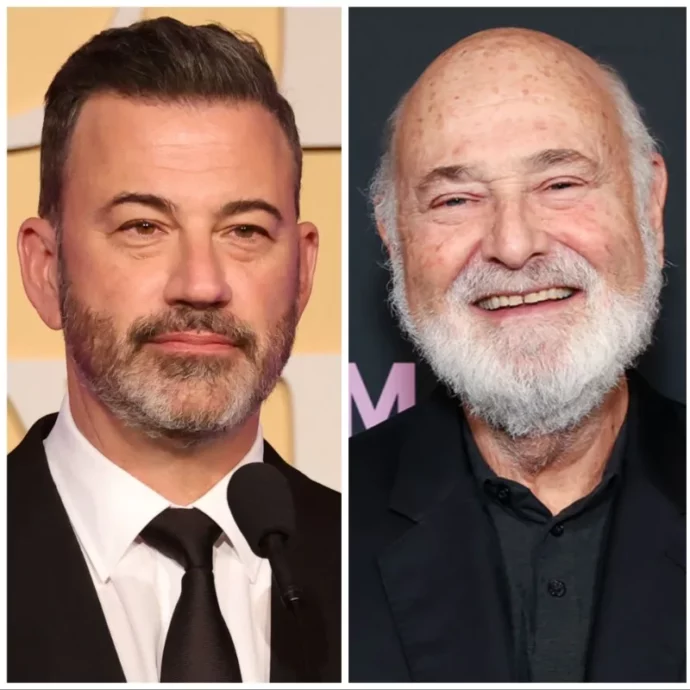Carlo Mazzacurati non c’è più. Una lunga malattia si è portato via uno dei più sereni e delicati registi italiani. Mazzacurati, padovano, aveva 57 anni. Grande e grosso com’era, e da qualche anno a questa parte con una lunga barba, dava l’idea di essere un burbero veneto dalle poche parole. Invece, dietro al ruolo istituzionale di regista, colui che decide e coordina un set, c’era un uomo attento, riflessivo, generoso. La sua poesia in immagini si impone tra gli anni ’80 e ’90. E più che raccontare il Nord-Est – la maggior parte dei suoi film è stata ambientata tra le province del triveneto – Mazzacurati sapeva trasformare in forma cinematografica la levità e la dolcezza dei suoi dropout e perdenti, miserabili di paese nati oltre il tempo massimo della storica commedia all’italiana di Risi e Monicelli.
L’esordio dietro la macchina di presa arriva con Notte italiana nel 1987 (grazie al connubio con Nanni Moretti, produttore con la Sacher), e poi prosegue con una meditata lentezza per altre 19 pellicole, fino all’ultima presentata lo scorso novembre al Torino Film Festival, La sedia della felicità.
In mezzo ci sono tante piccole, preziose gemme artistiche. Intanto s’inventa Antonio Albanese attore drammatico. E lo fa nel 1996 con Vesna va veloce, usando il comico brianzolo come una sorta di contraltare razionale e duro rispetto alla protagonista, un’immigrata cecoslovacca che arriva in Italia a cercare fortuna. Mazzacurati era così: non gli servivano maschere, ma caratteri; non gli servivano bizzarrie ma slittamenti degli interpreti nei personaggi. L’epoca è quella minimale ed intimista degli anni ottanta dei Soldini e Salvatores. Ma mentre gli altri colleghi lavorano chi sul realismo, talvolta fantastico, chi sul kolossal all’italiana, lui rimane ancorato alle storie di provincia, alla descrizione di quelle piccole increspature dell’anima che ne rilevano poi il fondo scuro o un’improvvisa inaspettata bellezza.
Tre i titoli straordinari che vanno assolutamente recuperati per capire la sua poetica. Il primo è Il Toro (1994) quando vince al festival di Venezia il Leone d’Argento per la miglior regia; poi La lingua del santo (2000) e infine L’amore ritrovato (2004). Quasi uno per decennio, perché di più davvero è troppo. Troppa l’attenzione per i propri attori e le proprie storie. Troppo il tempo per confezionarlo bene e di correre, comunque, non ce n’era bisogno. Nei tre film chiave tre coppie d’attori: nel primo Diego/Abatantuono/Roberto Citran, nel secondo ancora Albanese con Fabrizio Bentivoglio, infine Stefano Accorsi/Maya Sansa.
Ne L’amore ritrovato, tratto da uno splendido romanzo di Carlo Cassola ambientato tra l’altro in Toscama negli anni trenta, Mazzacurati raggiunge l’apice dell’illustrazione di una coppia di amanti in tutto il loro dolente e necessario realismo: mai spettacolarizzazione dei sentimenti o dei gesti, ma scavo totalizzante nell’anima dei suoi amati personaggi.
Caratteri che non espone mai al ridicolo anche quando sceglie un remake difficile di un film di Comencini, A cavallo della tigre (2002); o quando si sfoga con il bel mondo del cinema e forza la mano della commedia con La Passione (2010). Poi ancora, per capire la dolce poesia di Mazzacurati guardatevi un paio dei suoi documentari: senz’altro il trittico su Meneghello, Zanzotto e Rigoni Stern, ma soprattutto Sei Venezia (2010): dove la gente comune nei suoi limiti e bizzarrie dell’anima diventano protagonisti ‘semplici’ della città più ‘cartolinizzata’ al mondo
Forte il sodalizio nella scrittura con Umberto Contarello (oggi cosceneggiatore con Sorrentino de “La Grande Bellezza”) e ancor più forte il legame con Bologna: studi al Dams a cavallo degli anni settanta/ottanta e da tre anni presidente della neonata Fondazione Cineteca. Senza dimenticare il divertimento nell’apparire nei film di Nanni Moretti: ricordiamolo quando in Caro Diario sul letto, piange e subisce la lettura di una recensione del Manifesto di “Harry pioggia di sangue”.