Prevenzione, i limiti della mammografia nella diagnosi del tumore al seno
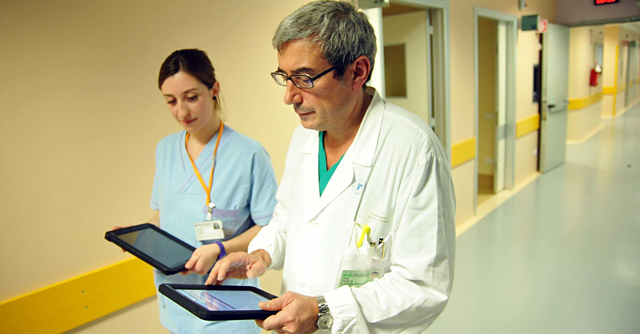
Un recente studio del British Medical Journal mette in dubbio il fatto che lo strumento sia efficace. La ricerca prende in considerazione 90mila donne e, pur con alcuni limiti, svela come, in un caso su cinque, l'accertamento del cancro si riveli errato
La mammografia è considerata da tempo l’esame strumentale d’eccellenza per quanto riguarda la diagnosi precoce dei tumori al seno. Questo ci viene confermato dal fatto che, per esempio, in Italia circa il 70% delle donne tra 50 e i 69 anni vengono invitate a sottoporsi allo screening mammografico nazionale biennale. Ma negli ultimi anni sono stati pubblicati degli studi che mettono in dubbio l’efficacia di questo esame, attraverso la diagnosi precoce, nel ridurre la mortalità in seguito al tumore al seno. L’ultimo lavoro in questa direzione è uno studio longitudinale canadese che ha preso in considerazione una vasta popolazione: 90mila donne di età compresa tra i 40 e i 59 anni, seguite per 25 anni, pubblicato sul British Medical Journal, una autorevole rivista medica inglese.
Secondo gli autori l’utilizzo della mammografia come unico strumento diagnostico, non riduce la mortalità per tumore al seno se confrontata con la palpazione. Non solo: il rischio di sovradiagnosi, quindi l’identificazione di masse tumorali che per la dimensione non permettono di dire se si svilupperanno in qualcosa di maligno o meno, obbligano comunque a una forma di cura che trova l’indicazione proprio in questa incertezza. Per una donna su cinque, secondo lo studio, la diagnosi di tumore è errata, ma il trattamento, farmacologico o chirurgico che sia, si rende un passaggio obbligato. Si tratta di uno studio molto interessante, se non fosse altro che per l’ampio numero di donne coinvolte, che ha però destato perplessità nella comunità scientifica per via di alcuni limiti metodologici che riducono l’importanza delle conclusioni alle quali giungono i ricercatori. Vediamone alcuni.
Un primo limite evidenziato è relativo al considerare la mammografia come unico esame radiologico di prevenzione in donne tra i 40 e i 49 anni. Questa modalità di studio, se utilizzata come unico strumento diagnostico, non viene ritenuta corretta per via della densità del tessuto ghiandolare, tipico di questa età, che rende più difficile la lettura mammografica. Lo screening in questa età dovrebbe, inoltre, tenere conto di fattori quali la familiarità, il non aver avuto figli, l’aver avuto la prima gravidanza in età tardiva, l’aver avuto precocemente la prima mestruazione e la menopausa precoce, che aumentano la probabilità di sviluppare un tumore al seno e quindi la necessità di una maggiore attenzione alla diagnosi precoce.
Altro limite individuato è relativo al parametro di valutazione scelto per valutare l’efficacia dello screening: quello della sopravvivenza. Questo parametro rischia di essere confusivo in uno studio che viene portato avanti per 25 anni, periodo di vita durante il quale possono intervenire avvenimenti diversi che conducono alla morte, che non sia il tumore stesso.
Esiste, inoltre, una differenza di precisione tra gli strumenti diagnostici impiegati nello studio e quelli attualmente utilizzati, la mammografia digitale in modo particolare permette di ridurre le radiazioni utilizzate a fronte di una eccellente qualità dell’immagine.
Insomma uno studio controverso, che lascia aperte alcune perplessità metodologiche, ma nello stesso tempo fa riflettere sulla efficacia della mammografia che ancora oggi rappresenta il più accurato esame strumentale per la diagnostica precoce del tumore alla mammella. Tumore che non dobbiamo dimenticare essere la prima causa di morte per le donne, con tutte le preoccupazioni e paure che questo comporta. Il buono di questo studio è che spingerà i ricercatori ad approfondire ulteriormente questo tema con l’obiettivo di giungere ad una maggiore chiarezza su un argomento così emotivamente importante per la salute delle donne.
Roberta Rossi è presidente della Federazione italiana di sessuologia scientifica
Leggi anche: La risposta della Società italiana di radiologia medica