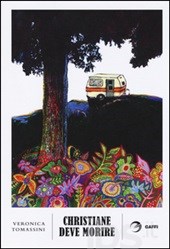 La signorina Varrani, la redaktora, come la chiamano al campo rom di Siracusa, è una giornalista di un quotidiano locale. Il suo capo, un omuncolo petulante di nessun valore, la incalza ogni giorno perché vuole che riporti dal campo uno scoop. Ma dal campo rom nessuna notizia è degna di un titolo in prima pagina, c’è solo il consueto traffico di personaggi fuori dal mondo: Rusca detta la tigre, il capo Skender che dice di aver suonato un tempo con Kusturica, la vecchia Zofia, sua madre, rauca e lagnosa, la sensuale Rusca (“la vita che ti cerca”).
La signorina Varrani, la redaktora, come la chiamano al campo rom di Siracusa, è una giornalista di un quotidiano locale. Il suo capo, un omuncolo petulante di nessun valore, la incalza ogni giorno perché vuole che riporti dal campo uno scoop. Ma dal campo rom nessuna notizia è degna di un titolo in prima pagina, c’è solo il consueto traffico di personaggi fuori dal mondo: Rusca detta la tigre, il capo Skender che dice di aver suonato un tempo con Kusturica, la vecchia Zofia, sua madre, rauca e lagnosa, la sensuale Rusca (“la vita che ti cerca”).
La Varrani segue un istinto che da sempre la porta a unirsi agli ultimi, ai ripudiati del mondo. Da quando, bambina di nove anni, si imbatte nel libro che le muta la percezione della realtà: la storia di Christiane Felscherinow raccontata in Christiane F. Noi, i ragazzi dello Zoo di Berlino. Christiane che “le batteva nelle tempie”, la vita di provincia in un decennio come gli anni Ottanta “in quell’albume periferico, dove i sogni perdevano prestanza”, e poi più tardi il matrimonio, il marito che la lascia per una che a letto ci sa fare meglio di lei, il rimpianto corrosivo nello scorgere la quotidianità degli altri, la pace muta delle vite normali, e infine la presa d’atto, amara e ineluttabile, della distanza che corre tra sé e gli altri.
Questo è Christiane deve morire, il secondo romanzo di Veronica Tomassini, uscito per Gaffi Editore a quattro anni di distanza da Sangue di cane (Laurana), che a sua volta fu uno degli esordi più luminosi e discussi del 2010.
Un libro che, non a caso, ha visto la luce dopo un’avventurosa vicenda editoriale. Veronica Tomassini scrive storie forti, di reietti e di provincia, temi che sono cari all’editoria contemporanea solo se declinati in una dimensione consolatoria. Ma gli emarginati di Veronica Tomassini non sono eroi del riscatto, né la provincia in cui si muovono è quella vetrinetta distintiva che ha fatto le fortune di tanti libriccini italiani. La sua provincia è un buco nero, è un urto di vomito, è verità senza orpelli.
La verità, d’altro canto, è il tratto distintivo, il credo assoluto della sua scrittura. Una scrittura di fronte alla quale, da sempre, riesco a registrare solo due specie di giudizi, due modulazioni agli opposti: da una parte approvazioni senza riserve (è la parte che mi sono scelto), dall’altra ostilità, malevolenza, sospetto. Cioè, quello che generalmente accade in qualsiasi ecosistema nel momento in cui appare un organismo sconosciuto.
L’opera di Veronica Tomassini sta alla contemporaneità editoriale italiana come lo strazio di un allarme nell’oziosa quiete notturna. Nell’andamento a scatti che contraddistingue questo romanzo, uno sbalzo continuo dal presente al passato, da un campo rom ai tetti di eternit della periferia di un tempo andato (“non era la giovinezza, erano deserti” si legge in un passaggio bellissimo del libro), ci sono idee, vita, sofferenza. C’è soprattutto un dono, quello – per dirla con De André – di saper “consegnare alla morte una goccia di splendore”.
Articolo Precedente
Medio Oriente: realtà esplosiva, parole calibrate

Articolo Successivo
Illustrazioni, vincere la scommessa








