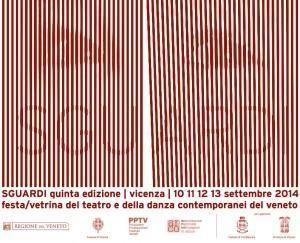 C’è il vedere e c’è il guardare. Andare a fondo, ispezionare, controllare. Lo sguardo indaga, entra profondo, scava, scandaglia. L’idea è venuta cinque anni fa al PPTV, i Produttori Professionali Teatrali Veneti (diretti da Labros Mangheras della compagnia Tib di Belluno), che hanno imbastito il festival “Sguardi”, la vetrina itinerante del teatro veneto, che si è svolto a settembre. Partendo da Padova, passando da Belluno e Venezia, fino a Verona e quest’anno Vicenza. Per il 2015 si ipotizza la soluzione Schio. Quattro giorni, una trentina di spettatori, tra teatro e danza. Poche altre regioni, siamo a conoscenza di Lombardia, Liguria e da quest’anno Calabria, organizzano simili vetrine per promuovere il teatro delle compagnie residenti.
C’è il vedere e c’è il guardare. Andare a fondo, ispezionare, controllare. Lo sguardo indaga, entra profondo, scava, scandaglia. L’idea è venuta cinque anni fa al PPTV, i Produttori Professionali Teatrali Veneti (diretti da Labros Mangheras della compagnia Tib di Belluno), che hanno imbastito il festival “Sguardi”, la vetrina itinerante del teatro veneto, che si è svolto a settembre. Partendo da Padova, passando da Belluno e Venezia, fino a Verona e quest’anno Vicenza. Per il 2015 si ipotizza la soluzione Schio. Quattro giorni, una trentina di spettatori, tra teatro e danza. Poche altre regioni, siamo a conoscenza di Lombardia, Liguria e da quest’anno Calabria, organizzano simili vetrine per promuovere il teatro delle compagnie residenti.
Abbiamo scelto quattro spettacoli, novità importanti, germi in divenire, azioni da sottolineare. La città sulle palafitte ci viene raccontata da Juliette Fabre, attrice francese che ha studiato tra gondole e calli, che con l’uso di un violoncello che se ne sta impiccato al centro della scena e reti da pescatori apostolici che scendono dall’alto, in ‘Ballata per Venezia’ poetico canto d’amore e d’odio, viscerale, carnale quasi goethiano. Il rumore di acqua accompagna la scadenza delle note perché “Venezia non si racconta, la si passeggia”. Tutt’altro che affresco da cartolina patinata, né Casanova né Carnevale; un catino-bacinella è la laguna che tutto attrae come calamita, in un’atmosfera tra antiche leggende in una miscela arcaica e moderna che si perde nelle notte dei tempi. Le città di mare andrebbero viste dal mare ma Venezia non è una città di mare ma una città sul mare. “Venezia esiste?” è la domanda esistenziale che gira e rigira tra le mani, le palafitte come stampelle per non cadere, per non sprofondare, per non far inghiottire tutta quella grande bellezza.
Fieri i Trepieds che con ‘Vizi in virtù’ ci portano, con semplicità e piccoli gesti leggeri, dentro quel mondo fumoso e rarefatto, polveroso in bianco e nero, delle sale da ballo durante il conflitto bellico. Teatro danza ben fatto questo: un uomo e due donne s’intrecciano in un tango seduttivo e affilato, tra chanson francesi mentre le valigie che si aprono sul boccascena hanno il sapore della deportazione e la maschera a gas ricorda la guerra da fuggire anche solo con l’immaginazione.
La parabola di un amore cresce e decade nel corso di ‘Tomato soap’, rosso come la passione prima, il sangue poi. Il “soap” ricorda le telenovelas, le favole rosa da libretti Harmony da “vissero felici e contenti” che nella vita poche volte diventano realtà. I Manimotò utilizzano due grandi pupazzi maneggiandoli entrandoci dentro. Lui e lei sono due fantocci, grandi, grossi, sconclusionati (l’uso delle maschere in Italia è stato ben sviluppato da Zaches e Teatrino Giullare, a livello europeo da Familie Floz), deformi e mostruosi. Il mondo d’idillio costruito con una narrazione senza parole, di piccoli gesti colmi d’amore e affetto dolcissimo vengono dissolti da, prima insignificanti poi sempre più frequenti, azioni aggressive messe in atto dall’uomo verso la donna, alle quali sempre seguono pentimenti, lacrime e rose aspettando la volta successiva.
Stessa tematica affrontata anche in ‘Parliamo d’altro’ dove il confronto tra una madre ed una figlia, e sullo sfondo la violenza subita dalle donne, mette in evidenza come il fil rouge tra l’educazione familiare, appresa per osmosi e respirata all’interno delle quattro mura domestiche, sia il primo termine di paragone degli adolescenti verso il mondo esterno. Una madre picchiata non sarà in grado di proteggere una figlia, non tanto fisicamente, ma con i comportamenti che risulteranno essere omertosi minimizzando l’accaduto. Nel limbo tra il detto e il non detto si annusa una violenza psicologica strisciante, prima che di lividi, e il groviglio di sedie accatastate in scena esalta la ragnatela di minacce, dipendenza e paura al quale è difficile sottrarsi. La figlia viene inghiottita nello stesso vortice di prevaricazione e controllo maschile di fronte al quale la madre non ha avuto la forza di ribellarsi. Le colpe delle madri ricadono sulle figlie.
Articolo Precedente
Musica indie, lettera aperta a Sara Mazo degli Scisma: torna da noi!

Articolo Successivo
UB Underground, Trainspotting in salsa mongola








