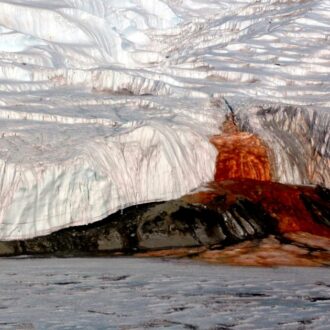Hanno cercato di renderle invisibili, sfigurandole con l’acido, cercando così di umiliarle e piegarle per un amore non ricambiato, un affronto, un tradimento, lasciando sui loro corpi cicatrici indelebili. Invece, per alcune di queste donne le cicatrici hanno cancellato via i loro tratti ma non la loro essenza, rendendole ancora più visibili e importanti di prima. E’ con questo gioco di parole “In/visibile” che si presenta il progetto fotografico di Ann-Christine Woehrl, in mostra per due week-end (dal 17 al 19 e dal 24 al 26 ottobre) a Lodi, in occasione del Festival della Fotografia Etica.
Certo, il suo è un progetto che fa gelare il sangue. Provate a scorrerlo qui, sul suo sito, e provate a dire che pagina dopo pagina riuscite a far correre via le immagini senza problemi. Bene, aggiungete il fatto che Ann-Christine ha ripreso solo 48 donne mentre si contano 1500 casi l’anno di aggressione con acido a livello mondiale, 1500 donne sopravvissute che hanno avuto il coraggio di denunciare a cui si devono aggiungere tutte quelle che non denunciano. Quelle ritratte da Ann-Christine fanno parte delle donne che hanno reagito; donne che nonostante tutto, che sia la dipendenza economica dal marito o dalla famiglia, sono riuscite ad accettarsi, e che sono ritornate alla vita quotidiana sopportando gli sguardi imbarazzati della gente.
E se ogni cicatrice corrisponde ad una ferita ogni sguardo la riapre. Eppure per il suo progetto Ann-Christine ci presenta donne che sembrano non curarsi più dell’opinione della gente. A Lodi, in particolare, ci saranno le storie di quattro donne provenienti da quattro stati differenti: Neehaari dall’India, Flavia dall’Uganda, Nusrat dal Pakistan e Renuka dal Nepal. Scatti quotidiani che raccontano la loro volontà di sopravvivere e tornare alla normalità e che va oltre lo stereotipo che la società ha cucito loro addosso, rendendole nuovamente visibili

agli occhi del mondo.
Storia di reazione e denuncia anche quella del progetto di Meeri Koutaniemi che in “Taken” riporta il dramma dell’infibulazione. “Per la tradizione, gli organi genitali femminili sono impuri – racconta lei stessa in un’intervista – e l’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che ci siano più di 140 milioni di donne vittime di mutilazione nel mondo”. “Nonostante questa pratica – aggiunge- sia stata dichiarata illegale in Kenya è eseguita in ventotto paesi del mondo e rappresenta ancora un’importante tradizione tra le tribù come quella dei Masai”. Nei suoi scatti, in bianco nero, racconta questo assurdo rito di discriminazione verso le donne, bambini ma anche verso adolescenti.
Una violenza diversa, non più fisica ma psicologica, di libertà negata, è quella di “Beautiful Child” di Laerke Posselt. Si tratta di un reportage sui concorsi di bellezza per bambini negli Stati Uniti dove la Posselt segue nella loro quotidianità Sophia ed Evie, due concorrenti di soli due anni di età. Due bambine che sembrano e si comportano da già adolescenti, che si atteggiano per vincere una corona e una fascia, e i cui genitori non capiscono come in questo modo si enfatizzi l’aspetto sessuale, si commercializzi l’infanzia e si interferisca con la

salute mentale e l’immagine di sé che hanno le giovani bambine coinvolte.
Si parla di immagine, ma per una storia ben diversa nel progetto di Olivia Arthur che in “Jeddah Diary” esplora il controverso e complicato mondo delle donne Saudite, in bilico tra modernità e tradizione, tra ciò che è consentito o meno vedere. Invitata in Arabia per insegnare in uno workshop per fotografe locali, Olivia ha in seguito stretto amicizie ed è ritornata nel paese per fotografare diverse volte. “Ho provato – dice – a ricostruire la mia interpretazione di questa bolla in cui le ragazze vivono e le rigide regole a cui devono attenersi. Ma più aggiungevo elementi e meno mi sembrava di capire perché le regole cambiavano da una situazione all’altra e alcune cose iniziavano a sembrare contraddittorie”. In un’intervista a Vice, infatti, preciserà. “E’ stata la cosa più difficile che io abbia mai provato a fare ma ho comunque cercato di fare vedere che in Arabia Saudita ci sono mondi diversi”.
Una contraddizione che ha un unico comune denominatore: la necessità di non mostrare i volti o, comunque, di oscurarli. In questo modo è ancora più evidente questa realtà difficile da comprendere, dove le ragazze, le mogli e le madri si dividono tra la tradizione e un desiderio di occidentalizzazione che non va oltre le mura di casa. E la voglia di libertà e di occidentalizzazione ritorna anche in “I Just Want to Dunk” di Jan Grarup che racconta la storia di un gruppo di giovani donne di Mogadishucolpevoli di aver una passione troppo

occidentale, il basket, considerato lo sport del nemico (l’America). La squadra di Suwey, giovane capitano di 19 anni, però non ci sta e continua ad allenarsi sui campi da basket, protetta bucati da proiettili e da uomini armati pagati dall’associazione per il basket somala per controllarle e proteggerle dagli attacchi dei nemici. Cinque storie che raccontano cinque differenti modi di esercitare violenza con l’obiettivo di alzare il sipario su realtà, spesso drammatiche, che coinvolgono molte donne in tutto il mondo.
Articolo Precedente
Capitale della cultura 2019, vince Matera. Il presidente: “La gioia è di tutta la Basilicata”

Articolo Successivo
Gianni Morandi vs Francesco De Gregori: quando la sincerità è la chiave del successo