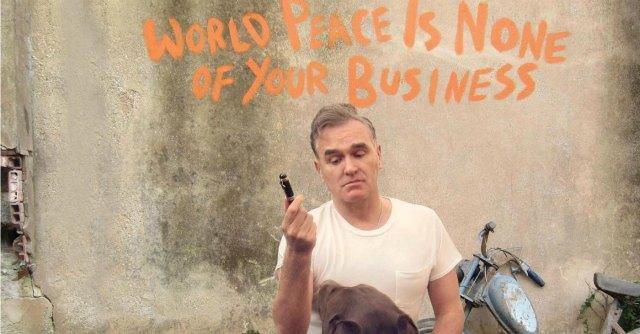Nick Mulvey è una delle meravigliose rivelazioni dell’anno e la nomina del suo primo lavoro solistico – “First Mind” – per il Mercury Prize è un’ulteriore conferma del meritato successo che il trentenne musicista di Cambridge sta raccogliendo in questo periodo. Molte delle sue date registrano il tutto esaurito e non poteva andare diversamente allo Shepherd’s Bush Empire di Londra.
Proprio come Peter Gabriel con i Genesis e Mauro Pagani con la PFM – tanto per citare due esempi estremamente conosciuti – anche Mulvey abbandona i suoi Portico Quartet nel momento di maggior successo. All’epoca del quartetto Mulvey suonava lo hang, strumento che ha caratterizzato il sound della band tanto quanto l’elegante ricerca melodica e le digressioni improvvisative. Sarà il secondo album in studio, “Isla”, uscito per l’etichetta di Peter Gabriel e prodotto da John Leckie (Radiohead e Pink Floyd, per citare due nomi) a portare il quartetto al meritato successo e a sancire la dipartita di Mulvey. Dallo hang nei Portico Quartet alla chitarra di questa nuova avventura solistica, Nick Mulvey si prepara ad intraprendere un percorso dove l’esigenza di mettere in musica brani lasciati all’angolo da anni, ha vinto sulla tranquillità di un percorso già tracciato e sicuro. “First Mind” è uno dei dischi d’esordio più belli dell’anno e dal vivo i brani splendono ancora di più, uno dei tanti esempi è dato da “Nitrus” – canzone conclusiva del concerto allo Shepherd’s Bush Empire – che presenta variazioni rispetto alla versione in studio.
È estremamente interessante comprendere come Mulvey attinga a diverse tradizioni musicali piegando alle proprie esigenze alcune caratteristiche: la sua tecnica chitarristica risente della breve permanenza a Cuba, oltre che dell’influenza del suo insegnante zimbawese Chartwell Dutiro. Steve Reich ha indubbiamente influenzato l’approccio compositivo di Mulvey, molti brani infatti sembrano nati dal principio della ripetizione di uno schema fondante: “The Trellis”, “Ailsa Craig”, “April” e la stessa title-track sono gli esempi più lampanti. Dal vivo le canzoni appena citate sembrano splendere di nuova luce grazie all’apporto dato dalle tastiere, il contrabbasso di Milo Fitzpatrick (Portico Quartet) e le percussioni; strumenti che in più passaggi danno vita ad ipnotiche digressioni all’interno dei brani, come nel caso di “First Mind”.
Nick Mulvey ancora prima di essere un chitarrista è un percussionista e questo si riflette negli arrangiamenti dei brani che presentano sempre una struttura corposa ed articolata, diventando una sorta di rete sonora sulla quale si adagia il cantato del musicista. I suoi studi in etnomusicologia hanno dato frutti eccellenti permettendogli di sviluppare un sound peculiare, articolato nella sua semplicità, mentre i testi sono genuini e mai banali, con brani di notevole bellezza come la nostalgica “Cucurucu” – in parte ispirata alla poesia “Piano” di David Herbert Lawrence – o “Fever to the Form”, brano legato al periodo di abbandono dei Portico Quartet, che porta alla luce proprio la necessità di passare dal caos all’ordine interiore, attraverso la musica (“I will follow the feeling / and sing fever to the form / all my fever to the form”).
A fine concerto l’ex Portico Quartet non fa mancare una cover di Drake, “Hold on, We’re Going Home”, che rispetto all’originale sembra avere colori pastello, quasi rarefatti. La bellezza di questo concerto è la stessa che c’è dietro ogni singola canzone dell’album, e la si può percepire immediatamente perché si viene catturati da un candore primordiale e un senso di nuovo che affascina. Quasi ogni brano è avvolto da una continuo rimando alla positività, che sia la delicatezza di “Nitrus” (“I’ve seen a day / with no more to pay / when trouble came in droves but trouble drove away”) o la serenità di “Meet Me There (“The only way to hold on is keep letting go / Oh there’s a field meet me there / Out beyond rightness and wrong, meet me there”). Controcorrente sembra andare “I Don’t Want to Go Home” che con il suo arpeggio semplicissimo e i perfetti contrasti utilizzati nel testo, delinea una storia d’amore finita: “And in the fire I find the snow / illusion come illusion go”.