Poesia. Duetti #05: Elisa Biagini e Adriano Padua: la parola tra verso e ritmo
All’inizio degli anni Cinquanta i tre poeti brasiliani del gruppo Noigandres (Haroldo e Augusto De Campos e Decio Pignatari) nel loro Plano Piloto para poesia concreta dichiaravano ufficialmente finita l’epoca del verso in poesia.Detta così, la cosa può sembrare una sorta di boutade, ma alle radici della poesia, che è alle origini arte orale e non scritta e si basa non su questo, o quell’aspetto grafico del linguaggio, ma sul suo ritmo e sulle sue qualità sonore, non c’è alcuna necessità del ‘verso’.
Chiunque abbia visto un qualsiasi manoscritto trobadorico comprenderà immediatamente ciò a cui mi riferisco: a separare le unità metriche sta solo un punto, non c’è alcuna necessità di andare a capo: per chi deve eseguire quello scritto ciò che conta davvero sono le posizioni degli accenti.
Dunque il ‘verso’, almeno per come lo si intende da quando la poesia si è consegnata alle pagine dei libri – e cioè come un ‘andare a capo’ – non è cosa che riguardi necessariamente la poesia (così come la rima, ahimè, che è invenzione della prosa e del suo cursus, ben prima che della poesia). C’è una distanza immensa tra il ‘fiore inverso’ di Raimbaut d’Aurenga, allocato nella voce e nel liuto del suo autore, e l’affermazione celeberrima che ‘il verso è tutto’: nessuno più silente dei cosiddetti maudit francesi, come notava Fortini in un suo magistrale saggio dedicato all’oralità in poesia.
Se mi attardo a fare queste considerazioni è perché ho davanti due ottimi libri di poesia contemporanea che sembrano riproporre, qui ed ora, i due capi divaricati della questione.
Da una crepa (Einaudi, 2014) di Elisa Biagini è certamente un esercizio raffinatissimo intorno a tutte le potenzialità del verso scritto, nel suo frantumarsi in unità sempre più piccole, ma sempre più ‘significanti’, con il risultato di fare del verso in sé la principale scommessa formale del volume. I versi di Biagini sono come schegge, frammenti taglienti di un discorso che come sempre ha al centro il corpo, in questo caso anche il corpo del testo, quello degli scritti di Celan e Dickinson con cui l’autrice fiorentina fittamente interagisce.
Ciò che nasce dalla crepa è dunque un dialogo, quasi che la crepa dell’io di cui dice il titolo fosse smagliatura della rete che si ripete ad ogni a capo, quasi che ogni verso fosse filo del medesimo tessuto, sempre da riannodare: «Sullo spigolo del / congedo mi sbuccio /il respirare. / il fiato / rammendato col / filo più scuro: / d’abbandono». Per dirla con le parole di Biagini il suo è davvero uno scrivere «ai bordi», carezzando i lembi di una ferita che si sostituisce ostinatamente all’io lirico.
Il verso è invece totalmente annullato nei blocchi compatti proposti da Adriano Padua nel suo Schema (d’if, 2012). Vittima di una sorta di embricazione il testo si agglutina, copre ogni spazio, l’unico modo di accedere al suo senso è eseguirlo, ridotto com’è a puro cursus. Lo schema – cui allude il titolo –sembra essere allora quasi una mappa per ricostruire ciò che il testo poetico era prima che noi lo pronunziassimo, affidandolo alla catastrofe del suono che non è mai possibile ripetere, che è sempre diverso ogni volta che eseguiamo il medesimo ‘verso’: «Io vorrei costruire la parte del nome, fatta d’acqua». Più che a prosa poetica qui siamo di fronte alle rovine terremotate di ciò che una volta era lirica. Nonostante lo ‘schema’ (il testo scritto) ripeta gli ictus, il reale li torce, il fiato li sporca, rendendoli ogni volta diversi. Ciò che resta sulla pagina è residuo e non radice, significante che viene dopo il significato, polvere di suono, come quella che Duchamp fotografò sul suo Grande vetro. 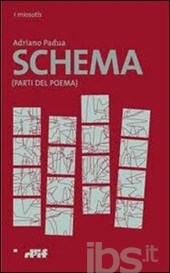
Là dove la ‘crepa’ apre, lo ‘schema’ racchiude, anche se lo scopo sembra il medesimo (il senso), anche se la materia – liquida o cristallina che sia – è comunque il corpo: quello della poesia, quello del respiro e quello del poeta.
Ciò che qui importa, comunque, è che entrambi questi testi testimoniano com’è proprio attorno al ‘verso’ e alla sua lotta con e contro il ritmo che si gioca una partita importante della poesia contemporanea.
Non tanto per scegliere l’una o l’altra strada, quanto per domandarsi cosa mai potrà nascere nel futuro da una poesia capace oggi di far convivere e in qualche modo – paradossalmente – dialogare due esperienze poetiche così distanti.




