Leibniz e il mito del capitale
Il male, poiché possibile, è consustanziale a qualsiasi realtà. L’imperfezione della creatura precede il peccato: prima ancora di trasgredire la legge, la creatura è limitata. Uno sguardo manicheo si domanderebbe: «Salvare o condannare apoditticamente?». Una terza via, passando per il riconoscimento dell’imperfezione come singolarità vivente, è la comprensione esplorante le dinamiche del reale. Il contesto è la leibniziana teodicea, la giustificazione – attraverso una visione polifonica dell’universo – dell’operato di Dio rispetto alla sussistenza del male.
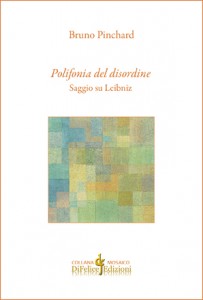 La polifonia non è un aggregato, un caos senza unità. Al contrario, propone un’unità nella diversità, è un insieme armonico di molti suoni. Questo concetto, versato in ontologia, è l’idea leibniziana di mondo. La polifonia è il principio che fa convergere le infinite singolarità. Il risultato è il mondo, da non intendere come rigida sostanza, ma come risultato possibile degli infiniti possibili. Quella elaborata da Pinchard – attraverso Leibniz – è una metafisica della contingenza che, al di là delle apparenze che accecano l’occhio pessimista, afferma non esservi caos nelle cose. Bisogna emancipare lo sguardo dalla massa della cosa, entrarvi dentro e scoprire la solidarietà dell’esistente «al di là del bene e del male»: ciò che appare tragico è solo la cresta dell’onda di variazioni infinitesimali nell’ontologia soggiacente l’evento drammatico; una macroscopica colpa si rivela conforme all’ordine microscopico. Il mondo è un continuo. La sostanza – aristotelicamente parlando – non è niente senza accidente.
La polifonia non è un aggregato, un caos senza unità. Al contrario, propone un’unità nella diversità, è un insieme armonico di molti suoni. Questo concetto, versato in ontologia, è l’idea leibniziana di mondo. La polifonia è il principio che fa convergere le infinite singolarità. Il risultato è il mondo, da non intendere come rigida sostanza, ma come risultato possibile degli infiniti possibili. Quella elaborata da Pinchard – attraverso Leibniz – è una metafisica della contingenza che, al di là delle apparenze che accecano l’occhio pessimista, afferma non esservi caos nelle cose. Bisogna emancipare lo sguardo dalla massa della cosa, entrarvi dentro e scoprire la solidarietà dell’esistente «al di là del bene e del male»: ciò che appare tragico è solo la cresta dell’onda di variazioni infinitesimali nell’ontologia soggiacente l’evento drammatico; una macroscopica colpa si rivela conforme all’ordine microscopico. Il mondo è un continuo. La sostanza – aristotelicamente parlando – non è niente senza accidente.
«I disordini sono finiti nell’ordine», afferma Leibniz, facendo anche leva sul concetto di vinculum substantiale, un legame che assicura un certo grado di unità ai corpi e alla materia. L’ontologico vinculum substantiale è, storicamente, il mito. Il mito è una visione del mondo, un modo per tenere uniti fatti contingenti in un continuum chiamato «storia», «tradizione». Ogni Weltanschauung è mito. Il mito del contemporaneo, secondo Pinchard, è il capitale, frutto avvelenato del regime della produzione, visione totalizzante che – anche se il plusvalore fosse disvalore – genera un senso. Come Leibniz scriveva una teodicea, l’uomo contemporaneo dovrebbe autoimporsi l’imperativo categorico di una mitodicea: una discussione sul mito.
La libertà permessa dalla metafisica del contingente è un appello a riconsiderare il capitale: se il vinculum substantiale non è una prigione dell’essere, perché il mito del capitale deve essere la gabbia del contemporaneo? Se persino l’ontologia è libertà, come può la storia non essere campo di emancipazione e cambiamento?



Resta in contatto con la community de Il Fatto Quotidiano