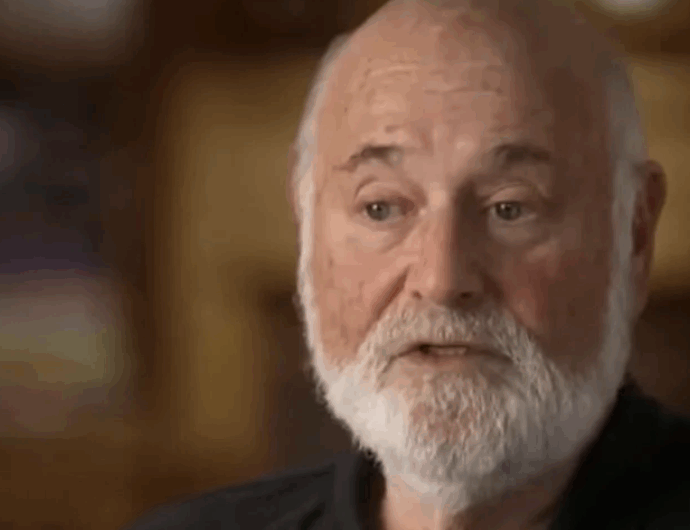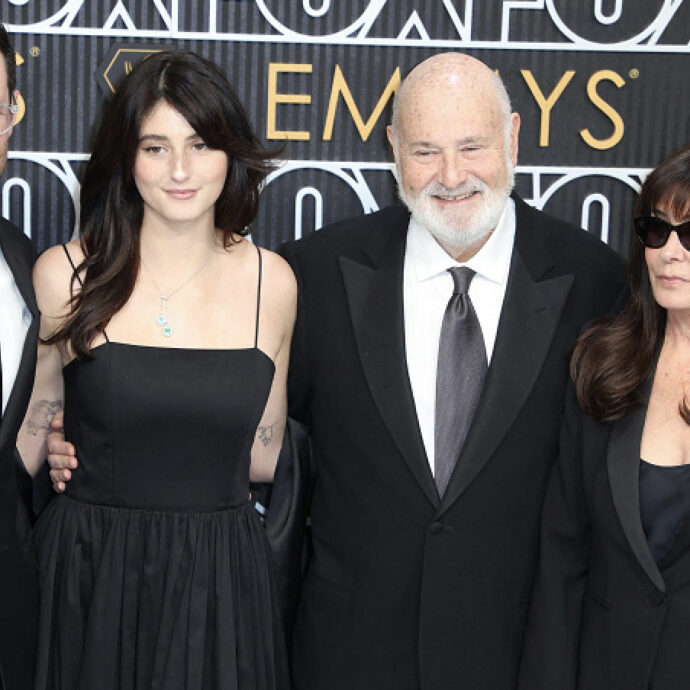Big Eyes che suona Big Lies, a tutti gli effetti. Eppure, nella filmografia di Tim Burton, pochi film come questo hanno uno scarto così sottile tra Realtà e Finzione. Perché la “grande menzogna” su cui si basa la pellicola è una storia vera, una delle più clamorose frodi nella storia dell’arte, con tanto di protagonista femminile tuttora vivente (86enne), amica da anni del regista. Ed è plausibile che quest’amicizia longeva abbia indotto uno dei più grandi visionari di Hollywood a intraprendere il suo nuovo “viaggio cinematografico” in uno straordinario fatto di cronaca situato a cavallo tra la vibrante San Francisco di fine Fifties e le Hawaii di metà Sixties.
È allora che il presunto pittore Walter Keane esplose in un successo mediatico e commerciale senza precedenti producendo una serie di quadri rappresentanti bambini con occhi enormi. In realtà, mano e pennello erano di sua moglie Margaret – l’unica artista e pittrice della famiglia – ma l’uomo affetto da evidente mitomania e schizofrenia, la teneva reclusa a dipingere in casa, nascondendo al mondo la verità e convincendo la donna che così “era meglio per tutti, poiché una donna pittrice non avrebbe mai venduto quanto un uomo”.
Con un plot tanto affascinante per una realtà che supera la finzione in quanto ad elementi di follia, Burton aveva a disposizione una materia adatta al suo sguardo, che tuttavia ha resistito a spingere in quei territori di fantasmagoria di cui lo sappiamo maestro. Appoggiato sul talento dei due protagonisti Amy Adams e Christoph Waltz, Big Eyes ha una struttura narrativa classica, che omaggia la mescolanza tra commedia e psicodramma hollywoodiani dell’epoca, con voluti riferimenti ad alcuni sommi colleghi quali Hitchcock (la Margareth della sempre ottima Amy Adams ammicca fisicamente non poco alla Doris Day de L’uomo che sapeva troppo, 1956) e Kubrick (la sequenza delle minacce di Walter alla moglie attraverso il buco della serratura della porta è un chiaro omaggio a Shining).
Se la prima parte del film potrebbe far presagire a un crescendo estremo con esiti, appunto, alla Hitchcock, è proprio la ricaduta della climax a convincere di meno, facendo emergere tutti i limiti di un Tim Burton “imbrigliato” nelle storie realmente accadute. Migliori, infatti, sono i momenti in cui a farsi protagonista è il meta-sguardo dell’Artista degli “occhi grandi”, dolenti e immensi di senso quali le migliori produzioni del genio de La sposa cadavere, solo uno dei suoi non pochi capolavori.
Amy Adams diretta di Burton “rispecchia” il suo immaginario pittorico come meglio non potrebbe, mentre il pur bravo Waltz è per l’occasione troppo spesso sopra le righe. A mancare, dunque, forse è proprio la magia di Tim, o quella a cui da tempo ci ha abituati: Big Eyes è un più che buon film sull’emancipazione femminile dell’epoca, sulla manipolazione dei media e del marketing rispetto all’arte (si veda a tal proposito il fondamentale documentario Exit Through the Gift Shop di Banksy) e su pregi e virtù di un periodo mutante per l’America coincidente, non a caso, con la Beat Generation di San Francisco, ma che tuttavia poco ha a che fare con i temi e le poetiche di Tim Burton.