Da oltre un anno mi occupo attivamente della divulgazione della Bioeconomia, che – è bene ricordarlo fin da subito – non è la “economia del settore bio” (come sta cominciando a farci credere un certo pressapochismo mainstream), bensì una disciplina socioeconomica che postula, ai fini della salvaguardia del nostro habitat, uno sviluppo dell’attività umana neghentropico, cioè attento ad evitare l’irreversibile degradazione di materia ed energia intrinseca ai processi produttivi. Uno dei riferimenti concettuali oggi giorno più osteggiati – con un tasso di ostracismo che sconfina nell’eresia – è quello di “decrescita”, che nei suoi presupposti fondamentali si ispira proprio all’approccio bioeconomico introdotto mezzo secolo fa da un geniale economista rumeno a cui fu negato il Premio Nobel soltanto per la scomodità delle sue tesi (naturalmente contrarie alla deriva ultracapitalistica di allora). Una delle quali, certamente la più “blasfema”, era che un sano e duraturo equilibrio ecosistemico avrebbe dovuto basarsi non tanto sulle leggi che governano l’offerta aggregata (più produttività, più efficienza e più stress sui fattori produttivi), quanto sulle dinamiche della domanda: soltanto da una sobria e responsabile rimodulazione dei nostri stili di vita si sarebbero potuti ripristinare gli equilibri ambientali ed umani che il boom economico del Dopoguerra aveva così repentinamente stravolto nelle cosiddette “economie sviluppate”.
Ancora oggi, la stragrande maggioranza degli italiani che si confrontano con queste teorie arricciano istintivamente gli angoli della bocca, preferendo magari pensare all’ultimo smartphone lanciato sul mercato, salvo poi ostentare una certa e titubante indignazione di fronte alle notizie sull’iniquità distributiva dei redditi, sul surriscaldamento climatico, sull’imminente esaurimento dei combustibili fossili, su una disoccupazione giovanile lanciata come un treno verso il 50%, sui livelli retributivi in picchiata e sulla capitolazione dei consumi. Tutto questo, naturalmente, mentre qualche abilissimo funambolo retorico del terzo millennio si affanna a nascondere la polvere sotto il tappeto, preannunciando nuove stagioni di prosperità collettiva. La prosperità ci sarà, certo. Ma si presenterà sotto altre forme. Che si chiamano società vernacolare e si baseranno sulla sobrietà energetica e consumistica.
Abbiamo tirato troppo la corda: dovremo prima o poi ammetterlo a noi stessi e, soprattutto, al Pianeta che ci ospita. Il mostro turboliberista, galvanizzato da una mentalità capitalistica sempre più spietatamente fondata sul dogma della Crescita ad ogni costo, ha ormai finito di sbranare gli ultimi tessuti ancora attaccati all’osso.
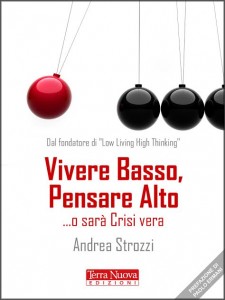 Qualcuno, puerilmente sedotto dall’illusione che l’esportazione di questo modello nell’Oriente e nel sud del mondo avrebbe garantito alla popolazione umana, mediante l’apertura di nuovi mercati, ulteriori decenni di “benessere” su vasta scala, continua a professare il mito dello sviluppo economico, sotto l’araldica del Pil. Che, è bene ricordarlo, non è stato rivitalizzato neanche dalla grottesca inclusione contabile di prostituzione, narcotraffico e contrabbando.
Qualcuno, puerilmente sedotto dall’illusione che l’esportazione di questo modello nell’Oriente e nel sud del mondo avrebbe garantito alla popolazione umana, mediante l’apertura di nuovi mercati, ulteriori decenni di “benessere” su vasta scala, continua a professare il mito dello sviluppo economico, sotto l’araldica del Pil. Che, è bene ricordarlo, non è stato rivitalizzato neanche dalla grottesca inclusione contabile di prostituzione, narcotraffico e contrabbando.
Nonostante la presenza di qualche “bolla d’ossigeno” ancora in giro per il globo, il modello basato sulla crescita globale dell’output è avviato al tramonto. Le sempre più scarse dotazioni energetiche tradizionali, l’affievolimento della spinta motivazionale di popolazioni sempre più scoraggiate dallo scollamento tra democrazia e potere, e l’accentramento del capitale in mani sempre meno numerose e sempre più avide, stanno rapidamente tracciando la nuova rotta.
Chi difende e diffonde queste preoccupazioni – effetti collaterali di una mentalità che ha illusoriamente inseguito una crescita infinita in un sistema dalle risorse finite – viene additato come un impenitente gufo catastrofista: sebbene queste considerazioni appaiano in netto contrasto con la cultura dominante da cui siamo ipnotizzati da oltre due secoli, i radicali cambiamenti socioeconomici che abbiamo appena cominciato a sperimentare (ci siamo dentro sì e no con la punta di un alluce) imporranno una seria rimodulazione delle nostre scelte individuali e comunitarie.
Come argomenta il prof. Mauro Bonaiuti nella prefazione all’opera principale del padre della Bioeconomia, “due sono essenzialmente le alternative: la prima è che una qualche catastrofe di dimensioni planetarie induca una profonda revisione delle preferenze; la seconda è che una profonda revisione delle preferenze eviti la catastrofe.”
Di questo ed altro, mediante il racconto della mia scelta di fuoriuscire da questo sistema, parlo nel nuovo libro “Vivere Basso, Pensare Alto…o sarà Crisi vera”.
Articolo Precedente
Animali torturati per produrre più carne. E la chiamano economia

Articolo Successivo
Brindisi, il canile della vergogna. Comune: “Cerchiamo di supplire a carenze attuali”






