‘The Stories of John Cheever’, alla riscoperta dei racconti
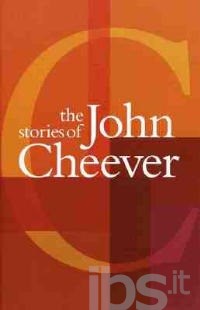 Nel 1979, negli Stati Uniti, uscì The Stories of John Cheever. Il libro raccoglieva tutti i racconti di John Cheever, uno scrittore difficilmente etichettabile. La raccolta vinse il Premio Pulitzer, il National Book Award e il National Book Critics Award. Sicuramente ciò che meritava il suo autore, che di lì a poco, tre anni, sarebbe morto, all’età di settant’anni, a seguito di un cancro ai reni.
Nel 1979, negli Stati Uniti, uscì The Stories of John Cheever. Il libro raccoglieva tutti i racconti di John Cheever, uno scrittore difficilmente etichettabile. La raccolta vinse il Premio Pulitzer, il National Book Award e il National Book Critics Award. Sicuramente ciò che meritava il suo autore, che di lì a poco, tre anni, sarebbe morto, all’età di settant’anni, a seguito di un cancro ai reni.
In Italia, John Cheever è stato largamente sottovalutato, a tratti ignorato, per diversi decenni. A dare la giusta attenzione ai racconti e ai romanzi di quest’uomo tormentato, ci fu, qualche anno fa, la casa editrice Fandango, che decise di pubblicare alcuni volumi molti dei quali tradotti da Leonardo Giovanni Luccone.
Negli ultimi anni, è la casa editrice Feltrinelli a rilanciare l’autore. E’ dunque bello, nelle desolanti librerie italiane, vedere volumi che permettono di riscoprire Cheever: è di quest’anno la pubblicazione delle Lettere, tradotte da Tommaso Pincio, nella collana Le Comete; è del 2012 la pubblicazione dei diari, il bellissimo Una specie di solitudine, tradotto da Adelaide Cioni; ed è sempre del 2012 la pubblicazione, finalmente, in Italia, dei Racconti, quel The Stories of John Cheever che ingenera cortocircuiti che squarciano il secolo Novecento. Pochi mesi fa, il volume è stato ripubblicato nell’Universale Economica Feltrinelli, ed è senz’altro il modo migliore per avvicinarsi all’autore.
John Cheever è uno scrittore che è un inganno: leggendolo distrattamente si potrà credere che egli sia un autore di narrazioni, di trama. Si potrà credere che ciò che gli interessa sia nelle piccole cose, nel quotidiano, nei lievi smottamenti che la vita ingenera nel genere umano. Non è proprio così. Sarà lui stesso a dichiarare: «Io non lavoro con la trama, lavoro con l’intuizione, la percezione, i sogni e i concetti. La trama implica la narrazione e un sacco di stronzate. Non c’è alcuna filosofia morale nella narrativa al di fuori dell’eccellenza».
John Cheever è uno scrittore metafisico, anche se non si vede. Ed è anche per questo che è metafisico. Cheever si occupa della vita, volendo, con la sua arte, definire la dissonanza metafisica della vista stessa.
Lo sottolinea molto bene Andrea Bajani nell’introduzione ai Racconti. Uno dei compiti che John Cheever sembra volere infliggersi – perché per lo scrittore è necessaria l’afflizione – è questo: dare udienza ai fantasmi. “Provare ad ascoltare la loro stazione radiofonica, entrare nell’intercapedine, in quell’abisso, che fa anche paura, e dove i fantasmi, con un microfono davanti e le cuffie nelle orecchie, trasmettono sulla loro frequenza di scoppi e fruscii”.
La scrittura per lo scrittore – sembra voler dire Cheever nei suoi racconti – non è che, continuamente, un’immersione nel fondo, uno stare al confine tra la realtà e tutto ciò che risiede fuori dalla realtà, per arrivare a capire che il senso del mondo, l’unico senso del mondo, deve essere fuori di esso. E’ forse per questo che in uno dei suoi racconti più celebri, Il nuotatore, Neddy Merrill, il protagonista, decide, senza apparente altra ragione, di attraversare il proprio quartiere a nuoto, passando da una piscina dei vicini all’altra. Nel corso del suo viaggio, il tempo narrativo accelera e un pomeriggio di nuoto si trasforma in un’Odissea di mesi, forse anni, di lontananza da casa. Quando infine, sfinito e infreddolito, Neddy raggiunge la propria abitazione, la trova abbandonata e in rovina: davanti a lui solo relitti.
Uno degli insegnamenti di John Cheever è questo: bisogna credere nei relitti. E leggendo i suoi racconti – dove di relitti non se ne trovano molti – riecheggia, continuamente, un odore di relitti, come se fosse la realtà luccicante, quella più normale, quella delle giornate trascorse in famiglia, della vita quotidiana, ad aprirsi, talvolta, quando il mondo è distratto, e a svelare la sua vera natura: una natura fatta di relitti. Un panorama desolato, dove bruciano pneumatici e uomini oscuri riemergono dalle tenebre solo per ricordarci che la verità è lì, proprio nelle tenebre.



