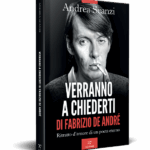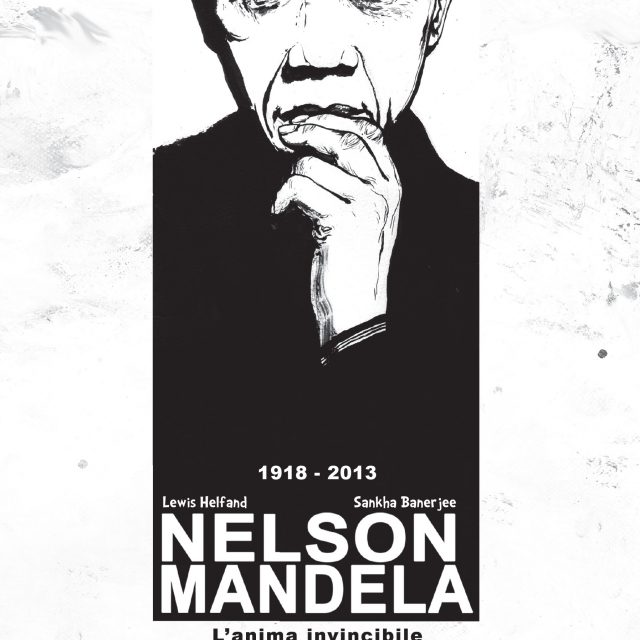Luca Vanni non è abituato alla ribalta. A fine 2013 era quasi fuori dai primi mille, un anno fa 700 al mondo. Ora è a un passo dai primi 100. Altissimo, servizio notevole, rovescio bimane. Trent’anni a giugno, è un ragazzo timido. Simpatico, disponibilissimo. Genuino. È nato e vive a Foiano della Chiana. Il paese aretino è noto anche per il Carnevale, e proprio durante il Carnevale hanno voluto abbracciarlo: i concittadini ai piedi del Palazzo, lui in cima al terrazzo con il Sindaco. La vita di Vanni è quella del tennista di seconda fila che, ostinatamente, si oppone a sfiducia e infortuni. Vive viaggiando tra future e challenger, centrifugato tra ritmi forsennati e prize money che un Djokovic neanche prenderebbe in considerazione. Poi, tre settimane fa, l’exploit in un torneo ATP: finale a Sao Paolo, terra rossa brasiliana, con lui che serve per il match contro il 30 al mondo (Cuevas). Se avesse vinto sarebbe diventato 80 al mondo, con la finale ha toccato il best ranking di 108. L’impresa gli è valsa la convocazione come quinto di Davis contro il Kazakistan, al seguito della prima squadra con Fognini, Seppi, Bolelli e Lorenzi. “Alla Davis non dici mai di no. Una parte di me pensa che, in questo modo, non potrò andare a fare le quali a Indian Wells e perderò punti. Per entrare al Roland Garros è fondamentale essere a ridosso dei cento, ma questa convocazione è un grande onore”.
A Sao Paolo sei stato a un passo dall’impresa autentica: è maggiore la gioia per la finale raggiunta o il rimpianto per non avere vinto il titolo?
Inutile nasconderlo, un po’ ci penso a quel servizio non tenuto sul 5-4 del terzo set. Non dirmi però che ho avuto il “braccino”, anzi proprio per non averlo ho spinto ogni colpo. Ho sbagliato uno smash, ma non ho rimpianti. E Sao Paolo non è l’unica cosa che ho fatto. Certo, cambia il peso degli incontri. Cambiano gli hotel, gli spettatori. In campo, però, è sempre e solo tennis.
In semifinale avevi contro l’idolo locale, Joao Sousa. Ti hanno gridato di tutto. Sembrava di essere tornati a Maceiò, quando la torcida provocò i crampi psicologici a Pescosolido.
C’erano 6mila spettatori, 50 per me e 5950 per lui. Stadio immenso, tetto altissimo. Più mi insultavano, più mi caricavano. A fine match, al microfono, ho lanciato baci e ringraziato il pubblico “per l’affetto”: ero appena ironico.
Tra una vittoria e l’altra, registravi video sotto la doccia. Sembravi vagamente ubriaco.
Macché ubriaco. Il problema è che l’inglese non lo conosco benissimo. Così parlavo in maniera incerta. E poi ero felice. Tutta quella ribalta mi era nuova, come le conferenze stampa. Dopo la prima vittoria, ho visto la scrivania con il mio nomesopra e un plotone di giornalisti. Ero terrorizzato: che gli racconto? Mi faranno il terzo grado.
Invece?
Invece, quando rompi il ghiaccio, poi ti diverti. I giornalisti pendono dalle tue labbra, sembra quasi che tu gli stia rivelando notizie fondamentali. È buffo. L’unico problema era che a volte non mi venivano le parole. Ci ho messo mezzora a ricordarmi che “orgoglioso” si dice “proud”.
È vero che, in Brasile, hai comprato una racchetta al primo negozio che hai trovato perché quella precedente l’avevi spaccata durante le quali?
Più o meno. A fine 2014 provo una Wilson nera, per professionisti. Mi piace e me la faccio spedire. Però me ne mandano un’altra arancione. Dicono che è identica, colore a parte, ma per me non lo è. Poi parto in Brasile con quella racchetta.
Solo quella?
Solo quella. Vinco il primo turno di quali a fatica, non mi trovo bene e ne compro un’altra in un negozio: una racchetta normale, che può acquistare chiunque.
Non potevi contattare direttamente la Wilson?
L’ho fatto, conosco uno dei rappresentanti. L’ho cercato su Skype di continuo, ma non mi ha mai risposto. Poi, guarda caso, dopo aver vinto la semifinale mi ha richiamato: “Ehi, Lucone, cercavi qualcosa?”.
Al primo turno di quali hai faticato con il numero 871 del mondo, sette giorni dopo per poco non batti il 30. Com’è possibile?
Il campo in cui ho giocato il primo turno di quali era assurdo. Sotto un tendone, attaccato a un altro campo dove la gente si allenava. A due passi c’era il Carnevale, un casino che non hai idea, e il campo non era neanche regolamentare: erano proprio sbagliate le misure.
A Sao Paolo neanche dovevi esserci.
La settimana prima c’era Quito: Ecuador, altura. Ero a Foligno, dove mi alleno, e non sapevo se partire: fuori di due dal tabellone. Poi si è liberato qualche posto e ho preso il volo. Già che c’ero ho fatto Sao Paolo.
Come calcoli le trasferte? Intendo i costi.
Quando in banca hai 20mila euro, non è che puoi buttare via i soldi. Come trasferta spendevo 2mila euro, in Ecuador ne prendevo 3200 anche se uscivo subito (come è successo). Potevo starci. Una volta che sei lì, ammortizzi. Dividi la camera con qualcuno, ti organizzi con altri per le trasferte. E comunque nei tornei ATP ti trattano da Re.
Tipo?
Hotel 5 stelle, navetta, rimborso pasti per due. Non ci sono abituato. Nei future fai tutto da solo e nei challenger ti rimborsano poco. Sono abituato a risparmiare su tutto, anche se una chianina e un rosso con la fidanzata, qualche volta, me le concedo.
Viaggi da solo.
Ho un grande allenatore, Fabio Gorietti, ma preferisco fare quello che mi pare. Se dico di trovarci alle 20 per cena e lui arriva alle 20.10, mi innervosisco. Non c’è niente da fare, il tennista è un nomade singolo.
Sei arrivato alla soglia dei primi 100 a quasi trent’anni.
Mi sono diplomato a Ragioneria a Foiano, poi dai 19 anni ci ho provato. Mi allenavo a Perugia, mi manteneva mio padre. Mi pesava. Nel 2006 mi iscrivo a un future e vinco una partita: un punto Atp. Poi ne vinco un’altra: due punti Atp. E mi ritrovo 650 del mondo.
Cambia molto?
Qualcosa. Prima mi guadagnavo da vivere facendo l’istruttore di tennis al Circolo Giotto di Arezzo: quindici euro l’ora. Poi partecipavo alla serie A, ai tornei a squadre: Italia, Francia, Germania. Per darti un’idea, se non hai classifica prendi tipo 400 euro a partita. Se sei 650 al mondo, te ne danno – che so – 1000. Non ti cambia la vita, ma sopravvivi.
Hai avuto molti infortuni.
A 20 anni mi sono saltate le ginocchia due volte. Nel 2013, dopo tanta gavetta e troppo dolore, mi sono operato al tendine rotuleo. Da mesi andavo avanti col cortisone. Dopo due sconfitte al primo turno in Australia ero a pezzi. Quasi non camminavo più. Prima del torneo successivo mi sono cancellato, sono tornato a casa e mi hanno operato.
Sei quasi uscito dai primi mille.
Nel 2014, per risalire la classifica, non so neanche quante partite ho giocato. D’estate è stato un delirio: c’erano i future a Santa Margherita di Pula in Sardegna. Li vincevo e la domenica volavo a Catania, a Roma, in Croazia. Facevo il campionato a squadre e al lunedì tornavo in Sardegna. Spesso neanche dormivo.
Mai pensato di smettere?
Qualche volta. Non sai quanti pianti dentro la vasca: “Perché capitano tutte a me?”, mi chiedevo. Andavo a lavorare nel mobilificio di mio padre, ma dopo un po’ mi cacciava: “Qui non ti voglio”. Lui mi ha sempre spronato, altri no. A 19 anni avevo scritto una lettera ai miei genitori promettendo che ce l’avrei fatta: forse sono stato di parola.
Il momento più duro?
Dopo l’ultima operazione. Quattro mesi di stop. Ho passato un giorno agli Internazionali di Roma. Vedevo gli altri giocare ed era come avere una coltellata al cuore. Sognavo di essere nel tabellone principale l’anno successivo, cioè questo. Magari ce la faccio.
Chi ti conosce dice che, senza infortuni, saresti un top 40.
Prova a rovesciare il concetto: siamo sicuri che, senza infortuni, sarei vicino ai 100? Certo, ho avuto sfortuna. Anche dopo l’operazione: sei mesi fa, in volo per la Francia, per poco un’otite mi manda al Creatore. Un’altra volta avevo così male al polso che ho usato solo il rovescio in back: ci ho pure vinto il doppio, con quel back del cavolo.
Però?
Però gli infortuni mi hanno spinto a non mollare. Forse senza infortuni mi sarei adagiato sui 300-400 al mondo. In fondo ottieni ciò che meriti, la vita ha una sua giustizia. Anche se non capita sempre. Penso soprattutto a Federico.
Luzzi. Una leucemia fulminante se lo è portato via a neanche 29 anni. Aretino come te.
Ci allenavamo insieme, giocavamo i pokerini. Mi diceva che dovevo pormi come obiettivo quello di giocare le quali negli Slam. Anche Bracciali è aretino. E Starace si è allenato per anni al Blue Team di Arezzo. Potito è un po’ il mio punto di riferimento.
Lo scandalo scommesse lo ha travolto.
Lo so e non posso dire se sia colpevole o meno. Alludevo alla sua voglia, alla sua umiltà. Ricordo quando mi portò con sé in Spagna e mi regalò un biglietto prima di giocare con Nadal. Un gesto che non dimenticherò mai.
Sono gli unici big che conosci?
Fognini mi ha mandato un sms dopo la vittoria con Joao Souza, Seppi e Bolelli li conoscerò in Davis. Paolino (Lorenzi) è un amico da sempre, i suoi genitori stanno a Cortona. Anche lui è esploso tardi, però ha sempre gravitato nei 200. La mia è una storia molto più altalenante.
Che obiettivo ti prefiggi?
Cosa posso dirti? Tutto è possibile. Non fraintendermi, non sto dicendo che entrerò nei primi venti. Ma vivo alla giornata. È la cosa che mi viene meglio.