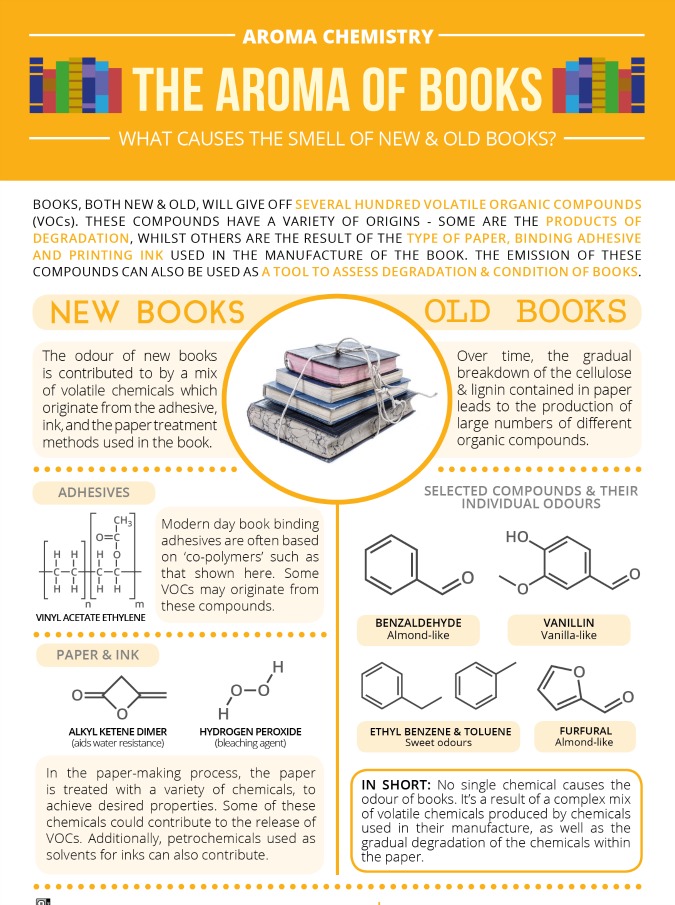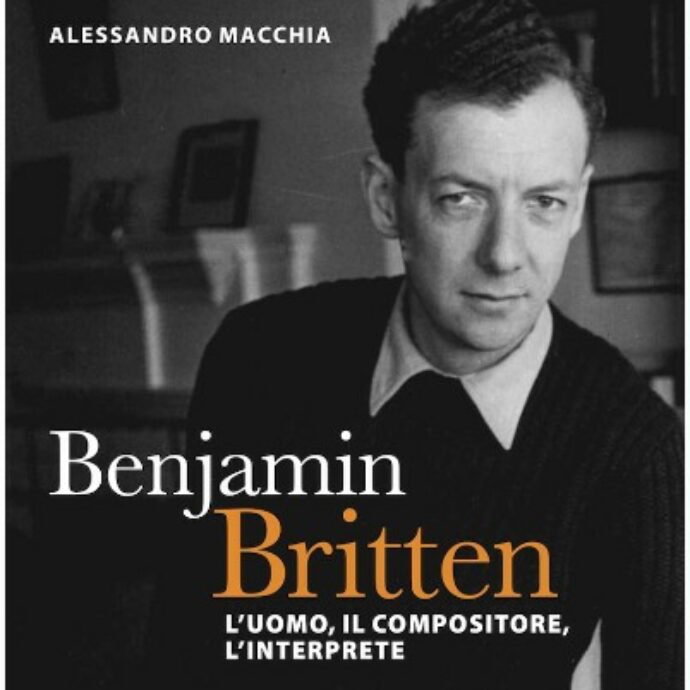Nel suo romanzo più famoso, tradotto in tutto il mondo, un attempato giornalista – nella calda estate del 1938, a Lisbona – incontra in treno una signora in vena di conversazione. “Lei è un intellettuale” fa la signora al dottor Pereira, “dica quello che sta succedendo in Europa, esprima il suo libero pensiero, insomma faccia qualcosa”. Pereira accampa scuse: c’è gente sopra di lui di cui deve tenere conto. “Capisco – replica la signora – ma forse tutto si può fare, basta averne la volontà”.
Dove sono gli intellettuali? La domanda, tutto sommato, è questa. Sono tutti in ferie, ragiona Pereira, gli intellettuali sono tutti in ferie. Non è il ’38, per fortuna, non è agosto, non siamo a Lisbona, ma da queste parti gli intellettuali sono eternamente in ferie. Uno come Antonio Tabucchi, morto a Lisbona il 25 marzo di tre anni fa, era fra i pochi in servizio permanente. E non per devozione a un’idea di impegno accigliata, un po’ snob e, in fondo, datata. La parola “intellettuale”, per esempio, non gli piaceva. L’impegno di uno scrittore, diceva, è scrivere bene quello che scrive, parlare con convinzione, fosse pure dei cavoli del proprio orto. L’impegno di uno scrittore è avere a cuore il mondo, è un esercizio di attenzione alle cose. “Anche dal mio paesello natale, quando ci sto, mi piace occuparmi del mondo, perché il mondo mi riguarda”.
Uno scrittore non può andare in ferie dalla realtà che ha intorno. Gran parte dei nostri scrittori, con la scusa di non essere più “impegnati” e di voler parlare solo attraverso i propri romanzi, tacciono di fronte a tutto. Tacciono fin troppo: forse perché non hanno niente da dire?
Questo giornale ha ospitato Tabucchi negli ultimi anni: come quelli di Fo o di Busi, i pezzi di Tabucchi non erano mai d’occasione. Nascevano, intanto, come un pugno che batte sul tavolo, nel moto di indignazione o di rabbia che non si può, né si vuole, frenare. Era, Tabucchi, un estremista appassionato, un radicale della parola scritta; oltre alla testa, in ogni suo intervento, c’entrava anche il cuore, c’entravano lo stomaco e il fegato. Come vanno le “fognature italiche?” mi domandava negli ultimi tempi al telefono da Lisbona, e sentivo che dietro quella sprezzatura c’era parecchio amore. Se cedeva alla nostalgia – “Ti ricordi com’era bella l’Italia?” si legge in uno degli ultimi racconti – era per mettere in salvo, dal passato, qualcosa di buono – di bello, appunto, di pulito – per il presente. L’ironia poteva essere feroce, toscanissima, a rischio querele (ne prese di pesanti da Schifani e da Ferrara). Le posizioni anche troppo spigolose, a rischio tagli (Le Monde sfrondò un suo pezzo contro Cesare Battisti, “santificato – scriveva – da alcuni intellettuali francesi”).
Ma la sua capacità di ostinazione non cedeva di fronte a niente: ricordo nottate a casa sua, a Vecchiano, provincia di Pisa, in cui non si andava mai a dormire, perché lui continuava a discutere, a fumare, a incazzarsi, e voleva andare più a fondo, in questa o quella questione, e mi diceva: guardiamo meglio, cerca, bisogna capire. Ma Antonio, è l’una di notte. Non importa. Non so se avrebbe condiviso le opinioni di Erri De Luca, ma l’aggettivo “pavidi”, rivolto da De Luca ai suoi colleghi, l’avrebbe sottoscritto. Non amava le mezze tinte, i piccoli compromessi con la coscienza propria e l’altrui. Della classe politica italiana, nella sua ultima estate (quella del 2011), scriveva sul Fatto che, una volta finite le stragi, è passata al furto. “Agli italiani ha rubato tutto. Ha rubato il paesaggio. Ha rubato la libera scelta e la libera concorrenza. Ha rubato il futuro dei nostri giovani… Ha rubato la fiducia nella democrazia (era fragile e incerta, ed è stato facile) e nelle nostre istituzioni. Ha trasformato il Parlamento in un rifugio di corrotti, di mafiosi, di indagati, di condannati”. Esagerava? Ma uno scrittore non ha anche il compito di “esagerare”, di suonare l’allarme, di farlo suonare per tempo, prima che serva davvero, prima che sia tardi?
Manca Tabucchi, mi manca, anche e soprattutto quando esagerava, quando non ero d’accordo con lui fino in fondo. Per i suoi libri, e per le parole intorno e oltre quei libri – che suonavano come la sua voce nelle notti vecchianesi: guardiamo meglio, cerca, bisogna capire.