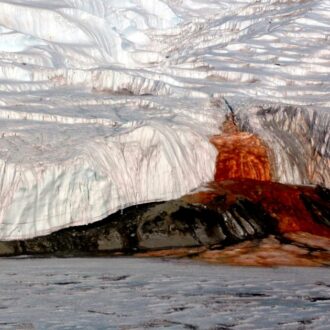“Se è vero – e lo è – che i grandi film sono quelli in cui si ride e si piange molto, ‘Mia madre’ di Nanni Moretti è un grande film. Perché fa ridere con le lacrime agli occhi e fa piangere col sorriso sulle labbra“. Questo è l’incipit della critica di Marco Travaglio all’ultimo film di Moretti.
Non ho riso e non ho pianto. Sono un mostro? Sono diventato di colpo una persona insensibile? Non credo. Non ho mai amato il gigantismo definitorio: grande amore, grande cinema. C’è l’amore, c’è il cinema. Perché aggiungere ‘grande’? Ma se con una pistola puntata alla testa dovessi scegliere tra gigantismo e nanismo propenderei con sicurezza per la seconda opzione. Quindi, un piccolo film.
In che senso ‘piccolo’? Perché non ho pianto? Due sono le risposte possibili: perché non sono Marco Travaglio e forse perché Moretti non voleva farmi piangere, non era nelle sue intenzioni. Ho pianto nella scena finale di The Champ di Zeffirelli, ho pianto perché Zeffirelli voleva farmi piangere. Moretti ha scelto un’altra strada, meno evidente, meno ‘pornografica’, se mi passate il termine. Un dolore così personale va affrontato lateralmente, con manovre elusive.
Un film sulla madre senza una scena madre. Scelta azzeccata, in questo il film funziona. Il dolore diventa fessura, intercapedine dell’anima, solo così è comunicabile, con pudore e sobrietà linguistica.
Una bolletta che non si trova, un appartamento allagato, l’inutile tentativo di asciugare con i quotidiani quello che è eterno: l’implacabile scorrere della vita, il senso di alienazione che si prova a dirigere un film quando la propria madre sta morendo fuori dal set, la voglia di licenziarsi e di tornare a un ‘tempo infantile’ e lasciarsi dietro le etichette sociali. “Mi si nota di più se vado alla festa o non ci vado?”. Ecco, il dolore cinematografico di Moretti ha questa grazia della sottrazione, assenza/più acuta presenza (come direbbe Attilio Bertolucci).
Frammenti di dolore, come già ne La Stanza del figlio il dolore era l’incapacità di lasciare un messaggio a una segreteria telefonica. Dicevo anche che non ho riso. Ho sorriso invece. Anche qui lo stesso discorso. Non si può ridere, non si deve ridere in questo film, le risate sono grasse a volte, comunque sovrappeso. Sorridere è un atto lieve, una sfumatura interiore. E tutte le scene legate all’attore Turturro hanno questo segno, il segno del sorriso, e della vitalità.
Come spettatore avrei preferito che il personaggio fosse caratterizzato in modo meno caricaturale, un tono sotto diciamo, anche per dare più verità a quella carezza che Turturro fa alla regista interpretata da Margherita Buy. Il film non mi ha emozionato, e questo è il suo pregio, la sua recondita emozione, ma devo confessare un peccato di oggettività: quando vediamo il cadavere della madre sul letto ho concentrato la mia attenzione sul corpo dell’attrice e mi è sembrato di notare un respiro: era viva. E se il cinema è ‘la morte al lavoro’ come sosteneva Cocteau, in fondo anche questo film ha un senso. Purtroppo, mi verrebbe da dire.
Articolo Precedente
‘Ameluk’ e ‘Le frise ignoranti’: la commedia italiana parla pugliese con Rosanna e Lino Banfi

Articolo Successivo
Samba, una storia d’amore e immigrazione con il “quasi amico” Omar Sy e Charlotte Gainsbourg