Se fosse un film, o una puntata di una serie televisiva, andrebbe trasmessa a notte fonda, magari coi sottotitoli, e forse per l’ultima volta. Ma non è un film, non è una serie televisiva, e la notte è scesa da tempo: si tratta -anzi, si trattava – di un anniversario, una data cerchiata in rosso, un momento di ricordo, ventiquattro ore che avevano un significato particolare, che richiamavano nelle orecchie un boato vecchio di vent’anni, una marcia di rabbia lucida che sembrava essere sopravvissuta, un sacrificio involontario che avevamo custodito come fosse una molla, un orizzonte, una specie di nuovo e fottutamente dolorosissimo inizio.
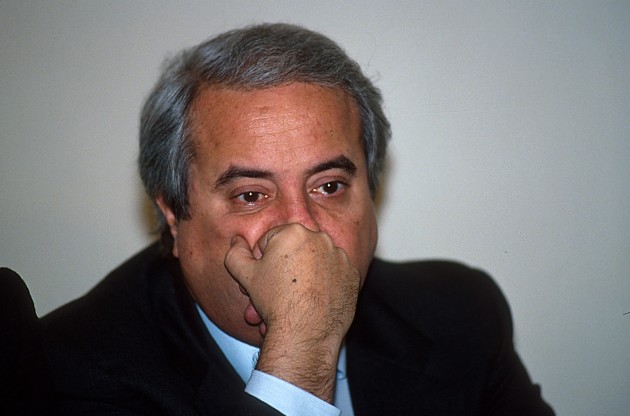
Definizioni che oggi vengono già tutte maledettamente declinate al passato: era, appunto. Perché l’edizione numero ventitré delle Falconiadi, oggi, non ha più nemmeno un briciolo di tutte quelle preziose caratteristiche che un paio di generazioni di gente perbene ha voluto vederci dentro: dentro a quel 23 maggio e dentro ad ognuno di noi.
Se fossimo un Paese onesto, almeno intellettualmente, non avremmo problemi a dire che oggi questa data ci appare vuota: sono scomparsi certi significati di rinascita, come quando stavamo finendo dentro al baratro aperto dal tritolo, e ci siamo appigliati ad un ramoscello di un albero, quello di via Notarbartolo, l’albero Falcone. Si è spezzato quel ramo, o forse l’hanno sostituito con uno di plastica, oggi che ha vinto il discount dell’antimafia, le facce in bianco e nero, gli slogan con tanto di hastag, una volta all’anno, un giorno su 365, una comunione presa la domenica per tornare più leggeri a delinquere di lunedì.
Il 23 maggio, oggi come oggi, non vuol dire più nulla: e non solo perché a battersi il petto in quella cattedrale di sangue e fierezza chiamata aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo ci arrivano ogni anno gli stessi che insorgevano davanti al tribunale di Milano contro i pm che processavano B, le facce sponsor della responsabilità civile per i magistrati, le mani che firmano Jobs act di fame e riforme scolastiche che faranno forse da indotto a schifose clientele.
Fino a qualche anno fa, sembrava indispensabile fare i nomi e cognomi, dire e scrivere che a ricordare Giovanni Falcone atterravano a Palermo gli stessi figuri che, a Roma, volevano abolire la mafia, ma solo per legge. Adesso, ed è un fenomeno davvero curioso e a tratti imbarazzante, si è dissipata perfino quella voglia, quel dovere, quel desiderio di denuncia: il fatto è che ci siamo abituati a questa plastica, la mal sopportiamo, circondati come siamo da vari circhi ritinteggiati d’antimafia. E non è solo colpa della cosiddetta classe dirigente, incapace di cambiare, di girare pagina al Paese.
Mentre a commemorare l’Attentatuni scendevano in numeri sempre superiori, infatti, l’antimafia si tingeva sempre più di nero. Mai un vocabolo è passato così velocemente dall’essere proibito al dare la nausea: Roberto Helg era il presidente della Camera di Commercio, diceva di essere contro il pizzo e l’usura, poi l’hanno arrestato per estorsione; Antonello Montante, potente capo degli industriali di Sicilia, leader della rivolta anti racket di Confindustria, è indagato tra mille polemiche – che potrebbero anche assumere la consistenza del fango- per concorso esterno a Cosa Nostra; i beni sottratti alla mafia invece li gestiscono pochi amministratori, sempre gli stessi, con tariffe a cinque zeri e schiere di consulenti inseriti a bilancio di aziende che nel novanta per cento dei casi falliscono dopo il sequestro.
Ma forse il principale tratto distintivo della nostra epoca è rappresentato dai cosiddetti simboli dell’antimafia che scendono in politica, per poi perdere ai punti dell’incompetenza questo strano round lungo vent’anni tra criminalità e legalità: una partita che finisce sempre in mille rivoli di paradossi senza senso. Se è vero che la storia si compone di cerchi concentrici, epoche destinate a finire o a ripetersi concludendosi in farsa, è il caso di dire che l’età della cosiddetta antimafia stia definitivamente franando.
O finendo, peraltro molto male. Concepito con il Maxi Processo di Palermo, generato definitivamente tra poche centinaia di metri e pochissimi giorni (gli stessi che separano l’autostrada A29, all’altezza dello svincolo di Capaci, con via Mariano D’Amelio), il vocabolo antimafia e tutte le sue produzioni laterali hanno iniziato ad avere un sapore stantio, marcio, appassito. Diceva Leonardo Sciascia che se tutto è mafia, niente è mafia: oggi stiamo attraversando i tempi in cui tutto è diventato antimafia.
Ernest Hemingway, invece, sosteneva che la sua generazione era stata profondamente segnata da un evento, la prima guerra mondiale: poi aggiunse che in effetti non solo la sua, ma ogni generazione porta le cicatrici di un singolo enorme evento. Il nostro evento, quello che ci ha segnato, è finito vittima di eccessiva pubblicistica, cannibalizzato da convenienze di parte, fino ad arrivare all’inevitabile crisi di rigetto: era denso di significati il 23 maggio, di obbiettivi, di promesse rinnovate , ma sono (siamo?) riusciti ad annullare ognuno di questi significati, a svuotarlo per lasciare spazio alla retorica. I fatti reali contano sempre meno, senza quell’etichetta, quell’antimafia appiccicata a casaccio ovunque. E dato che oggi tutto è antimafia, ne deriva che niente sarà probabilmente ormai antimafia. Forse è il caso di reinventarselo con i fatti questo termine e questo giorno, prima che sia troppo tardi.
Articolo Precedente
Strage di Capaci, il 23 maggio e la nostra coscienza

Articolo Successivo
Beni confiscati: lo Stato non c’è, a Cisliano i ragazzi difendono ‘La Masseria’






