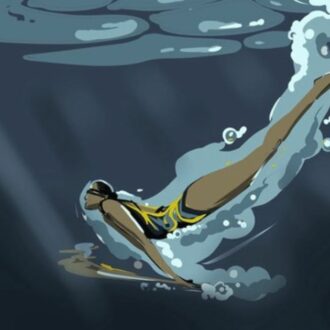Modena – Io sento che, son sicuro che, io so che gli angeli sono milioni di milioni e che non li vedi nei cieli ma tra gli uomini, sono i più poveri e i più soli, quelli presi tra le reti (Lucio Dalla, “Se io fossi un angelo”)
Non esistono angeli e non esistono demoni. E’ un’osmosi, un passaggio liquido dalla divinità al peccato e ritorno, purificandosi nel perdono, quando c’è, quando si può, quando è possibile. Nasciamo angeli e ci sporchiamo con la terra, con la vita, siamo nuvole prima di sprofondare nella melma del mondo, che troppe volte si fa invece “immondo”. Angeli con le ali increspate ed infangate non più capaci né in grado di sbatterle alte, di poter librarsi, come albatri troppo goffi per riprendere il filo ammezzato con il cielo, come Icaro devoti al fallimento. In un’arena-limbo-quadrato-ring di sabbia (potrebbe essere anche una spiaggia coperta di migranti) dieci corpi stazionano, pantaloni arrotolati e spago come cintura. Sembrano soldati di Ulisse in procinto d’attaccare il ciclope, storditi da Sirene, sembrano soprattutto abbandonati, corrosi dalla lotta.
Stefano Tè porta in scena in questo ‘Angeli e Demoni’ (niente a che vedere con Dan Brown) un folto gruppo di detenuti (una decina, mentre tre sono fuggiti durante le prove) accorpandoli ad attori della compagnia Teatro dei Venti e ad una dozzina di giovani. Ne esce un quadro d’impatto dai colori e dalla forza che da una parte emerge verticale, tra canti arabi e tamburi, e si eleva dal suolo in alto, dall’altro, una dirompente forza d’urto che investe lateralmente gli spettatori seduti, assiepati, in forma vicina, contigua e voyeuristica, attorno al fulcro dell’azione, gabbia.
Il regista napoletano con la barba da hipster, modenese da oltre dieci anni, lavora nella casa di reclusione di Castelfranco Emilia e nella casa circondariale di Modena, e ci mostra con lucidità e calore uno strappo incastrato nella tela del tempo, uno spazio mangiato e sottratto, una parentesi dove, con ‘La Gerusalemme Liberata’ sullo sfondo come essenza e sentore, le parole centenarie di Tasso si esaltano nelle bocche dell’oggi, divenendo presente, vita, richiesta d’aiuto, grido d’allarme, perdita, consapevolezza della sconfitta. Che anche Lucifero era un angelo. Il canto si fa preghiera e questa si disfa in una invocazione mentre le pose plastiche e statuarie di lotta si trasformano in appoggio. Come se la violenza potesse rendere un prospetto di colonne portanti, di nuove fondamenta sulle quali costruire un domani diverso dal passato. La loro danza è una haka maori, arrabbiati avanzano in questa spiaggia di conquista che si fa respingimento e palude, dove i passi affondano nelle sabbie mobili e le caviglie si fanno faticose al cammino imbrigliato verso l’ignoto.
 La rena scivola dalle mani come clessidra del tempo perduto e che non ritorna, i granelli ammantano i volti e gli occhi, come sepoltura, per non vedere brutture e strazi, sangue e devastazione dell’uomo contro se stesso e contro i propri simili. E non c’è salvezza e non c’è redenzione, il tutto infuso e imbevuto nel valzer da funerale di Shostakovic, nero pece che avanza e morde. Non bastano le preghiere in questo campo profughi, non servono le mani al cielo in quest’oasi al contrario, che non salva ma che accerchia, chiude, recinta, come campo santo, come bara, frontiera dalla quale non si può scappare né nascondersi, dove non esistono dune né ombre, ripari né rinfresco.
La rena scivola dalle mani come clessidra del tempo perduto e che non ritorna, i granelli ammantano i volti e gli occhi, come sepoltura, per non vedere brutture e strazi, sangue e devastazione dell’uomo contro se stesso e contro i propri simili. E non c’è salvezza e non c’è redenzione, il tutto infuso e imbevuto nel valzer da funerale di Shostakovic, nero pece che avanza e morde. Non bastano le preghiere in questo campo profughi, non servono le mani al cielo in quest’oasi al contrario, che non salva ma che accerchia, chiude, recinta, come campo santo, come bara, frontiera dalla quale non si può scappare né nascondersi, dove non esistono dune né ombre, ripari né rinfresco.
 Una danza macabra lambisce le coste di questo istmo, di questa lingua perduta, sperduta, dimenticata nel lutto di una notte senza fine, troiane senza via di fuga, in una difesa antica ed ancestrale, animalesca, da corrida e Minotauro, tra rantoli come delfini o capodogli o balenotteri spiaggiati senza più ossigeno né voglia di nuotare. Che rabbia fa rima con sabbia: “Più bevo e più sete mi viene, questi bicchieri son pieni di sabbia”, esplode la chitarra stornellante di Mannarino.
Una danza macabra lambisce le coste di questo istmo, di questa lingua perduta, sperduta, dimenticata nel lutto di una notte senza fine, troiane senza via di fuga, in una difesa antica ed ancestrale, animalesca, da corrida e Minotauro, tra rantoli come delfini o capodogli o balenotteri spiaggiati senza più ossigeno né voglia di nuotare. Che rabbia fa rima con sabbia: “Più bevo e più sete mi viene, questi bicchieri son pieni di sabbia”, esplode la chitarra stornellante di Mannarino.
Visto al Teatro delle Passioni, Modena, il 21 giugno 2015
Articolo Precedente
Lo Straniero, la rivista diretta da Goffredo Fofi premia Alba Rohrwacher, Roberto Keller e Marco Torchio

Articolo Successivo
Eretica, Ayaan Hirsi Ali torna a far discutere: “L’Islam va riformato: non è una religione di pace”