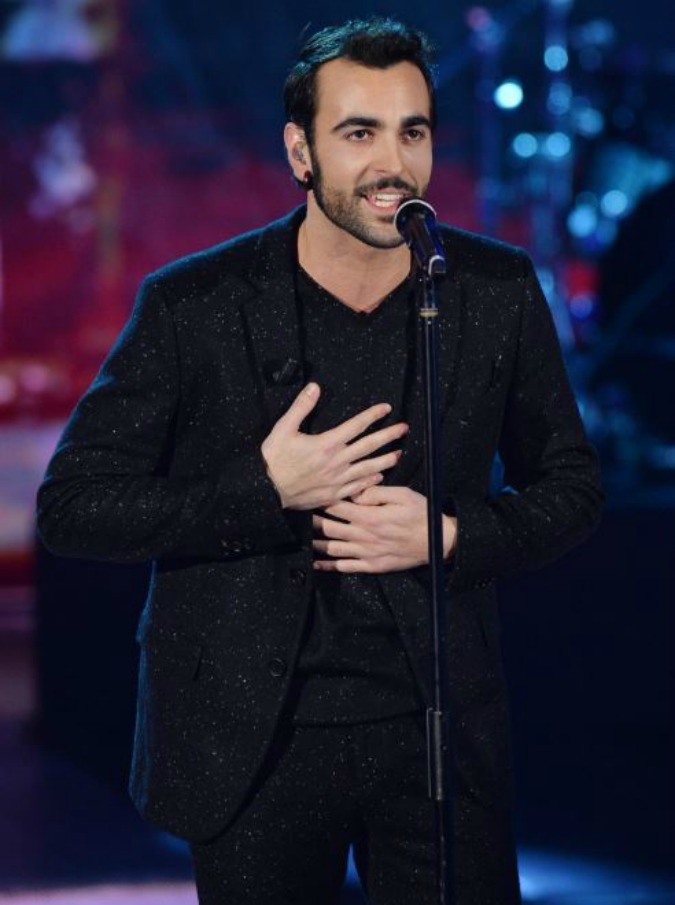Nel tempo inquieto e instabile del grunge i 48 anni di Scott Weiland devono essere durati una eternità. Non i simbolici 27 di Kurt Cobain, giovane fino all’ultimo nel ricordo dei suoi fan, adolescenti persi tra la fine del sogno americano incarnato dal ghigno di Ronald Reagan e l’esplosione di realtà del primo Bush. Non i 35 di Layne Staley, voce degli Alice in Chains, talento smisurato unito a smisurata insofferenza, a suo modo poeta quasi senza sforzo, o più probabilmente senza voglia, di quel buco nero senza proporzioni e senza sbocco che lo ha portato a consumarsi fino alla morte sul divano di casa.
Weiland era diverso. Tanto per cominciare era californiano, e questo nella epopea maudit dei maglioni bucati e del mal di vivere di inizio ’90 deve essere sembrata una colpa. Di Cobain e Staley condivideva solo la dipendenza dalle droghe. Non aveva la voce seventies di Chris Cornell né quella cavernosa ed empatica di Eddie Vedder. Tantomeno il karma di quest’ultimo, capace più di tutti gli altri di leggersi e salvarsi nella musica. In più era l’ultimo: arrivato al successo nella fase finale di un movimento che – come sempre accade nella musica – partito dall’underground era diventato mainstream. Insieme, per intendersi, a robaccia tipo Silverchair, mentre attorno nascevano mostri di incazzatura tipo RATM e il grunge lentamente incrociava il nu-metal di gente come i Korn. E anche questo non gli è mai stato perdonato.
Weiland ha insomma riassunto in sé tutti i vizi e tutti i fallimenti, ma mai abbastanza. Troppo poco grunge, originario di un posto con troppo sole per essere autorizzato a soffrire davvero, poca voce per essere vera rockstar, troppa per essere un mito. In tutto non più di dieci anni di successi, tra Stone Temple Pilots e Velvet Revolver. Ma sempre da manierista: grunge alla fine del grunge, glitterato insieme a Slash dopo la fine dei Guns n’ Roses.
Forse è per questo che la sua morte fa malinconia molto più del previsto. Trascina con sé la fine dell’adolescenza, smuove l’emotività nel ricordo di una breve stagione dell’innocenza, già turbata dalle ansie di adulto. Mentre Cobain e Staley hanno ‘preferito’ morire, Weiland ha vissuto, è rimasto aggrappato alla musica, sempre scacciato dai gruppi per la sua inaffidabilità e per la dipendenza da eroina. È morto a 48 anni non da eroe, ma da piccolo musicista che aveva ricominciato dalla provincia americana perché, aveva recentemente dichiarato “è l’unico modo per fare un po’ di soldi ora che i dischi non si vendono più”.
Difficile immaginare una frase più triste, più autentica e disillusa di così da uno che ha cantato Interstate love song davanti alle folle. Difficile pensare anche che esista qualcosa di più autenticamente sofferente che vivere per uno che da almeno 20 anni si aggirava come uno zombie tra gli uomini. Eppure – che sia ipocrisia di chi vuol vedere un senso dove non c’è o eresia di un ex adolescente che ha versato infinite e inutili lacrime sul ritmo di Creep ‘I am half the man I used to be‘ – la morte restituisce a Scott Weiland la dignità che altre star del rock hanno oscurato con la loro tragedia. Nella Spoon river dei cantautori maledetti la sua è la ballata dell’uomo qualunque. Che non era destinato né al successo e forse nemmeno alla tragedia. E proprio per questo, per uno scherzo mal riuscito, è rimasto incastrato nel mezzo fino alla fine. Senza mai decidersi davvero per l’una o per l’altra strada. Weiland è morto solo, nel tour bus che lo accompagnava in piccoli club di provincia. Non lontano, e in fondo mai abbastanza vicino a niente.