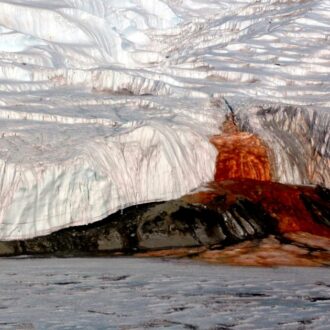Ero in sala alla Berlinale 66. in una delle proiezioni dell’ultimo film di Gianfranco Rosi, Fuocoammare. Le sale delle proiezioni erano gremite (e parliamo di sale da più di un centinaio di posti) in una manifestazione che ha dedicato proprio alle tematiche migranti gran parte della selezione dei film. Una scelta politica, quella della manifestazione, nell’alto significato del termine, come è lo stesso di film di Rosi. Un cinema politico, come lo era stato il Neorealismo, che nel nostro paese tende a essere messo ai margini o banalizzato, a volte censurato, che non stimola particolare interesse tra il pubblico (chissà se è vero?).

La pellicola di Rosi è invece importante per una serie di motivi: riporta al centro uno dei drammi più grandi (in termini di numeri), avvenuto in Europa negli ultimi trent’anni. Documenta in modo oggettivo il processo di accoglienza da parte dell’Europa, evidenziando dunque un vero vuoto di azione da parte delle politiche europee (il Frontex ha fallito). Contrappone l’immaginario nazionale con l’immaginario internazionale (quello dei numerosi sbarchi), cercando di far emergere contraddizioni presenti sia in una che nell’altra parte. Sceglie infatti l’isola di Lampedusa per raccontare quella parte di terra vicino all’Africa, una parte di Italia dimenticata e conosciuta solo per gli sbarchi avvenuti in questi anni. Una terra ai margini e ai confini del continente europeo, ma così presente e esemplare per evidenziare le contraddizioni tra locale e globale.
Fuocoammare lascia così la semplice retorica delle immagini televisive per inserirci in un viaggio attraverso gli occhi di un bambino (anche questa non è una scelta casuale) figlio di pescatori, che non parla italiano, non sa l’inglese, non sa remare, che soffre il mal di mare e ha l’occhio pigro perché pensa a sparare piuttosto di leggere e osservare. Samuele non vedrà mai i migranti, ma confiderà al dottore che di corpi migranti ne ha visti e analizzati molti, un’ansia che da tempo lo opprime.
Perché nel titolo del film, una forma gergale degli abitanti dell’isola, che è una metafora del mare agitato, è contenuto il vero significato politico del documentario (nella versione inglese oltretutto il titolo si fa più esplicito): non basta dire “c’è il mare agitato” per risolvere il problema, bisogna fare molto di più…
Articolo Precedente
Oscar 2016, Ennio Morricone favorito per i bookmaker. E quest’anno potrebbe essere la volta buona per Stallone

Articolo Successivo
Oscar 2016, il duello per la miglior attrice: tra Blanchett e Lawrence spunta Charlotte Rampling