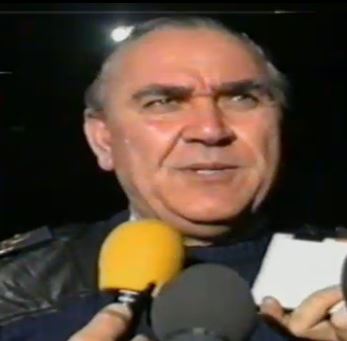Moby Prince, una storia italiana: la nave fantasma senza pace. La verità affondata da 25 anni di silenzi e contraddizioni










Chissà che storia, Bruno e Giuseppina, chissà che ridere Anna e Diego, dopo quel viaggio di nozze sognato tutte le notti. Chissà che urla, Liana, al campo di pallavolo – e chissà che occhi: li aveva scelti anche il cinema, una volta. Chissà che racconti, Giovanni Battista: ingigantiti ma solo un po’, racconti di marinai, anzi di marconisti, le voci delle navi. Chissà, comandante Chessa, che orgoglio i due figli medici, dopo aver speso metà della vita a tagliare onde, sfidare venti, appoggiare navi sui fianchi delle città. E chissà che emozione, piccola Sara, aver compiuto trent’anni, quanta paura di essere diventata grande, di sentirsi già vecchia.
Sara era una delle due bambine a bordo del Moby Prince. L’altra si chiamava Ilenia, era sua sorella e aveva appena cominciato a camminare. Sara e Ilenia sono rimaste bambine per sempre, quando la nave che le portava dai nonni, in Sardegna, si trasformò. Non più il luna park con il mare sotto, i corridoi di moquette e la cuccetta stretta stretta dove dormire tutti insieme, tutti vicini. Piuttosto un buco spaventoso, i rumori terrificanti, gli scoppi, il caldo, le lacrime, la tosse, che neanche Angelo e Alessandra – babbo e mamma, i più forti del mondo – sapevano far smettere.
Dopo 25 anni il Moby Prince continua a girare in tondo come la sera che andò a fuoco portandosi via 140 vite piene di futuro, a qualche colpo di remo dal lungomare di Livorno, il 10 aprile 1991. Gira intorno ai suoi interrogativi, le sue fiamme sono diventate eterne: un processo e due inchieste a 15 anni di distanza non sono riusciti a dare al disastro navale più grave della storia italiana una ricostruzione che abbia avuto la forza di reggere a dubbi, obiezioni, ipotesi alternative alla storia della nebbia, unica colpevole che qualcuno ha visto e altri no.
Da qualche mese una commissione d’inchiesta del Senato tenta di dare pace alla nave fantasma. Dentro quella commissione i partiti sono stati trascinati dai familiari delle vittime che non hanno ceduto neanche all’archiviazione dell’inchiesta bis del 2010. Stremati, hanno ricominciato a riascoltare file audio, a rivedere vecchi filmati e foto ingiallite, a chiedere perizie, a raccogliere i documenti persi o mai cercati. L’ultimo sforzo di un impegno civile coperto dal silenzio: dei giornali, della politica, dell’opinione pubblica.
Il silenzio è l’enorme fondale sul quale sono finite molte verità sulla sciagura del Moby Prince, il disastro che nessuno ricorda: un traghetto Livorno-Olbia con 66 membri dell’equipaggio e 75 passeggeri, appena uscito da uno dei porti più grandi d’Italia, si schianta contro la cisterna di greggio di una petroliera all’ancora, la Agip Abruzzo, armatore Snam, società di Stato. E fu subito silenzio: da quello del flebile mayday che nessuno sentì a quello dello shock di chi ascoltò la sentenza che assolveva tutti, nel 1997. Il silenzio del comandante della Capitaneria, Sergio Albanese, capo di soccorsi mai arrivati, che uscì sulla motovedetta e non disse una parola alla radio, mai: “Assentivo” dirà, sfidando il ridicolo. Il silenzio delle navi ancorate davanti a Livorno (undici, tredici, quattordici) che invece di offrire aiuto, come dice ogni dizionario del mare, scapparono. Il silenzio rimasto su navi con nome in codice o in incognito. Il silenzio dei due dipendenti della Navarma (ora Moby Lines, guidata ora come allora da Vincenzo Onorato) che non spiegarono mai perché manomisero il timone del relitto. Il silenzio del comandante dell’Agip, Renato Superina, che al processo non rispose alle domande e che nel frattempo è morto. Il silenzio delle prove “dimenticate” o scomparse, da entrambi le navi. Il silenzio della politica, infine, che ficcò subito la testa sotto terra. “La verità non sarà mai una verità appagante per nessuno” disse il presidente della Repubblica Francesco Cossiga – che di silenzi si intendeva – mentre ancora si contavano i morti.
Per questo la commissione del Senato per la prima volta dopo 25 anni ha l’occasione di riscattare questi anni in cui l’Italia del Moby Prince se n’è fregata. Di sicuro i senatori hanno già assistito a un bignami di questa storia. Maria Sammarco e Grazia D’Onofrio, due giudici del collegio che assolse tutti, al Senato hanno detto di non voler rispondere. I senatori si sono ritrovati a pregarle: non siete sotto processo, vogliamo capire se potete dirci qualcosa di utile. Ma le magistrate sono rimaste per un’ora e mezzo solo per ripetere sei volte che quello che c’era da dire è nella sentenza. A complicare le cose c’è che il terzo del loro collegio, il presidente, era Germano Lamberti, anni dopo condannato a 4 anni e 9 mesi per corruzione in atti giudiziari.
In commissione hanno ascoltato Mauro Valli, uno degli ormeggiatori del porto che salvarono l’unico superstite del traghetto (il mozzo Alessio Bertrand). Valli urlò alla radio: “Il naufrago ci dice che ci sono altri naufraghi da salvare”. E’ registrato, ma al Senato Valli ha raccontato di non averlo mai detto. Ha aggiunto che le trasmissioni radio non subirono interferenze, mentre il canale d’emergenza quella sera era una babele di lingue e voci strozzate. Ha sostenuto che fu assicurato un coordinamento dei soccorsi, mentre fu il capitano di un’altra petroliera a svegliare la Capitaneria: “Evidentemente non avete ancora capito la gravità della situazione”.
Sul Moby morirono cittadini di 45 province. Una storia italiana. Quindi ignorata, sottovalutata, a partire proprio dall’sos mai sentito. La commissione potrebbe chiedere di nuovo i tracciati radar agli americani, visto che Camp Darby – la base più grande del Mediterraneo – era a due passi e Livorno quella sera era “assediata” da navi militarizzate di ritorno dalla guerra del Golfo. L’Italia del 1991, come oggi, era legata a Washington. I magistrati chiesero immagini satellitari ai vertici militari italiani, russi, cinesi e soprattutto statunitensi. E nessun satellite – fu la risposta – degnava Livorno di uno sguardo. Il pm Luigi De Franco – che in commissione ha parlato – andò da Giulio Andreotti per chiedere aiuto: il segretario del capo del governo gli rispose che “difficilmente avrebbero potuto darli, perché spiare era vietato dal trattato Nato”. Ma ci sono 140 morti, ribatté il magistrato. “Fanno le guerre, figuriamoci cosa gli interessa” si sentì rispondere.
L’Ustica del mare, l’hanno chiamata. Con la differenza che tutti sanno cos’è Ustica. E’ per esempio una cicatrice che Livorno dovrebbe portare sul volto, mentre quella città sempre pronta a scaldarsi per battaglie di civiltà ebbe l’atteggiamento di chi voleva dimenticare subito una storia che gettava una luce obliqua sul proprio porto, cioè sul proprio cuore. Nessun sindaco si è incatenato: cortei e fasce tricolori. Nessun parlamentare si è battuto. “Neanche a me – dice l’ex pm – tornava il fatto che non si riuscivano a trovare persone che potevano riferirci sulla presenza della nebbia in una serata di aprile: non è venuto nessuno, non è venuto un testimone a dirlo”. E’ una storia italiana, trattata come gli italiani sanno fare. Se le inchieste giudiziarie non hanno dato risposte è per inquinamenti e depistaggi, ma anche per sciatteria, impreparazione, sottovalutazione. I soccorsi condotti in modo penoso (altro che coordinamento) furono non solo il centro, ma l’icona. Furono una “baraonda straordinaria” come la definì la Procura quando archiviò l’inchiesta bis nel 2010. Ma a quella conclusione c’era arrivato il capo delle capitanerie, l’ammiraglio Giuseppe Francese: “Un coordinamento efficace dei soccorsi si realizzò 6 ore dopo la collisione”. Lo scrisse 20 giorni dopo la strage. Eppure il pm del 1991 l’ha scoperto da un’audizione in Senato. Un mese fa. “Non sapevo che esistesse”.
Da Il Fatto Quotidiano del 4 aprile 2016