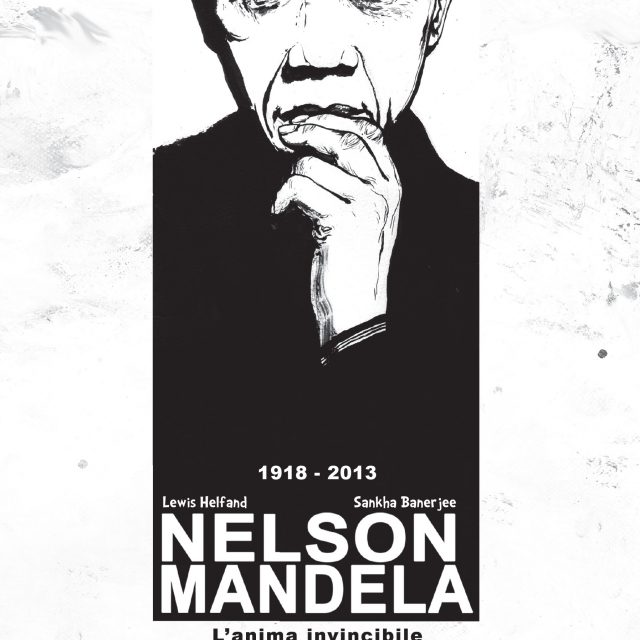Su Twitter ha 11,2 milioni di follower: praticamente la popolazione di Cuba. E sui social è esattamente come è nella vita o sulle scene: un pazzo scatenato che non ha problemi a esporre idee anche controverse, sicuramente distanti dalla “politeness” tipicamente inglese. Lui è Ricky Gervais, “il Woody Allen inglese” (la definizione è del Guardian): attore, comico, regista, sceneggiatore, scrittore, produttore e, in passato, persino pop star. Ha 54 anni, e in carriera ha vinto tre Golden Globe, due Emmy, sette BAFTA, cinque British Comedy Awards e altre decine di premi “minori”. Un curriculum che definire prestigioso è eufemistico, per un artista che in Italia è ancora poco noto rispetto a quanto meriterebbe. Magari qualcuno di voi lo ha conosciuto nelle ultime settimane, dopo i tweet entusiasti sulla serie Gomorra (definita da Gervais “forse la migliore serie televisiva dell’ultimo decennio”).
Ma ci sarebbe molto altro da conoscere sulla carriera di un genio della comicità che ha conquistato anche gli Stati Uniti, oltre alla natia Inghilterra. Il successo vero, quello mainstream, è arrivato nel 2001 con l’esordio sulla BBC della serie The Office, la sitcom ideata insieme a Stephen Merchant che ha avuto così tanto successo da meritarsi, negli anni, una versione americana (dal 2005 al 2013, con Steve Carell), una francese (Le Bureau) e una tedesca (Stromberg). Italia non pervenuta, tanto per cambiare. Da The Office in poi, gli americani si sono innamorati di Gervais, a cui hanno affidato addirittura la conduzione di ben quattro edizioni dei Golden Globe. Conduzioni solitamente memorabili, perché il comico inglese non ha mai avuto problemi nel dire quello che pensava, magari mascherandolo da sketch scherzoso. Politicamente scorretto, con un bicchiere di vino in mano, Gervais ha persino ringraziato Dio di essere ateo, dal palco dei Golden Globe. Che per un newyorchese o un californiano può anche andar bene, per carità, ma tutta l’America che sta tra le due coste probabilmente sarà sobbalzata sul divano.
Negli anni, Gervais ha firmato altri piccoli e inusuali capolavori televisivi: Life’s too short, per esempio, è un mockumentary spassosissimo che racconta la finta vita dell’attore inglese (e nano) Warwick Davis, alle prese con una carriera che non decolla e tante, troppe, miserie quotidiane. Gervais e Merchant, che interpretano se stessi, sono i cinici e scorrettissimi “carnefici” del povero Davis, che dovrà subire battutacce, cliché, stereotipi sul suo essere nano (e soprattutto sul suo essere un attore fallito). In Inghilterra la sit-com non è piaciuta granché, ma in Italia (dove è stata trasmessa da SkyArte) è rivoluzionaria. Appropriarsi degli stereotipi e demolirli è la cifra stilista dell’iconoclasta Ricky Gervais. E in fondo è quello che ha fatto anche in Scemo di viaggio (An Idiot Abroad, nella versione originale). Gervais e Merchant ancora nel ruolo dei sadici, mentre Karl Pilkington è il malcapitato mandato in giro per il mondo ad affrontare le proprie tare mentali e i propri luoghi comuni sulle culture e sui paesi diversi dal Regno Unito.
Per non parlare di Derek, serie in due stagioni trasmessa in Italia da Netflix, che ha rappresentato forse l’episodio più polemico e controverso nella carriera dell’attore inglese. La serie racconta le quotidiane vicende di Derek, appunto, uomo non certo intelligente né brillante che lavora in una casa di riposo per anziani. Secondo alcuni politicamente correttissimi commentatori inglesi, la serie deriderebbe le persone con disabilità mentali. “Sembra più crudeltà pigra che satira”, ha tuonato Tanya Gold dalle colonne di The Guardian. In realtà, e non bisogna essere particolarmente cinici o crudeli per capirlo, il personaggio di Derek rappresenta la purezza di un essere umano senza sovrastrutture, dall’animo semplice e gentile, completamente scevro da furbizia o cattiveria.
Quasi tutte le serie realizzate da Gervais utilizzano la tecnica del mockumentary, il falso documentario. È il suo tratto distintivo, ma forse il genere è logoro e l’attore inglese rischia di ripetere se stesso fino allo sfinimento. Quest’anno, forse proprio per cambiare un po’ aria, è stato protagonista con Eric Bana del film Netflix Special Correspondents, in realtà assai deludente e giustamente massacrato dalla critica. Il problema è che Gervais non rende quando deve seguire un copione tradizionale. Forse è per questo che utilizza il mockumentary, forse è per questo che le cose migliori le fa sul palco del Golden Globe, mentre sorseggia del vino e sputa parolacce in faccia ai più grandi divi hollywoodiani. Ricky Gervais è come quelle compassate e anzianotte signore inglesi che, quando esagerano col cherry, cominciano a dire cose irripetibili e a sfogare tutta la crudele sincerità che solitamente nascondono sotto la patina di esasperante politeness tipicamente britannica.
Ma pur con tutti i passi falsi recenti di una carriera comunque clamorosa, con le polemiche continue e le liti fanciullesche sui social network (per la cronaca: trattasi del secondo vip britannico più odiato sui social dopo Piers Morgan), Ricky Gervais è un meraviglioso esempio di come si possa diventare una star globale anche senza svendere più di tanto l’essenza originaria del proprio talento. Scorretto, irregolare, a tratti insopportabile e supponente: è l’uomo Gervais a essere così, prima ancora che l’artista. Non ha paura a dire quel che pensa e ne paga personalmente le conseguenze. Avercene dalle parti nostre, signora mia.