Napoli Teatro Festival Italia, un mese di programma (tutto al chiuso)
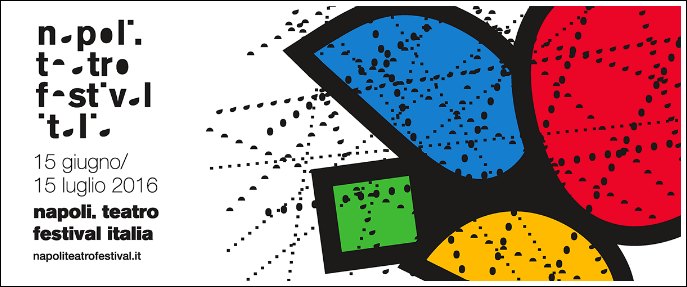
Qualcuno di importante diceva che Napoli è un teatro a cielo aperto. Allora non è comprensibile chiudere il pubblico dentro asfissianti forni boccheggianti, i teatri cittadini, bellissimi ma senza aria condizionata (il dolo è il gadget del ventaglietto di cartone), invece di utilizzare gli spazi che intorno alla città si aprono come fiori alla vista del sole. Parliamo del Maschio Angioino o del Real Albergo dei Poveri, di Castel dell’Ovo o il Vomero, solo per citarne alcuni. La scelta di inserire gli spettacoli del Napoli Teatro Festival Italia (debordante un mese di tenitura, non una rassegna, diviene la prosecuzione della stagioni dei vari teatri cittadini in un continuum senza sosta che annichilisce anche gli appassionati più feroci) all’interno di platee vellutate è da considerarsi come un “attentato” alla visione e fruizione delle pieces.
Da un lato il festival, costato tra i cinque e i dieci milioni di euro (le cifre, comunque da capogiro, si sa, ballano e sono ondivaghe e interpretabili, senza chiarezza né trasparenza) diviene una pioggia di contributi per le produzioni di compagnie e teatri della zona (spettacoli che poi, paradossalmente, saranno nelle stagioni ufficiali l’anno prossimo). Altri fondi ricadono sulle strutture attraverso altissimi affitti. Insomma tutta la Napoli teatrale ci guadagna. Si dice che tra il presidente Luigi Crispello e il nuovo direttore artistico, l’italo-belga Franco Dragone (uno con un portfolio di pubblico di 80 milioni di spettatori – si è avvalso della consulenza di Antonio Audino e Jean Louis Colinet – l’aria sia elettrica, per usare un eufemismo, e che non siano propriamente sulla stessa lunghezza d’onda di pensiero e vedute, con il primo che punta a rinsaldare il locale e l’altro deciso all’apertura europea.
In questo secondo solco abbiamo avuto la fortuna di imbatterci nell’opera portentosa di James Thierrée, nipote di Charlie Chaplin, anche se non ama che il suo nome venga associato a quello del mostro sacro. In una epifania di infiniti fili e cavi, si aprono a corolla isole galleggianti sospese nel vuoto, astronavi e carrucole, polpo dai tanti tentacoli, sorta di meduse che fluttuano e galleggiano a mezz’aria, il tutto sembra riportare ad un mondo sotto il livello del mare, quasi da Sirenetta. In questa parentesi assurda e fantastica, “La grenouille avant raison” ricorda Avatar, Il Signore degli Anelli e Fantasia, De Chirico o le scale di Escher, visionaria e immaginifica, in questo futuro archeologico, polveroso e antico, figure misteriose, pianista, mozzo, cantante, contorsionista-apneista con un controllo del corpo strabiliante, sembrano attratti e catapultati da forze misteriose. Un condominio irrazionale dove la normalità è composta da magie, incantesimi, alchimie, sortilegi, tutto è capovolto in questa resistenza dell’uomo nei confronti di una Natura ingestibile, illogica e contraddittoria.
Come perle rare anche i due piccoli segni tracciati da Alain Moreau e dal suo Tof Theatre (qualche anno fa abbiamo visto “Bistouri”, esaltante) il primo di mezz’ora, il secondo di un quarto d’ora. Anche se molto differenti l’uno dall’altro, il primo “Soleil Couchant” più delicato e commovente, il secondo “Dans l’atelier” più rock e muscolare, hanno entrambi il tratto comune della creazione artistica, il manichino-fantoccio che si ribella al suo deus ex machina, a chi lo ha creato, colui che lo ha messo al mondo, come Frankenstein, come Pinocchio con Geppetto. In “Soleil” un anziano, che Moreau abita entrando dentro braccia e gambe e lasciando indipendenti tronco e testa, pare un mix estetico tra Camilleri e Napolitano, con pochi sottili gesti ci racconta con dolcezza struggente il suo fine vita; su una spiaggia aspetta la sera, il tramonto della propria esistenza, con sé ha una vanga per seppellirsi o per ripararsi in una trincea perché sente che la sua clessidra ha esaurito la sabbia.
Sul fronte campano di qualità è il nuovo di Punta Corsara che prende a prestito l’intramontabile hit di Gino Paoli. “Il cielo in una stanza” ci riporta subito alla scena de La Grande Bellezza di Sorrentino dove al posto del soffitto si apre il mare della gioventù dove nuotare felici e nel pieno delle forze. In un interno distrutto e disagiato, squassato e claustrofobico di macerie (tra Scimone e Sframeli e “Le voci di dentro”) un edificio si mostra a flash back, in un rimpallo-palleggio tra gli anni ’50 e i ’90. Emanuele Valenti e Armando Pirozzi ritagliano parole cadenzate tra il feroce Schwab, l’appuntito Bernhard, l’inquietante Pinter in questo palazzo dove tutti sono sepolti ma nessuno vuole cedere andandosene. Sotto cumuli labirintici di cunicoli e mura crollate sta il popolo napoletano, ma potrebbe essere ampliato a quello italiano, in questo girone dantesco di chiusure e burocrazia, se ne stanno sotterrati in equilibrio precario vivendo alla giornata, vittime impotenti di una cappa che li blocca nell’immobilismo, tra senso di colpa e vittimismo, voglia di cambiare e intima convinzione dell’impossibilità del mutamento che frustra prima dell’azione: “Perché in questa città deve finire tutto alla De Filippo, tutto in farsa?”. Napoli intanto risplende, limite e grandezza dei napoletani.