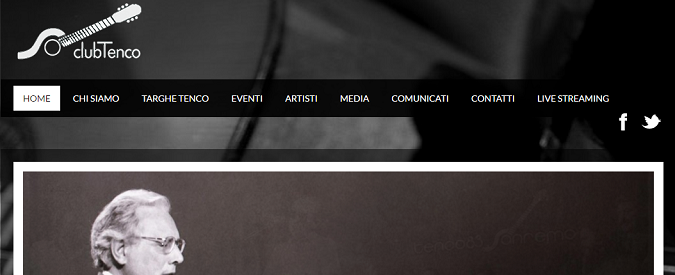Francesco Motta, col disco “La fine dei vent’anni”, si è aggiudicato la Targa Tenco Opera Prima 2016, grazie a un vantaggio abissale sul secondo classificato. A parer mio, il disco artisticamente vale la cinquina finale, ma sotto il punto di vista della scrittura non merita di certo la vittoria. Perché? Vediamo.
Motta è un esponente esemplare del cosiddetto “indie”, che alcuni vedono come un vero e proprio genere; io non credo lo sia, semplicemente perché esiste sempre, solo e soltanto in contrapposizione a qualcos’altro. Anzitutto, poi, bisognerebbe scindere storicamente il mondo indipendente italiano dall’indie inteso come genere di oggi. Non è un dettaglio: deve essere il punto di partenza. L’autonomia che l’indie italiano esprime oggi non è più riferita ai meccanismi commerciali ingerenti nella forma delle canzoni, nell’immagine o nella scelta dei luoghi in cui cantare, ma è un’attitudine al fatto di sentirsi incompresi. Questo può esprimersi in vari modi: a volte con i superficiali giochini di parole di Dente, quasi a esorcizzare l’eredità pesante e monumentale dei cantautori italiani storici; altre volte con un muro di suono perfettamente calibrato e spesso dalla scrittura poderosa, che permetta e giustifichi l’incomunicabilità, per far sì che la voce nel tutto diventi inudibile, coerente con una realtà sociale che esalta la verticalità e la solitudine di rapporti interpersonali al computer: diventa dunque un modo per crearsi l’alibi nel sentirsi incompresi.
Uno degli elementi che più hanno fatto la fortuna della canzone d’autore è stato il concepire il brano come una comunicazione del tutto orizzontale, come un veicolo per dire chiaramente le cose in faccia a chi ascoltava. Buona parte del mondo indie capovolge la situazione: «Soffro: cosa provo e quanto sto male posso saperlo solo io». Tutto questo potrebbe sprigionare una forza altrettanto degna d’essere messa in canzone e tradotta in suoni e parole; il guaio è che spesso quest’attitudine basta a se stessa.
Così come la voce fa il solo sforzo di risalire la verticalità dell’io e confondersi nel marasma degli altri suoni – pregiudicando il movimento orizzontale verso l’altro –, la capacità di scrittura non è necessaria; quando non si tratta d’impressionismo aulico forzato, e ostentato gratuitamente, si esaurisce in poche frasi ripetute con ostinazione. E non parlo solo del testo, ma di rapporti sorprendenti tra parole e melodia, di armonia che in maniera virtuosa e inaspettata guidi e governi la sintassi dei versi. Parlo di strumentazioni, timbri e volumi dei suoni che si inseriscano in questi rapporti: parlo, in breve, di padronanza della scrittura dell’arte-canzone; il più delle volte quest’aspetto è ininfluente. Spesso l’attenzione per la musica è maniacale, dovuta anche alla presenza di produttori artistici virtuosi e competenti, ma i rapporti significanti con l’architettura d’impianto del brano, col racconto testuale e con i suoni strutturali è pretestuosa, didascalica o assente. Oppure serve solo a sostituirsi alla mancanza di forza della stessa struttura.
Ciò che distingue Motta è invece proprio la sua voce: mostruosa, monumentale, artisticamente commovente. Nel bel mezzo della tensione verticale, di ciò che nel suo caso è a volte vera e propria frenesia sonora che potrebbe coprire quello strumento di comunicazione interpersonale, soprattutto dal vivo la voce di Motta arriva chiara e forte, e rappresenta così, già da sola, ribellione artistica alla società, che squarcia l’attitudine indie all’incomunicabilità e ritrova prepotentemente la stessa storica forza orizzontale della forma-canzone tradizionale. Ma nei contenuti non fa che esprimere raccapriccio, vivendo sempre di luce (nera) riflessa dall’invivibilità del mondo. La scrittura quindi il più delle volte latita, così per esempio nell’ascolto dal vivo il tutto si esaurisce al terzo o quarto brano.
Proprio per questo, se “La fine dei vent’anni” vuole essere preso come un documento che testimoni un’epoca, la Targa Tenco a Motta ci può stare. Se si vuole essere più esigenti, e io lo spero, bisogna aprire una riflessione. Io credo che il vero problema della canzone d’arte oggi in Italia sia proprio la scrittura. I cantautori dovrebbero tornare a scrivere e cantarsi canzoni che propongano una propria originale visione del mondo, e che strutturalmente stiano in piedi da sole: tanto nell’impianto essenziale del pezzo, quanto nella capacità di performance. Avvenne a cavallo tra gli anni Sessanta e i Settanta e oggi la più riuscita canzone d’autore, anche sofisticatissima nei suoni e negli arrangiamenti, deriva da quelle saldissime fondamenta. Buona parte dell’indie, invece, si presenta come un castello dalla mole imponente, ma transitorio e basato sulla sabbia.
Articolo Precedente
Oasis, i fratelli Gallagher arrivano al cinema con il lungometraggio ‘Supersonic’: il 7,8 e 9 novembre nelle sale italiane

Articolo Successivo
Diego Mancino, belle canzoni vivide, solide e retrò nel suo nuovo album “Un invito a te”