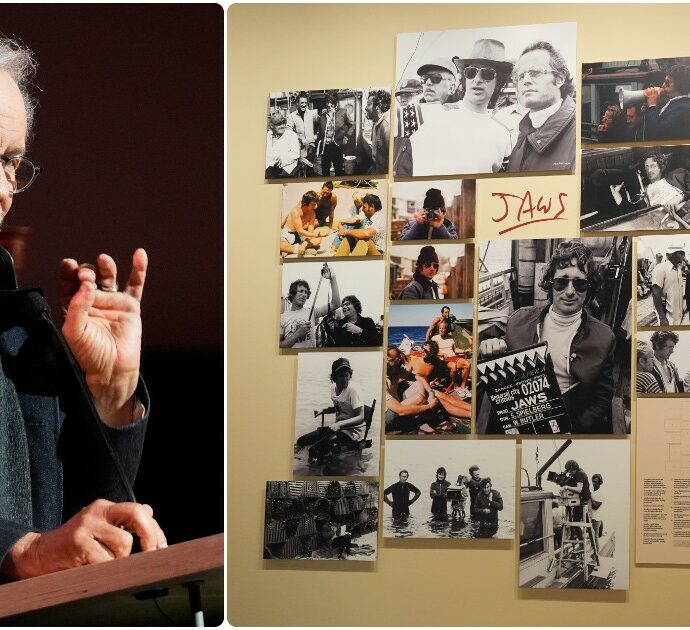Dal 1 dicembre 2016 ognuno di voi amerà, e adotterà, il piccolo Courgette con il suo aquilone giallo. Dopo tanta ricerca tra le uscite hollywoodiane, Pixar compresa, il film d’animazione dell’anno s’intitola La mia vita da zucchina. L’ha diretto il regista svizzero Claude Barras, al primo lungometraggio, coadiuvato dalla “sensibilità” adolescenziale della regista francese Celine Sciamma (i capolavori Tomboy e Diamante Nero riluccicano ancora in lontananza) allo script. Una produzione franco-svizzera che mette in primo piano l’artigianalità della stop motion, oramai diventata “genere” a sé con buona pace di Willis O’Brien e Ray Harryhausen (e soprattutto della Aardman Animations). Al centro della storia troviamo il decenne Zucchina/Courgette, capelli blu, naso e orecchie rosse come ciliegie, padre morto e madre alcolizzata. Dopo l’ennesima disgrazia in famiglia il ragazzino finisce in orfanotrofio modello casa famiglia. Lì troverà altri cinque compagni amici/nemici, angherie dolorose per iniziare, abbracci e legami forti nel prosieguo, la piccola e ribelle Camille a chiedere spazio nel cuore, il poliziotto buon Raymond chioccia salvatrice a creare uno spazio fuori dall’istituto.

Impossibile riassumere questa delicata e armoniosa composizione formale fatta di scenografie minimali, stilizzazione dei dettagli pop (la t-shirt verde con stella rossa, le pettinature iperattuali, scarpe, coperte, graffiti sui muri), espressività sintetizzata con grazia con pochi movimenti di occhi, bocca e mani. Già perché la stop motion di Barras – due anni di lavoro, 60 scenari costruiti e dipinti, sedute di set per otto mesi al ritmo di 3 secondi al giorno per ciascun animatore – è un passo uno con pupazzetti alti 25 centimetri, costruiti combinando materiali diversi (schiuma di lattice per i capelli, silicone per le braccia, resina per il viso, tessuti per i vestiti cuciti a mano) avvolti attorno ad uno scheletro articolabile adattato alla morfologia di ogni personaggio.
Il risultato ha qualcosa di amabilmente antico ma anche di abilmente contemporaneo. All’interno dei pupazzetti si muove e vibra una sorta di cordicina che dà vita, parole e anima candida a questi ragazzini finiti in un orfanotrofio che, contrariamente a I 400 colpi di Truffaut, a cui comunque il film s’ispira poeticamente come libero a anarchico canto doloroso del reale, diventa una casa che ripara i bimbi dalla bruttezza e dal cinismo del “fuori”. “A mio avviso c’è una stretta ed evidente relazione tra il background di realismo sociale vissuto dai protagonisti e la forma molto concreta di animazione stop-motion radicata nella realtà materiale usata nel girare. È una tecnica dura e faticosa che a differenza di altre tecniche digitali non permettere di cambiare nulla dopo le riprese”, ha spiegato Barras a Variety durante l’ultimo Festival di Cannes dove l’opera era stata inserita nella Quinzaine des Realisateurs.
Il film di Barras ha poi una sua straordinaria comunicabilità in termini di linguaggio aperto e privo di censure lessicali (sul sesso ad esempio), come sulla ricostruzione della realtà disagiata e marginale, nella fattispecie la figura dell’ “orfano”. Non gli scugnizzi sporchi di una bidonville lontana, ma i ragazzini di una qualunque città europea con il loro iPod e zainetto identici a quelli dei loro coetanei più fortunati a livello familiare. “Possiamo dire che questo è un film sull’infanzia più che un film per bambini. Un melodramma sull’infanzia pieno di emozioni e umorismo, un film d’animazione dal realismo sociale”. Distribuisce Teodora