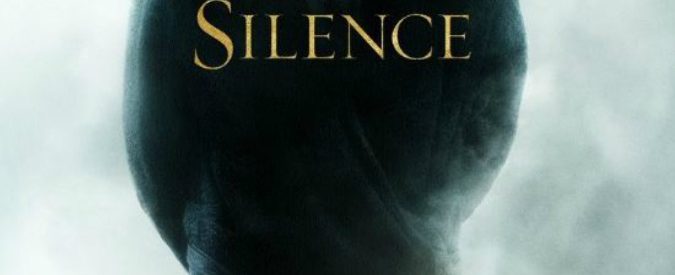Silenzio, parla Martin Scorsese. Sussurri impercettibili e forse un paio di grida, sottovoce come in un’infinita giaculatoria, il suono interiore, drammatico, ieratico di Silence sembra come arrivare prima dei suoi fotogrammi. Schermata nera con un lieve frinire di cicale, poi un’inquadratura fissa, esterno giorno seicentesco giapponese nebbioso e piovoso, silenzio assoluto in scena, pose plastiche attoriali di guardie e samurai in shitagi e geta, e là appesi, crocifissi, umiliati e torturati i preti martiri che vollero introdurre e propagare il cattolicesimo a scapito del Budda e di una tradizione feudale politicamente intransigente. Scorsese inizia così la sua venticinquesima regia. Sofferta, dolorosa, lunghissima gestazione per un film concepito quasi trent’anni fa e continuamente rimandato.
Chissà se è stata la volontà di Dio, il destino, o la semplice curvatura della linea di un orizzonte autoriale sempre imbevuto di un rapporto intenso, intimo e grondante sangue con l’altissimo, a datare Silence nell’anno domini 2016. Perché un conto sarebbe stato girare questo film a fine anni novanta con Scorsese cinquantacinquenne, e un altro discorso girarlo oggi ad oltre settanta. La storia ambientata primariamente nel decennio che va dal 1630 al 1640, e vede due frati cattolici portoghesi padre Rodrigues (Andrew Garfield) e padre Garrpe (Adam Driver) approdare pericolosamente in Giappone per trovare tracce dello scomparso padre Ferreira (Liam Neeson), testimone delle crudeli torture inflitte ai cristiani che non hanno voluto abiurare la loro fede, è un testo adatto ad un devoto e tenace credente come Scorsese ma solo se giunto alla tarda età. Intendiamoci subito: i poveri “cristi” degli albori filmografici del nostro, pensiamo al David Carradine crocifisso al vagone di un treno in America 1929, erano personaggi animati da un’attitudine mistica in cui si mescolavano miseria e predestinazione. Figure politiche prima di ogni cosa, dilaniate da sensi di colpa totalizzanti, e animate da una propensione distruttiva espletata e sputata fuori dal corpo con atti criminali e successiva redenzione.
Qui in Silence il fervore del credo si fa invece tutto interiore, la solennità di una fede individuale che pulsa di proselitismo ma che deve rimanere nascosta, isolata, invisibile, quasi impalpabile, tra i boschi, le rocce e le casupole del Giappone feudale. Rodrigues e Garupe non possono essere visti dalle autorità. Scappano. Fuggono. Si separano. Vengono catturati, ingabbiati, torturati. Diventano, al contrario, per i potenti inquisitori giapponesi i simboli generali e pubblicizzabili di una possibile abiura, di un’iconoclastia esemplare da mostrare al popolo contadino che sotterraneamente anela al battesimo e al padre nostro. Ecco allora il perché della varie fasi della vita in cui si realizza un film. Solo lo Scorsese 75enne poteva buttare a mare l’ipercinetica dinamicità dei suoi furiosi gangster per avvicinarsi all’estasi e al tormento tutti conficcati nell’ossessione interiore e immobile, priva di gesti estremi e violenti di padre Rodrigues, catechista che rievoca più il concetto di trascendenza dell’amato compagno di Taxi Driver, Paul Schrader (cosa sarebbe potuto essere Silence con Schrader allo script invece del più dozzinale, soprattutto nei dialoghi, Jay Cocks, dio solo sa…), che l’egoico broker DiCaprio, anche lui redento, sia mai, anche se fuori tempo massimo rispetto alla linea d’autore di zio Marty.
Però qualche appunto a Scorsese va pur fatto. Perché Silence non può e non deve essere collocato nella fascia alta dei suoi film (Taxi driver, Quei bravi ragazzi, America 1929, Al di là della vita, Fuori orario), come del resto nemmeno in quella speculare e bassissima degli stopposi Shutter Island o Hugo Cabret. Tecnicamente il film sfugge un po’ di mano a Marty, soprattutto tra la mezz’ora e l’ora di girato, dove la rarefazione della narrazione cede il passo a qualche anonima genericità nei raccordi di montaggio e dove l’inquadratura nelle scene con più di tre persone in campo sembra ricalcare un qualsiasi film storico hollywoodiano post 2000. Stesso discorso per l’esposizione di una tesi non proprio sotterranea, di una sterzata teologica evidente, di uno Scorsese più cattolico che cristiano come non mai, che si getta nel ginepraio dello scontro religioso (il confronto col buddismo, dell’abiura/non abiura), soprattutto negli ultimi tre quarti d’ora di film, che fa affiorare un fondamentalismo pericoloso e fuorviante rispetto al corpo centrale e al testo intimo ed individuale dell’opera. La tagliente, ruvida e impagabile cristologia scorsesiana non ha mai avuto bisogno di supporti istituzionalizzati per dare forza al proprio credo. Il curato di campagna bressoniano che sembra ricalcare come un sudario questo padre Rodrigues di Silence continua a morire tra puttane e preti spretati, non in cappelle o cripte reali. Non a caso la compressione narrativa della vecchiaia del protagonista de-cattolicizzato riserva una zampata finale che solo Bresson avrebbe potuto girare. E allora tutto torna. Il vecchio Scorsese sfiora cristianamente lo Scorsese degli albori. Chiudiamola qui. Senza altre deviazioni che potrebbero far deragliare memoria e storia di uno dei cinque (sei? sette?) registi più grandi al mondo.