Università, l’inglese è il futuro? E se parlassimo solo con le emoticon?
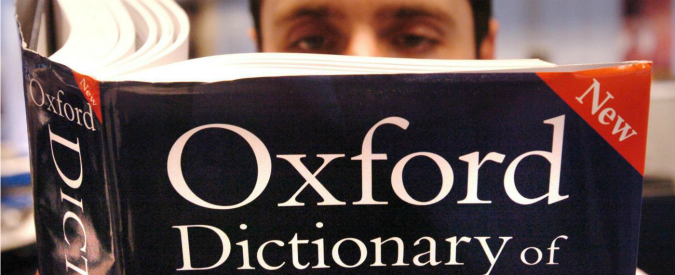
Una recente sentenza della Corte costituzionale argina la prepotenza della lingua inglese quale lingua esclusiva dell’alta formazione universitaria. Una visione monodimensionale, monopolistica e manichea dell’Accademia che da qualche tempo imperversa in Italia, forse guidata da uno dei tanti sensi di colpa della mia generazione. E ritenuta indispensabile da chi interpreta l’università come impresa, con riferimento esclusivo al modello della corporate.
Se la flessibilità del lavoro, della morale e dello spazio pubblico sono valori indiscussi, allora perché non adottare la stessa flessibilità nei laboratori didattici, dove l’insegnamento è dialogo? E porre l’italiano e l’inglese e, se necessario, lo spagnolo e il portoghese sullo stesso tavolo di lavoro? Ogni forzatura, soprattutto se linguistica, allontana dalla conoscenza e impoverisce il frutto del lavoro individuale e collettivo.
Insegnare Statistica in inglese pone pochi problemi, giacché ogni dieci parole c’è una formula o una equazione o un diagramma. E così è per chi impara. Quando ho scoperto che qualcuno aveva piratato, tradotto e stampato in cinese un mio testo di statistica ho anche realizzato che, in quella lingua, il testo si compattava enormemente e con un po’ di fantasia avrei anche potuto provare a insegnare usando quel libro: le notazioni simboliche erano del tutto preponderanti. E che la pirateria è sintomo di successo, anche se impoverisce royalties già striminzite.
Diverso è narrare la plurimillenaria storia idraulica del fiume Seveso o la complessa vicenda milanese di Leonardo da Vinci, chiamato da Ludovico il Moro perché bravo musicista e non in quanto idraulico provetto, qualità che acquisì soltanto in seguito proprio a Milano. Raccontare che, secondo Vasari, Leonardo stupì il pubblico suonando una lira d’argento a forma di teschio di cavallo non è semplice se devi farlo in manglish, il macaroni-english così battezzato da un collega della Princeton University che si riferiva al linguaggio di un giardiniere di lontana origine italiana. Lo conobbi anch’io: era capace solo di biascicare un arcaico siciliano o un inglese molto, ma molto essenziale e privo di qualunque intonazione. Perché noi italiani abbiamo enorme difficoltà a parlare con una giusta intonazione, in inglese anche più importante della pronuncia giacché l’intonazione è la componente fondamentale della comprensione verbale in quella lingua.
L’assioma che l’inglese sia la lingua universale del futuro è ardito. Nessuno dubita che il globish sia oggi la lingua scientifica, commerciale e finanziaria per eccellenza. E che l’eurish rimarrà la lingua ufficiosa dell’Unione Europea senza che l’inglese sia più tra quelle ufficiali, giacché quella irlandese è il gaelico. Ma domani? Se sul metro di Chicago, New York o Los Angeles le scritte sono da tempo bilingui, poiché lo spagnolo diventerà presto la lingua più diffusa negli Stati Uniti. Se il mandarino è già la lingua più parlata, almeno un miliardo di persone, mentre i social media sono invasi dalle emoticon. E se il futuro non sempre è quello una volta: il domani ci riserva magari l’abbandono dell’alfabeto per una qualche evoluzione delle emoticon.
Quasi 50 anni fa fui ospite di un ostello esclusivo di cultori dell’esperanto, la lingua che aspirava allora a diventare universale. Ricordo quella settimana come un incubo. Ognuno di noi sogna nella propria lingua e in quella lingua introietta la propria storia. Sapersi esprimere bene nel linguaggio universale è senz’altro indispensabile per stare al mondo, ma disconoscere la propria lingua non accresce l’autostima personale né quella di un popolo. E neppure quella della sua classe dirigente, soprattutto se abdica alla propria storia e al proprio io.