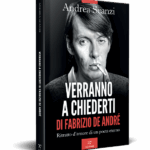New York
Intervistare Dio non è facile. E Roger Waters, un po’, Dio si è sempre sentito. In Animals rileggeva il Salmo 23 tramutando l’Onnipotente in un Signore spietato col suo gregge (cioè noi). In Amused To Death asseriva che Dio voleva i massacri e la jihad. Anche nel nuovo disco si immagina di essere Dio. Un Dio che non riuscirebbe a essere drone, perché commosso dalle morti che provocherebbe: un Dio che, il giuncastro, proverebbe a usarlo un po’ meglio. A venticinque anni dal precedente album di inediti, il creatore di The Wall torna con Is This The Life We Really Want?, in uscita il 2 giugno per Sony Music (in Italia il primo giugno). Un disco d’altri tempi, di bellezza dolorosa e vertiginosa, con vette inaudite e l’universo watersiano di sempre: gli orologi, le bombe, i gabbiani, la guerra, il padre (qui meno del solito), i cani, la tecnologia, l’urlo (quel suo urlo), la radio, la tivù accesa, i cori. E una voce mai così profonda e definitiva. Colpiscono l’assenza di assoli e il ruolo quasi marginale delle chitarre: niente David Gilmour (pare che Waters e Goldrich volessero coinvolgerlo con due assoli, ma poi non se ne sia fatto di nulla). Niente Eric Clapton, presente nel primo disco solista. Niente Jeff Beck, semplicemente monumentale in Amused To Death. E niente Snowy White, che lo accompagnava già nel tour di Animals. E’ un disco nato con Nigel Godrich, storico produttore dei Radiohead e non solo. L’effetto finale ricorda quello tra Johnny Cash e Rick Rubin per il ciclo sublime delle American Recordings.
Waters detesta le interviste. Da sempre. Il Fatto Quotidiano è l’unica testata italiana ammessa al suo cospetto, addirittura col permesso di riprendere venti minuti (dei circa trenta complessivi) con due telecamere: la trovate qui. Waters colleziona spigoli, dentro la sua testa c’è una galassia infinita di cicatrici che hanno generato la meraviglia immortale dei Pink Floyd. Durante l’intervista gli capita di incupirsi e irrigidirsi. E’ come se, di continuo, i suoi occhi fossero attraversati da nubi foschissime. Che percepisce solo lui, poiché palesemente ipersenziente. Non a caso Nick Mason disse: “Quando Roger lasciò i Pink Floyd, ci sentimmo come l’Unione Sovietica dopo la morte di Stalin”. Ci sono argomenti che detesta toccare (il passato coi Pink Floyd, il rapporto con Gilmour) e altri di cui parlerebbe per ore (il padre, il presente). Intervistarlo è come stare sul ring e sperare che il campione che hai davanti, prima o poi, lasci sguarnita la difesa. Devi fare breccia e non è facile. A un certo punto accade. A metà intervista pare rasserenato, per quanto uno come lui possa esserlo. Sorride, addirittura. E poi torna corrucciato. Dio è così: non fa sconti. Vede doppie apocalissi ed è sopravvissuto a fatica allo sbarco di Anzio. Il lunatico è ancora nell’erba, il diamante è sempre pazzo. Ma risplende ancora. Cronaca di un incontro ravvicinato a New York con un genio inaudito.
Nel nuovo disco, così come in Animals, l’amore non è evasione ma catarsi e salvezza. Nelle sue opere c’è un’alternanza brutale tra “l’amore che giorno dopo giorno invecchia come la pelle di un moribondo”, come cantava in The Wall, e l’amore che assurge a unico “rifugio dai porci volanti”.
Per me è indubbiamente così. Se abbiamo la fortuna di vivere l’amore per una donna, un amore romantico ma anche di altri tipi, esso ha un effetto trascendentale su tutti gli aspetti dalla nostra vita. Nell’ambito di una relazione con una donna o un uomo, apriamo delle parti di noi che aumentano le nostre possibilità di essere empatici verso gli esseri umani in generale. Questo ci dà la possibilità di esprimere le nostre energie per entrare in empatia con gli altri e aiutarli, anziché entrare in conflitto con loro. E’ importantissimo per ognuno di noi, ma potenzialmente anche per il pianeta che stiamo distruggendo. Dobbiamo usare le nostre energie per capire come rendere sostenibile la vita per tutti e non solo per quei pochi come Trump, che sono potenti e ricchi, ma anche pazzi e disturbati in modo preoccupante.
Ha detto che, in origine, Is This The Life We Really Want? nasce come radiogramma.
Il primo brano l’ho scritto durante l’ultimo tour di The Wall (2010-2013). Si intitola Déjà vu, ma all’inizio si chiamava If I Had Been God (Se fossi stato Dio). Ho poi scritto un radiodramma, in cui un vecchio irlandese porta il nipote in un giro del mondo immaginario per trovare risposta ad alcune domande fondamentali che il nipote si faceva. Ad esempio: “Perché vengono uccisi i bambini?”. L’ho proposto a Nigel Godrich e da lì siamo partiti.
A quel punto il disco, come ha raccontato a Jon Pareles, ha preso un’altra piega.
Il radiogramma è rimasto solo all’inizio e alla fine. Lo definirei un viaggio che parla della natura trascendentale dell’amore. Di come l’amore ci può aiutare a passare dalle nostre attuali difficoltà a un mondo in cui tutti possiamo vivere un po’ meglio.
C’è l’amore, ma c’è anche una ricognizione impietosa dell’umanità. Che sembra essere persino più incarognita di quanto già non lo fosse in The Final Cut e Amused to death.
Lei dice che siamo messi peggio di prima? Ha avuto questa impressione?
L’ho avuta ascoltando il disco. E più in generale vivendo questo presente.
Forse per certi aspetti sì, non abbiamo fatto grandi passi avanti per migliorare le cose. Siamo ancora legati all’idea che possiamo raggiungere lo scopo solo con la guerra. È stato evidente negli ultimi 25 anni, e forse già alla fine della seconda guerra mondiale, che nessuna guerra ha mai portato risultati. Eppure, per noi, è difficile accettare questa idea. Quando dico “noi”, in verità non intendo noi, perché la gente l’ha capito. Per esempio. Il 14 febbraio 2003, 20 milioni di persone in tutto il mondo sono scese in piazza a manifestare per cercare di convincere i nostri governi, in particolare il governo britannico e statunitense, a non invadere l’Iraq. Ma a quanto pare la lezione non è stata imparata.
Definisce Trump “nincompoop”: un “citrullo”.
Lo chiamo “nincompoop” a ragion veduta, perché il termine deriva dal latino “non compos mentis”, cioè incapace di intendere e di volere. Una definizione che gli si addice.
In The Fletcher Memorial Home (1983) immaginava la creazione di una casa di riposo per ex dittatori e statisti abietti, perfetta per Reagan, “Maggie” Thatcher, il fantasma di McCarthy e i ricordi di Nixon. Trump ci starebbe bene.
Oh, molto bene. Sono certo che starebbe benissimo lì.
Dal precedente album di inediti sono passati 25 anni. Un po’ tanti.
Mi sa che non ho sentito lo sparo iniziale.
Si chiede mai se ci sarà posto per Roger Waters nella storia?
Non me ne frega niente.
Amused to death era un capolavoro, eppure non ha avuto il successo che meritava. Le pesa il fatto di essere anzitutto un “ex Pink Floyd” e poi Roger Waters?
Mi pesa? Aver fatto parte di un gruppo pop chiamato Pink Floyd non ha importanza, anche se mi dà una certa possibilità di esprimermi. Se non avessi fatto parte di una band così famosa, forse ci sarebbe meno interesse per ciò che faccio ora. Ma non mi importa delle etichette o del passato. Quello che faccio arriva alla gente oppure no: la gente capisce, apprezza le canzoni, ascolta questo disco oppure no. Preferirei che la gente lo ascoltasse. Sto ricevendo ottimi riscontri e ne sono felice. Nigel ha fatto un ottimo lavoro come produttore, penso che sia proprio un bel disco. Dice molte delle cose in cui credo.
A partire dalla canzone che dà il titolo al disco.
La poesia “Is This The Life We Really Want?” l’ho scritta 9 anni fa, nel 2008, e l’ho tirata fuori per trovare delle idee durante la realizzazione di quest’album. Erano versi destinati a rimanere un lungo sfogo scritto. Dentro c’è anche un monologo: è quasi rap. E’ poesia, non è nata come testo di una canzone. È una dissertazione. Ed è bello che sia poi finita sul disco.
La mano di Godrich, lì, si sente moltissimo.
È interessante che per quel brano sia nata prima la musica del testo. Ci ho messo tanto tempo, perché è molto difficile per me legare un testo a una musica preesistente. Su insistenza di Nigel, mi sono seduto in una stanza con gli altri musicisti, mi hanno dato un basso e poi: “OK, registriamo, chi ha scritto gli accordi? Pronti? Via!”. Joey ci ha dato il tempo e quella è l’unica take: l’unica take di noi quattro che suoniamo insieme. Ho suonato il basso su quella canzone solo una volta. Inizialmente ero reticente e poco convinto, ma Nigel ha molto insistito e ne sono felice. E’ venuta proprio bene: è proprio bella! Poi ho dovuto decidere il tema della canzone ed è stato lì che ho pensato: “Aspetta! C’è una vecchia poesia che forse potrei usare”. A questa poesia tengo molto. Ci tenevo nel 2008 e ci tengo oggi. Ed è così che il brano è nato.
Ha detto al New York Times che la cosa più difficile della lavorazione del disco è stato tenere la bocca chiusa quando Godrich dava indicazioni su cosa fare.
Quando ero in studio e magari Nigel lavorava con gli altri musicisti, facevo fatica a trattenermi. Non perché dicesse cose sbagliate, ma la tentazione di intromettermi era fortissima. Ho cercato di non farlo. Nigel ha tolto anche una canzone, e mi è spiaciuto molto. (Waters ha detto di avere già il materiale per un nuovo disco, che è intenzionato a incidere in tempi relativamente brevi, NdA)
Prima parlava del suo essere bassista. E’ vero che fu Eric Clapton, dopo l’uscita dai Pink Floyd, a convincerla di essere un buon musicista?
(stupito) Sì. Durante la realizzazione di The Pros and Cons of Hitch Hiking (1984) ero lì che dicevo: “Oh, non so suonare”. Eric mi disse: “Sciocchezze! Sei un grande musicista”. La cosa mi sorprese e fu anche di incoraggiamento, perché non mi ero mai visto come un musicista. Ma ora sì. So che ho il mio stile come bassista, uno stile a tratti stravagante, ma so che me la cavo. So suonare.
Bob Ezrin ha detto: “Roger è un grande artista, un ossessivo totale e il sogno di ogni psichiatra”. Oggi i suoi dischi non sono certo più sereni. Lei lo è?
Sì. Se si parla di quando abbiamo fatto insieme The Wall, sono decisamente più felice rispetto ad allora. Ora comprendo molte più cose. Sono diventato meno narcisistico, meno concentrato su me stesso e meno autobiografico. E mi interesso di più ai muri in generale, al modo in cui trattiamo gli altri. Comunque non vedo Bob (Ezrin) da 20 anni, è passato tanto tempo.
Una volta un veterano le ha detto: “Tuo padre sarebbe fiero di te”.
(commosso) Era verso la metà dell’ultimo tour di The Wall. Venne da me un signore anziano, mi tese la mano, mi guardò negli occhi e mi disse: “Tuo padre sarebbe fiero di te”. Fu un momento molto toccante. Mi fece capire che anche a distanza di anni, perché mio padre era morto da 70 anni o giù di lì, riuscivo ancora ad emozionarmi per il mio rapporto con lui.
Suo padre Eric Fletcher Waters, caduto il 18 febbraio 1944 a pochi chilometri da Anzio, c’è in ogni sua opera. Lo citava già in Free Four, ed era il 1972. Quando è morto, lei aveva cinque mesi.
Ho sempre pensato di dover essere alla sua altezza. Era un uomo coraggioso, non solo perché era obiettore di coscienza nel 1939 e si rifiutò di arruolarsi nell’esercito. Poi cambiò idea quando capì che il suo credo politico prevaleva sulla sua fede cristiana e decise che doveva combattere contro i nazisti durante la seconda guerra mondiale. È stata una figura eroica del mio passato e significa ancora tantissimo per me, il ricordo che ho di lui. Sì, è stato molto importante.
Syd Barrett e Richard Wright. Di uno hai sempre parlato con affetto e rimpianto, con Wright ci sono stati anche molti scontri. Che ricordo ha di loro?
Ovviamente ricordo molto bene tutti e due. C’erano delle tensioni, ma non con Syd. Non ce ne sono mai state: lui è andato fuori di testa, tutto qui. Rick e io avevamo delle divergenze quando era ancora nel gruppo, però abbiamo anche fatto della gran bella musica insieme. L’ho sempre rispettato come musicista. Non saprei cos’altro dire. Abbiamo vissuto un periodo brevissimo.
Mica tanto. Con Wright ha lavorato quasi vent’anni.
Cosa sono vent’anni? È un attimo che fugge. Anche i 75.000 anni che siamo su questa Terra non sono niente. La via scorre via veloce e a volte, se potessi tornare indietro, agiresti diversamente rispetto a come hai fatto. Ma non si può chiedere a chi è morto se avrebbe preferito agire diversamente o se avrebbe cambiato qualcosa della sua vita. Il mondo delle relazioni umane, e delle credenze filosofiche o politiche di una persona, è così complesso e difficile. Ci sono tantissime scelte che facciamo ogni giorno. Siamo destinati a sbagliare: tutti facciamo errori, errare è umano. Non saprei davvero cos’altro dire su Syd o Rick.
Con i Pink Floyd avete dilatato l’idea di canzone. Sempre al New York Times lei ha dato una risposta bizzarra, in merito.
Noi iniziavamo, io guardavo Rick (Wright), lui guardava Dave (Gilmour): “Qualcuno sa un altro accordo?”. “No!”. Così suonavamo un do minore per mezz’ora… Scherzavo, ovviamente.
Il suo rapporto coi live è mutato radicalmente. Nel ’77 sputò in faccia a un cretino che voleva arrampicarsi sul palco durante un concerto a Montreal e da quell’episodio, che la traumatizzò, nacque The Wall. Durante i suoi primi concerti solisti negli Anni Ottanta, i Pink Floyd riempivano gli stadi e lei no. Così, fino alla fine dei Novanta, si è fermato. Ora invece non fa che suonare dal vivo.
Non avevo più fatto nulla dopo Radio K.A.O.S. (1987). Qualche anno dopo, Don Henley mi chiese di partecipare a un concerto di beneficenza per il suo progetto Walden Woods a Los Angeles. Accettai. Così feci 2-3 canzoni con la sua band. Quando salii sul palco e partii con la prima canzone, non ricordo quale, sentii una grande ondata di calore proveniente dal pubblico che applaudiva. Percepii che le persone provavano una specie di amore per me. Dopo aver fatto una manciata di canzoni quella sera, Chris Wright della Chrysalis Records mi disse: “Non mi ero mai reso conto che fossi un performer!”. Io gli risposi: “Certo che lo sono!” Poi scesi dal palco e pensai: “Mi è proprio piaciuto!”. Ero molto rilassato. Pensai che mi piaceva il rapporto che avevo con il pubblico quella sera. Tutto questo mi fece pensare che un giorno sarei tornato on the road e mi sarei cimentato di nuovo in quest’esperienza. Lo feci con In The Flesh, nel 1999. Pensai che era andata bene e che avrei provato a fare qualcosa di diverso ogni volta sul palco. Ed eccoci qui.
Le leggo una recensione che ha fatto di lei una persona che la conosce bene: “Un uomo come lui si arrende solo quando muore”. Sa chi l’ha detto?
No.
David Gilmour.
(allibito e facendo una faccia tipo De Niro “Stai parlando con me?” in Taxi Driver) Che cosa ha detto Dave?
Che un uomo come lei si arrende solo quando muore.
(poco convinto). Ha detto così?
Sì. Non ne sembra molto felice.
Ah, beh. Okay. Perché no?
E’ una bella recensione, no?
(sorridendo) Non mi interessa, non è una cosa che mi appassiona. Io e Dave siamo stati in un gruppo per 20 anni, e ora non ne facciamo più parte. Non lo vedo mai e non abbiamo rapporti. Se ha detto così, va bene. Non so perché abbia detto così, non so perché la cosa dovrebbe risultare interessante.
Forse perché siete due dei musicisti più amati nel mondo.
Okay, va bene! Ma ci sono così tante cose che mi appassionano adesso, che quella frase suona oggi un po’ irrilevante per me. Questo è un bel disco, non vedo l’ora di fare questi concerti. Il lavoro necessario per allestire il tour “Us + Them” (partenza il 26 maggio da Kansas City. La scaletta proporrà 4 brani dal nuovo disco e poi pezzi tratti da Dark Side Of The Moon, Animals e The Wall. Probabili date italiane nel 2018 e 2019, NdA) è enorme. È impossibile farlo nel tempo a disposizione. Ma lo stiamo facendo. Questo mi piace: mi piace essere sotto pressione. È sempre stato così. Era impossibile mettere in piedi gli show di The Wall quando ero nei Pink Floyd. Non si poteva fare, ma ce l’abbiamo fatta. Mi piacciono le sfide e forse Dave si riferiva a questo: “Si arrende solo quando muore”. Mi piace avere qualcosa da fare, non mi piace stare con le mani in mano. Inoltre mi piace esprimere sentimenti. La mia ragione di vita è avere un problema da risolvere. È questo che mi fa venire voglia di alzarmi ogni mattina, bere due caffè e dire: “Forza! Dai, alla carica!”. Mi piace lavorare e sono felicissimo di essere ancora in forma, forte e in salute per continuare con il mio lavoro. Se Dave intendeva dire che continuerò a farlo finché muoio, probabilmente ha ragione. Sì, probabilmente andrà così.
(Grazie a Sony, Claudia Benetello, Maria Galetta, Jon Pareles e Giovanni Rossi)