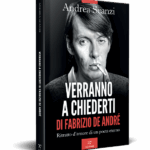Più che un disco, è una sentenza. Roger Waters, nome dato dall’anagrafe terrestre a una delle migliori (nonché più livide e fosche) espressioni del Divino, torna con un disco di inediti a 25 anni dall’epocale Amused To Death. Si intitola Is This The Life We Really Want?, è stato prodotto da Nigel Godrich (Radiohead eccetera) e ha richiesto due anni di lavoro. Uscirà per Sony il 2 giugno (primo giugno in Italia). Dodici tracce. Il Fatto ne è in possesso da un mese e può ora recensirlo in anteprima: alto livello, in alcuni casi altissimo livello. Superiore a Radio Kaos, superiore a The Pros And Cons of Hitch-Hiking, forse appena inferiore ad Amused To Death (che resta un’opera di irreale meraviglia). Noterete echi di The Dark Side Of The Moon, Wish You Were Here (più di quanto crediate), Animals (oh yes), The Wall (meno di quanto crediate) e The Final Cut (però molto meno cupo): insomma, note e tracce di Dio.
E’ un disco d’altri tempi, di bellezza dolorosa e vertiginosa, con vette inaudite e l’universo watersiano di sempre: gli orologi, le esplosioni, i gabbiani, la guerra. Le risate (inquietanti), il padre (qui meno del solito), i cani, la tecnologia. L’urlo: quel suo urlo. La radio, i sospiri, la tivù accesa, i cori. E una voce mai così profonda e definitiva. Colpiscono l’assenza di assoli e il ruolo quasi marginale delle chitarre: niente David Gilmour (Waters e Goldrich volevano coinvolgerlo con due assoli, ma poi non se n’è fatto di nulla). Niente Eric Clapton, presente nel primo disco solista. Niente Jeff Beck, semplicemente monumentale in Amused To Death. E niente Snowy White, già con lui nel tour di Animals. Lo strumento chiave, qui, è il pianoforte. Waters ha definito il disco così: “E’ un viaggio che parla della natura trascendentale dell’amore. Di come l’amore ci può aiutare a passare dalle nostre attuali difficoltà a un mondo in cui tutti possiamo vivere un po’ meglio”. Godrich ha tagliato alcuni brani e Waters ha già detto di avere pronto il materiale per un altro disco, che intende fare uscire a breve. Il tour “Us + them” partirà il 26 maggio da Kansas City. Date italiane nel 2018 (palazzetti) e 2019 (all’aperto). La scaletta conterrà quattro brani da Is This The Life We Really Want? e poi brani tratti da Dark Side, Wish You Were Here e Animals. La simbiosi tra Waters e Godrich ricorda quella verificatasi tra Johnny Cash e Rick Rubin per il ciclo sublime delle American Recordings. Se fosse un voto, sarebbe 8.5. Più probabilmente 9-. Waters ci ha messo un quarto di secolo, ma ha partorito il capolavoro che era lecito attendersi. Consiglio: ascoltatelo avendo davanti i testi tradotti, perché i testi (come sempre in Waters) sono oltremodo decisivi. Ecco la recensione, brano per brano, all’interno di una torcida più che mai imperitura.
When We Were Young. Classico inizio/non inizio di Waters, che se non lo fa strano non è contento. E’ quel che rimane – insieme agli ultimi secondi del disco – del radiogramma scritto da Waters e consegnato a Godrich, in cui un vecchio irlandese rispondeva ad alcune domande fondamentali che il nipote si faceva. Su tutte, questa: “Perché i bambini vengono uccisi?”. Orologi (Breathe, Time, tutto). Voce che narra e non canta. Musica sempre più cupa. Tanto per capire subito che tutto sarà dolore e morte: non vi sarà salvezza alcuna, come in The Ballad Of Bill Hubbard. Si è immediatamente catapultati al cospetto di Messer Satanasso. La voce è particolarmente demoniaca: perfetta, quindi, per raccontare questa contemporaneità malsana e irredimibile.
Deja-vù. Uno dei capolavori di Waters. Testo pazzesco, musica divina. Un brano quasi insostenibile. E’ stata la prima canzone scritta per il disco: Dio ebbe a comporla durante l’ultimo tour di The Wall. In origine si intitolava Se fossi stato Dio. Di fatto, immaginandosi Dio, Waters non fa che immaginarsi se stesso. Quindi parla da solo. Gli accade spesso. Il crescendo è straziante e quando parte l’orchestra, in contemporanea con la frase “Se fossi un drone”, si è lacerati – pardon: devastati – dall’emozione. Il parossismo emotivo coincide con l’urlo watersiano (sia lode) e con la 876esima esplosione presente in un’opera del Mahatma di Cro Magnon. Se non piangete ascoltandola, avete seri problemi al condotto lacrimale. In quel caso, curatevi: non è bello essere morti da vivi.
The Last Refugee. Brano che pare provenire da The Final Cut. Il testo è una sorta di mix tra The Hero’s Return e Gunner’s Dream. L’inizio (ancora) parlato, con una tivù accesa da qualche parte, vi rimanderà invece a Nobody Home (quindi a The Wall). La musica, deliberatamente, non decolla mai. Ciò la rende però una delle canzoni meno incisive.
Picture That. Brano molto floydiano. Il testo è una carrellata di orrori compiuti dall’umanità. E’ una sorta di Sheep 2.0: Animals 100%, però riletto da Godrich. Si vola. E si muore. Inesorabilmente.
Broken Bones. Tutti in piedi: altro apice inaudito, nonché sommamente inesausto. Waters consiglia ancora alle nuove generazioni di buttare via tutto quel che hanno costruito i loro padri. Nulla è cambiato dal celebre “We don’t need no education”: l’umanità non sa essere libera, le ossa sono ancora rotte e la Seconda Guerra Mondiale non ci ha insegnato niente. Sullo sfondo, lupi che ululano, gabbiani (ancora loro) e gente che scatarra (Wish You Were Here). La voce si compiace di lambire toni funerei e l’urlo watersiano gronda ancora sangue come ai tempi di Careful with that axe, Eugene. Godrich, qui, mostra con sicumera crassa quanto ce l’abbia lungo: può permetterselo. E non avete ancora sentito nulla.
Is This The Life We Really Want? Appunto. Uno dei testi più straordinari di Waters, in parte derivante da una sua poesia del 2008. Il brano parte come una suite lugubre dei Radiohead (che Waters peraltro non ama). Poi cresce, quindi si avviluppa in una sorta di rap ferale. Scudisciando e bombardando la nostra pochezza, tale da giustificare il parallelismo tra uomini e formiche, Waters accarezza l’abisso accentuando il tono grave della sua voce roca nonché geneticamente apocalittica. Egli regna, nei secoli dei secoli. Prendetene atto. Notate come Dio pronunci all’inizio: “L’oca è grassa”. Fa paura. Quando poi scandisce, dopo una poesia luciferina, “È perché/ Noi tutti/ Bianchi e neri/ Chicanos, asiatici”, si abbraccia direttamente l’Apocalisse. Inutile cercare vie di fuga: non ve ne sono, non ve ne saranno. Canzone che fa paura, in tutti i sensi: per la forza, per la bellezza, per la genialità, per il dolore. Non esiste una roba così. Non esiste. Tutto questo è illegale: Armageddon in musica. Sia davvero lode.
A Bird In A Gale. Dopo l’autopsia dell’umanità, ecco l’esplosione del volo. Ma è un volo ipotetico, perché siamo uccelli in gabbia. Uno dei brani più interessanti per progressione, arrangiamento, variazioni e ferite: quest’uomo ha proprio i demoni che gli prendono a calci i neuroni. E non gli danno mica tregua. Macché. Mai. L’effetto musicale è una sorta di scontro frontale tra Welcome To The Machine e The National Anthem dei Radiohead. L’eco qui usato – e abusato – è un altro tocco watersianissimo. Ascoltiamo dunque il Messia: “Il cane gratta la porta/ Il bambino annega in mare/ Posso addormentarmi sul tuo pavimento?/ Il pazzo ulula al mare/ Posso addormentarmi sul tuo pavimento? Nella storia c’è posto per me?”. Che esondazione continua di genio. Mamma mia. Im-ba-raz-zan-te.
The Most Beautiful Girl In The World. E’ di nuovo allegria contagiosa: “Poteva benissimo essere/ La ragazza più bella al mondo/ La sua vita si è spenta/ Come un bulldozer che schiaccia una perla”. Sta a questo disco come Watching Tv stava ad Amused To Death. Solo che quella era una ballata straziante su Tien An Men, mentre qui l’empatia non scatta appieno.
Smell The Roses. La canzone meno ispirata. Un po’ Have a cigar, un po’ Welcome to the machine, un po’ Dogs. Pare un contentino per i nostalgici dei Pink Floyd. Insensatamente usata come primo singolo. Il testo è molto bello (“Questa è la stanza dove fanno gli esplosivi/ Dove mettono il tuo nome sulla bomba/ Ecco dove seppelliscono i “ma” e i “se” e/ cancellano parole come “giusto” e “sbagliato”). Il brano, però, nulla aggiunge alla grandezza dell’Onnipotente.
Wait For Her. Attenzione, perché qui parte una suite sull’amore – inteso come catarsi e salvezza – che vi strapperà e strazierà il cuore. Sono tre canzoni, ma in realtà è la stessa. Un po’ come accadeva a Pigs On The Wing, solo che Iddio ebbe a dividerla quarant’anni fa in due parti (anche per avere più diritti d’autore, diciamolo). Wait For Her è delicata, garbata, dolce. Quasi rarefatta. E’ sconcertante questa capacità di Waters nel passare dalla modalità “Siamo tutti cani rognosi meritevoli dell’estinzione” alla sintonia lirica “L’amore può salvarci”. Egli continua a regnare.
Oceans Apart. Classico brano-raccordo: Roger li ama molto. Tornano i gabbiani: sono gli stessi di Southampton Dock, ormai dovreste conoscerli. Era il 1983, ma nulla è cambiato: siamo ancora noi, pazzi lunatici in cerca di un rifugio dai porci volanti, mentre i politici ci fottono, il primo citrullo che passa lo eleggono presidente e i sogni muoiono all’alba. Soprattutto ad Anzio. Ma non solo lì.
A Part Of Me Died. Eh, ragazzi, qui si piange parecchio. Ma parecchio. Cazzo, se si piange. La canzone è prosecuzione e conclusione delle due precedenti. La donna amata è morta per salvarci e, con il suo sacrificio, ha permesso che scomparisse con lei anche la nostra parte peggiore: “La parte che è invidiosa/ Insensibile e subdola/ Avida, maligna/ Globale, coloniale/ Assetata di sangue, cieca/ Incurante e squallida/ Concentrata su confini/ E macello e pecore/ Sul bruciare libri/ Radere al suolo case/ Incline agli omicidi mirati/ Con i droni/ Iniezioni letali/ Arresto senza processo”. La voce diventa ancora più profonda, solenne, marziale. Il crescendo è dolente, le lacrime sgorgano inesorabili. Tutto ha il tono del crepuscolo e del testamento. E quando Dio fa testamento, be’, c’è da avere davvero paura. Godetevi ogni sospiro, ogni carezza, ogni incubo di quest’opera: è una fortuna rara essere contemporanei di un genio simile.