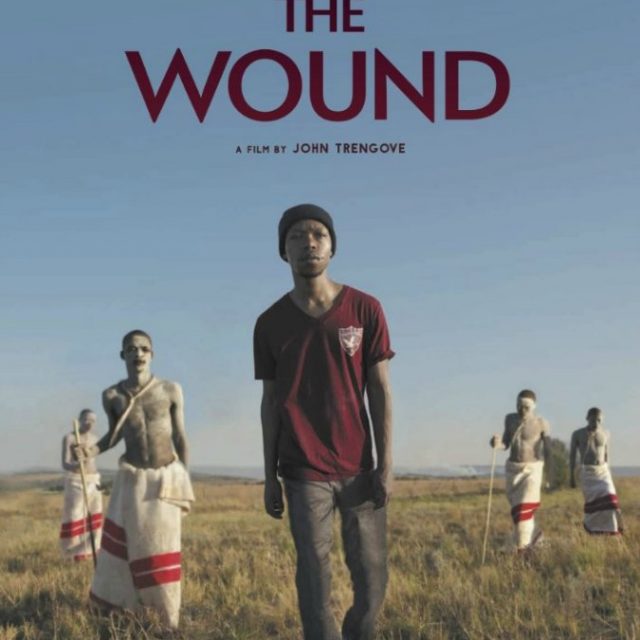Doveva esserci già pronto un comunicato, un epitaffio, un rigo appena. Daniel Day Lewis che si ritira dalle scene, che a 60 anni appena compiuti saluta Hollywood e milioni di fan, è sicuramente una decisione meditata da tempo. Se c’è infatti un tratto distintivo di una delle icone attoriali più raffinate anni novanta- primi duemila è quello della riflessività, della ponderazione, della calma, nel compiere gesti, scegliere parti, fare il proprio mestiere.
 Quando Martin Scorsese lo volle per interpretare Bill il macellaio in Gangs of New York ci mise parecchi mesi prima di “entrare” nella parte. Ha affilato coltelli e tagliato carni per settimane, ha voluto vestirsi con vestiti leggeri dell’epoca per parecchio tempo prima del set beccandosi pure una polmonite. Per diventare Hawkeye de L’ultimo dei mohicani (1992) ha vissuto in mezzo a un bosco per sei mesi imparando a cacciare, pescare e a scuoiare animali. Una meticolosità definita “method acting” (in italiano Il Metodo) che arriva dritta dritta dall’Actor’s Studio di Lee Strasberg, anche se Lewis Kazan e soci non li ha mai frequentati.
Quando Martin Scorsese lo volle per interpretare Bill il macellaio in Gangs of New York ci mise parecchi mesi prima di “entrare” nella parte. Ha affilato coltelli e tagliato carni per settimane, ha voluto vestirsi con vestiti leggeri dell’epoca per parecchio tempo prima del set beccandosi pure una polmonite. Per diventare Hawkeye de L’ultimo dei mohicani (1992) ha vissuto in mezzo a un bosco per sei mesi imparando a cacciare, pescare e a scuoiare animali. Una meticolosità definita “method acting” (in italiano Il Metodo) che arriva dritta dritta dall’Actor’s Studio di Lee Strasberg, anche se Lewis Kazan e soci non li ha mai frequentati.
Londinese, figlio del poeta Cecil Day-Lewis e dell’attrice inglese Jill Balcon, Lewis ha calcato più che altro le scene del Bristol Old Vic di Londra. Anche se il debutto su grande schermo arriva all’età di 14 anni in una piccola parte da delinquentello in Domenica, maledetta domenica di John Schlesinger (1971). È però nel 1985 con la doppietta My Beautiful Laundrette e Camera con vista che attira su di sé l’attenzione di critica, pubblico e fan. Lewis passa con grande versatilità dall’interpretare un altro balordo di periferia, omosessuale in un rapporto d’amore interraziale, ad un più spocchioso intellettualino edoardiano in Camera con vista.
 Dall’istintività del duo Frears-Kureishi all’eleganza di set di Ivory. Che sia nata una stella è chiaro. Solo che Daniel Day Lewis è già un trentenne che applica il criterio di selettività tra ruolo e ruolo. Ci vogliono quattro anni per ri-vederlo pimpante e brioso ne L’insostenibile leggerezza dell’essere di Philip Kaufman tratto da Kundera. È però con il sangue irlandese e il cinema roboante e impegnato di Jim Sheridan che Lewis inizia ad eccellere. Con Il Mio piede sinistro nel 1989 interpreta il paraplegico Christy Brown che si farà conoscere come scrittore e pittore usando l’unico arte che riesce a muovere. Anche qui l’attore londinese si fa trasportare sulla carrozzina anche fuori dal set, si fa imboccare da aiutanti e attori come fosse realmente handicappato. Il classico Oscar per l’attore che interpreta un disabile arriva puntuale, ma in molti hanno già compreso che Daniel Day Lewis di statuette dell’Academy ne potrà vincere anche altre senza necessariamente entrare in una categoria “sensibile”.
Dall’istintività del duo Frears-Kureishi all’eleganza di set di Ivory. Che sia nata una stella è chiaro. Solo che Daniel Day Lewis è già un trentenne che applica il criterio di selettività tra ruolo e ruolo. Ci vogliono quattro anni per ri-vederlo pimpante e brioso ne L’insostenibile leggerezza dell’essere di Philip Kaufman tratto da Kundera. È però con il sangue irlandese e il cinema roboante e impegnato di Jim Sheridan che Lewis inizia ad eccellere. Con Il Mio piede sinistro nel 1989 interpreta il paraplegico Christy Brown che si farà conoscere come scrittore e pittore usando l’unico arte che riesce a muovere. Anche qui l’attore londinese si fa trasportare sulla carrozzina anche fuori dal set, si fa imboccare da aiutanti e attori come fosse realmente handicappato. Il classico Oscar per l’attore che interpreta un disabile arriva puntuale, ma in molti hanno già compreso che Daniel Day Lewis di statuette dell’Academy ne potrà vincere anche altre senza necessariamente entrare in una categoria “sensibile”.
 Interessante è seguire il fil rouge dei film con Sheridan, saltando l’emblematica interpretazione ne L’età dell’innocenza di Scorsese, per arrivare a Nel nome del padre, autentico dramma familiare a sfondo politico, prison movie totalizzante che vede Lewis comprimere rabbia e dolore dell’ingiustizia subita, in una vibrante interpretazione del vero Gerry Conlon dovuta anche a parecchi giorni passati da Lewis in una vera cella d’isolamento senza dormire e mangiare. Ancora Sheridan, 1997, The Boxer. Summa psicologica del lavoro di Lewis, identità e ruolo tutto in sottrazione, silenzioso e criptico, meno pomposo del minimalismo alla Scorsese e Ivory, il pugile proletario, ex membro dell’Ira, Danny, si tuffa dentro a un melò semplice e puro che mescola privato e pubblico, e lascia senza fiato.
Interessante è seguire il fil rouge dei film con Sheridan, saltando l’emblematica interpretazione ne L’età dell’innocenza di Scorsese, per arrivare a Nel nome del padre, autentico dramma familiare a sfondo politico, prison movie totalizzante che vede Lewis comprimere rabbia e dolore dell’ingiustizia subita, in una vibrante interpretazione del vero Gerry Conlon dovuta anche a parecchi giorni passati da Lewis in una vera cella d’isolamento senza dormire e mangiare. Ancora Sheridan, 1997, The Boxer. Summa psicologica del lavoro di Lewis, identità e ruolo tutto in sottrazione, silenzioso e criptico, meno pomposo del minimalismo alla Scorsese e Ivory, il pugile proletario, ex membro dell’Ira, Danny, si tuffa dentro a un melò semplice e puro che mescola privato e pubblico, e lascia senza fiato.
 Poi si arriva al periodo solenne della maturità. Che è preceduto da una pausa. Una lunga pausa da qualsiasi set. Leggenda vuole che Daniel Day Lewis indossasse un paio di stivali del padre fabbricati dal calzolaio fiorentino Bemer. Gli stivali erano stati indossati per 30 anni e si erano talmente usurati che Daniel un bel giorno si presenta al negozio dei Bemer per farsene fare un paio nuovo su misura. Qui accade l’impossibile. L’adulto ricorda quando da ragazzino aveva preferito fare l’ebanista invece dell’attore, quell’artigianalità mancata (venne rifiutato dall’istituto professionale a cui fece domanda) rifulge a sorpresa tra le strade fiorentine. Lewis chiede ai Bemer di imparare la professione di calzolaio. Immaginate la scena. Qualcosa tra Tim Burton e Frank Capra. Ebbene Lewis si piazza lì, per settimane, mesi, gratuitamente. I Bemer dissero che era il primo ad arrivare la mattina e l’ultimo a uscire la sera. Scarpe fatte a mano. L’ultimo rifugio possibile dalla popolarità dello showbiz. La gente del quartiere l’aveva saputo e attivò un cordone di protezione dai paparazzi davvero impenetrabile. Solo la scrittrice Rebecca Miller, sua moglie dal 1996 dopo la relazione avuta con Isabelle Adjani, riuscirà a convincerlo a diventare Bill il macellaio in Gangs di Scorsese.
Poi si arriva al periodo solenne della maturità. Che è preceduto da una pausa. Una lunga pausa da qualsiasi set. Leggenda vuole che Daniel Day Lewis indossasse un paio di stivali del padre fabbricati dal calzolaio fiorentino Bemer. Gli stivali erano stati indossati per 30 anni e si erano talmente usurati che Daniel un bel giorno si presenta al negozio dei Bemer per farsene fare un paio nuovo su misura. Qui accade l’impossibile. L’adulto ricorda quando da ragazzino aveva preferito fare l’ebanista invece dell’attore, quell’artigianalità mancata (venne rifiutato dall’istituto professionale a cui fece domanda) rifulge a sorpresa tra le strade fiorentine. Lewis chiede ai Bemer di imparare la professione di calzolaio. Immaginate la scena. Qualcosa tra Tim Burton e Frank Capra. Ebbene Lewis si piazza lì, per settimane, mesi, gratuitamente. I Bemer dissero che era il primo ad arrivare la mattina e l’ultimo a uscire la sera. Scarpe fatte a mano. L’ultimo rifugio possibile dalla popolarità dello showbiz. La gente del quartiere l’aveva saputo e attivò un cordone di protezione dai paparazzi davvero impenetrabile. Solo la scrittrice Rebecca Miller, sua moglie dal 1996 dopo la relazione avuta con Isabelle Adjani, riuscirà a convincerlo a diventare Bill il macellaio in Gangs di Scorsese.
 Ma, appunto è tra il 2007 e il 2012 che Lewis vince il secondo e terzo Oscar. Mugugna, scava a mani nude, si sporca in faccia e sulle mani di oro nero come James Dean ne Il Gigante, interpretando il minatore de Il Petroliere, diretto da Paul Thomas Anderson. Leziose finché si vuole, le tre ore di film sono una sinfonia potentissima della mancanza di umanità e vita dietro all’assunto scintillante del denaro e del profitto individuale. Daniel Plainview è un personaggio bestiale e brutale, un uomo senza un’etica che pur di sopravvivere è disposto a tutto. Lewis lo carica di un odio e di un desiderio perenne di vendetta che spiazza eticamente lo spettatore, sospendendone giudizio e identificazione. Ci penserà Steven Spielberg con quel Lincoln crepuscolare e saggio, curvo e filamentoso, a offrire a Daniel Day Lewis l’ultimo ruolo della sua carriera. Ucciso dal vile sudista, sul letto di morte, Lewis lentamente evapora come un cristo redento dal sepolcro della storia americana e dalla storia del cinema.
Ma, appunto è tra il 2007 e il 2012 che Lewis vince il secondo e terzo Oscar. Mugugna, scava a mani nude, si sporca in faccia e sulle mani di oro nero come James Dean ne Il Gigante, interpretando il minatore de Il Petroliere, diretto da Paul Thomas Anderson. Leziose finché si vuole, le tre ore di film sono una sinfonia potentissima della mancanza di umanità e vita dietro all’assunto scintillante del denaro e del profitto individuale. Daniel Plainview è un personaggio bestiale e brutale, un uomo senza un’etica che pur di sopravvivere è disposto a tutto. Lewis lo carica di un odio e di un desiderio perenne di vendetta che spiazza eticamente lo spettatore, sospendendone giudizio e identificazione. Ci penserà Steven Spielberg con quel Lincoln crepuscolare e saggio, curvo e filamentoso, a offrire a Daniel Day Lewis l’ultimo ruolo della sua carriera. Ucciso dal vile sudista, sul letto di morte, Lewis lentamente evapora come un cristo redento dal sepolcro della storia americana e dalla storia del cinema.