Iva e spesa pubblica, i vincoli alle promesse dei partiti
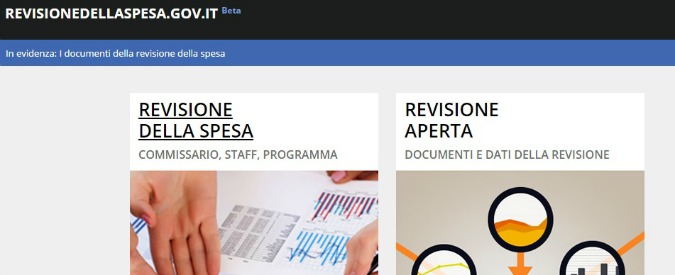
I partiti, tutti, non stanno dicendo la verità sui numeri. Quando fanno promesse elettorali nascondono un dato decisivo: le clausole di salvaguardia, cioè aumenti di tasse futuri già approvati per finanziare spese passate già sostenute. I conti pubblici italiani, ad oggi, incorporano un aumento dell’Iva già stabilito e duraturo, sia nel 2019 che nel 2020: 12,5 miliardi l’anno prossimo e 19,2 miliardi quello dopo. E’ il primo e il più consistente vincolo esterno – e interno – alla prossima legislatura.
Ci sono solo due possibilità: o si lascia salire l’Iva, con immediato impatto sui prezzi, o si cercano coperture alternative. Nel 2018 la parte di quest’anno della clausola di salvaguardia, ben 15,7 miliardi di pesante eredità dal governo Renzi, è stata disinnescata per il 70 per cento in deficit. Ma è difficile continuare così in eterno, perché già abbiamo usato tutta la flessibilità di bilancio che le regole europee concedevano. Tradotto: prima di finanziare le proposte elettorali dei loro mirabolanti programmi, i partiti dovrebbero spiegarci che vogliono fare sull’Iva: lasciarla salire o bloccare l’aumento? E in questo secondo caso, con quali risorse? Il prossimo governo parte con una zavorra da 12,5 miliardi solo nel 2019.
In privato i vertici del Pd renziano dicono che la questione Iva è stata volutamente omessa dal programma: il Partito democratico non prende alcun impegno a evitare l’aumento che quindi, almeno in parte ci sarà. Ma tra dirlo e farlo c’è un abisso. Anche il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan, già sul 2018, avrebbe voluto far scattare parte della clausola, ma politicamente era un suicidio e Renzi lo ha fermato. Su cosa pensino gli altri partiti, o se anche soltanto siano consapevoli della questione, resta il mistero.
L’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) guidato da Giuseppe Pisauro è l’autorità indipendente che vigila sui conti pubblici e porta alcuni elementi concreti in questo assurdo dibattito elettorale. In un recente Focus che presenta il contesto della prossima legislatura, l’Upb ha chiarito che gran parte delle coperture che i partiti presentano per i loro programmi non si può ottenere. Ci sono dei limiti a quanta spesa pubblica si può tagliare senza distruggere lo Stato. Inutile dire, come fa Luigi Di Maio imitando i suoi competitor, che il bilancio pubblico vale 800 miliardi e quindi non è un problema trovarne 20-30. Sono balle. Vediamo perché.
L’Upb spiega che in questi anni la spesa pubblica corrente si è già molto stabilizzata, di grasso da tagliare ne resta poco “in generale, solo attraverso interventi selettivi sarà plausibilmente possibile ottenere ulteriori contenimenti in voci di spesa che già mostrano una tendenza alla riduzione in rapporto al Pil da vari anni, come ad esempio quelle relative ai consumi intermedi”. Sono i famosi “sprechi”, quelli che sembra si possano ridurre in modo indolore. E invece oltre il 50 per cento della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche è destinato a “voci riguardanti la spesa sanitaria e che incorpora anche altre poste difficilmente comprimibili e in alcuni casi già oggetto di passate manovre, come ad esempio quelle relative agli aggi di riscossione, alle commissioni su titoli pagate alla Banca d’Italia, alle spese per missioni internazionali”.
Quanto alle famose Tax Expenditures, cioè le agevolazioni fiscali che M5S, Forza Italia e Pd vogliono tagliare per decine di miliardi, “sono stati ripetutamente oggetto di analisi e impegni programmatici, che tuttavia non hanno finora avuto seguito. Interventi su questo fronte implicano importanti effetti redistributivi e settoriali che potrebbero essere stati un freno alla loro adozione”. Tutti dicono di volerle tagliare ma nessuno lo fa, perché gran parte di quelle voci non si possono toccare pena gravi squilibri (per esempio quelle per il lavoro dipendente o per i familiari a carico).
Il commissario alla spending review del Pd, Yoram Gutgeld, ha tagliato quasi 30 miliardi, ma praticamente tutti sono subito stati riallocati. Quindi non di veri tagli si è trattato ma di una “riqualificazione” della spesa. E sembra che questo approccio sia ancora inevitabile.
Come ricorda l’Upb e come si vede in questa tabella, tutte le voci della spesa sono destinate a ridursi anche a politiche invariate. Alcune in maniera drastica, per effetto delle scelte di questi anni, in particolare gli investimenti (spesa in conto capitale) e i redditi da lavoro, cioè gli stipendi pubblici. Già nel 2018, osserva l’Upb, potrebbe esserci bisogno di trovare soldi per onorare l’ultimo rinnovo contrattuale. E poi bisognerà assumere gente, perché il blocco del turn over ha prodotto un invecchiamento insostenibile del personale.
Secondo i calcoli della Cgil, ormai in tutti i comparti della Pa l’età media è sopra i 50 anni e con questo trend nel 2020 circa 262.000 lavoratori saranno nella fascia 65-67 anni. E quindi, osserva il sindacato, “per mantenere almeno l’attuale livello dei servizi e delle prestazioni negli stessi comparti è necessario assumere nei prossimi 3-6 anni 550.000 lavoratrici e lavoratori”.
Morale: sui consumi è quasi impossibile tagliare senza massacrare la sanità, sulle agevolazioni fiscali i margini di manovra sono stretti, ridurre ancora gli investimenti sarebbe un suicidio, incidere sul costo del lavoro non è pensabile, anzi, ci vorrebbero assunzioni di massa. Dunque, cari partiti, dove volete tagliare esattamente? Non sarebbe il caso di essere più specifici?
Già garantire lo status quo sarebbe difficile. Promettere riallocazioni di spesa pubblica per decine o centinaia di miliardi serve solo a dimostrare ignoranza sulla composizione del bilancio pubblico e una certa presunzione di coglionaggine dell’elettore.
E’ appena uscito il nuovo libro di Stefano Feltri, vicedirettore del Fatto Quotidiano: “Populismo sovrano” per la collana Le Vele di Einaudi. Lo trovate qui.