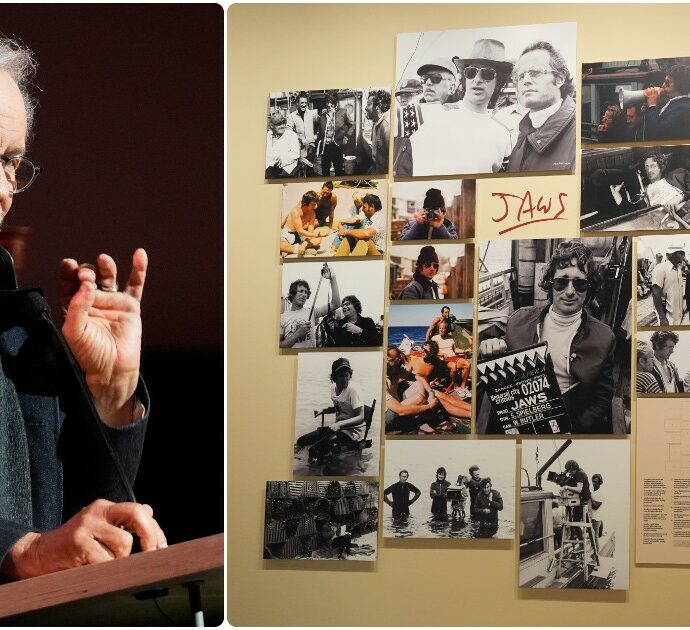Addio mastro Ermanno. È morto la scorsa notte all’ospedale di Asiago Il regista de L’albero degli zoccoli. Ermanno Olmi aveva 86 anni. Uno sguardo puro, gentile e profondo sulla condizione dell’uomo in mezzo allo scorrere frenetico degli artifici del mondo, iniziato più di 50 anni fa e portato avanti fino all’ultimo fatica, quel Torneranno i prati (2014) che, prima di tutte le retoriche celebrazioni ufficiali si era artigianalmente posto ad altezza dell’animo umano durante la tragedia universale, la distruzione massificata e sistematica della vita, attuata con il massacro istituzionale della prima guerra mondiale. Olmi è sempre stato così. Originale, autentico, mai intenzionalmente sofisticato o stilisticamente vezzoso. Le sue immagini parlavano all’umanità tutta senza troppi giri di parole. Allergico ai red carpet e ai set in pompa magna, il regista bergamasco si era costruito una sua personalissima strada poetica e nel tempo aveva perfino provato a costruire una non scuola, Ipotesi Cinema, per provare a coltivare una filosofia minima, un approccio cinematografico rallentato nei tempi e nei modi di realizzazione, meno concitato ed effimero dello star system industriale ufficiale.
“Il fatto è che ci ritroviamo tutti in balia dell’incasinamento generale, travolti e stravolti da un delirio da paranoia, a correre dietro a un mondo che corre più svelto di noi… Ma dove stiamo correndo? E per quale ragione? E poi, siamo davvero così sicuri di correre dalla parte giusta? O si corre e basta? Quasi che il correre, l’essere dinamici e produttivi, il non ‘sprecar tempo’ fosse già una convenienza in sé, un risultato utile e appagante”. Spiegava così il suo sguardo sul mondo, Olmi nel 2001 chiacchierando con Tullio Kezich. E il suo cinema è stato proprio questo. Un cinema che camminava e non correva, che faceva un passo di lato per osservare e meditare di fronte al cambiamento. La sua carriera inizia ufficialmente con Il tempo si è fermato (1959), una sorta di tasto “pausa” sulla vita di uno studente finito nella baracca di un guardiano su una diga sull’Adamello; e Il Posto (1960), subito cinema immenso origine della civiltà del consumo, dello svuotamento creativo dell’animo umano, puntino color pastello, indelebile, in mezzo alla nebbia del Nord ripartito col boom.
All’origine della carriera di Olmi però c’è una sorta di cartina tornasole di ciò che significa artigianalità e “non scuola” nel suo approccio all’immagine cinematografica. Una quarantina di documentari sulla produzione industriale mentre lavora per la Edisonvolta come addetto al settore ricreativo dell’azienda. La condizione umana, insomma. Perché al centro del cinema di Olmi c’è sempre stato l’uomo. Una spiritualità mai liturgica, uno sguardo libero ed anticonvenzionale. Olmi fu davvero figlio d’operai, mentre attorno una marea di nuovi, guizzanti osservatori del reale, futuri cineasti che raccontarono il popolo, nascevano borghesi con davanti una strada già pronta. Olmi era un cattolico non iscritto al PCI. E in quegli contava parecchio per differenza, nel bene e nel male. Quando nel ‘68 il mondo subisce gli scossoni delle “rivoluzioni” in Francia, Germania e Italia Olmi gira Un certo giorno. Angolazione singolare del tormento interiore, del piano scivoloso del cambiamento e della trasformazione di quei concitati istanti storici che per Olmi, in questo film che ha per protagonisti personaggi borghesi, dirigenti, manager, gente che va veloce e poi scoppia con un infarto, o spappola operai investendoli con l’auto senza che nulla cambi e nessuno si rivolti, passa essenzialmente dentro l’anima del singolo.
In pieni anni sessanta/settanta Olmi non è quindi il maestro dell’incomunicabilità o il re della commedia, non è l’allegorico inventore di scenari fantastici, ma il suo ‘amarcord’ lo scrive ancora una volta con grande semplicità di mezzi e parole, sempre con quel suo silente neorealismo fatto di non attori in scenari reali e spicci. Anno 1978, L’albero degli zoccoli è Palma d’oro al Festival di Cannes. Tre ore nel mezzo delle campagne lombarde di fine Ottocento in dialetto bergamasco, il film è una delle tante storielle che la nonna raccontava ad Olmi bambino, quella del contadino che taglia un alberello per rifare gli zoccoli al figlio che va a scuola. Il padrone del terreno su cui sorge l’albero si accorge dell’accaduto e caccia contadino e famiglia dalla cascina. “Nessuna nostalgia, ma memoria, rispetto, affetto”, spiegò Olmi “per un mondo che era fatto di lavoro, pratiche religiose, rituali magici, filastrocche, sogni, residui di festività pagane”. E’ come se il regista bergamasco rovesciasse il cannocchiale delle ideologie in voga nel cinema “engagè” di quegli anni. Per spiegare disparità e diseguaglianze sociali, ma anche la purezza e le radici dell’uomo, lui osserva dal e nel basso il reale che immagina davanti agli occhi. Dopo verrà di conseguenza l’alto, la sovrastruttura. Anche per questo Olmi negli ottanta non ritrova più il lirismo e la vibrazione giusta di quel mondo in trasformazione, dell’uomo che muta e cresce, che guarda l’altro e lo rispetta, che immagina un futuro migliore per i più indietro sulla scala sociale. Il doppio passo è d’obbligo di fronte all’edonismo che spiazza e fa perdere la bussola. Soprattutto ai produttori e al cinema non più fattibile con la semplicità del sistema Olmi: scarsa preoccupazione per le prevendite tv, budget contenuti, postproduzione casalinga con bottiglie di vino a fine giornata.
Segni e significati che Olmi insegna nell’oasi di Ipotesi Cinema a Bassano del Grappa dal 1981 prima che l’odiosa malattia invalidante lo colpisca senza avvertire che la ripresa sarà lunga. Da lì escono nomi come Mario Brenta, Maurizio Zaccaro, Giorgio Diritti. E nel bel mezzo del gelido decennio degli ottanta che la trama olmiana si fa quasi fiabesca. La leggenda del santo bevitore tratto da Roth (1988) e Il segreto del bosco vecchio da Buzzati (1993) con Paolo Villaggio. Ma l’apice, la summa di una carriera dopo un altro decennio di lontananza dal set, è quel Giovanni dalle Bande Nere che Olmi in stato di grazia dipinge come un muto quadro di un cupo bagliore tardomedioevale ne Il Mestiere delle armi (2001). “Via tutti”, chiede urlando Giovanni sul letto di morte. Bisogno di isolamento, di pensare di fronte al caos, di silenzio in mezzo al rumore, di ascolto del proprio battito cardiaco nel roboante clangore dell’iperconnessione globale. Guardate quel film, come si chiude, cosa racconta quello stralcio di storia, l’onore e il rispetto, la gelosia e il tradimento, l’ardore di un sentimento e il palpitare della lealtà, è riconoscerete Olmi. Un signore saggio e coerente che ha saputo trasformare perfino un modello come Raz Degan in un umano Cristo della bassa (Centochiodi, 2007). Chi scrive visitò il set, sull’argine del Po, tra capanni di fortuna, seduto su quelle seggioline anni settanta coi fili tesi di plastica. Sembrava davvero che il mondo si fosse fermato. Non era uno sfondo vero e proprio per il cinema, nemmeno l’impostura evidente del settore trucco della miseria contadina, ma un gruppo di non professionisti che recitava con candore e naturalezza la miseria. Poi ancora, ed infine, l’ultimo atto di una carriera inesausta e sublime, il un film sulla solitudine dell’uomo, sulla spiritualità pura dell’umano di fronte agli sconvolgimenti e alle ingiustizie sociali, la semplicità umanista di Torneranno i prati. Dove sotto la neve di una guerra mondiale putrefatta e orrenda sopravvive in forma animale e naturale un luccichio di dignità, di sogno, di utopia, di pace.