Tutto quello che vi hanno raccontato sulla povertà e la disuguaglianza è falso. A partire dal fatto che stiano diminuendo. E l’hanno fatto per convincervi della bontà dell’attuale sistema economico globale, basato sullo sfruttamento delle materie prime e del lavoro a basso costo del Sud del mondo, su politiche commerciali che ne impediscono lo sviluppo e su nocive ricette di “aggiustamento strutturale” imposte facendo leva sul debito. È l’accusa di Jason Hickel, antropologo britannico nato in Swaziland che in The divide – Guida per risolvere la disuguaglianza globale (il Saggiatore) mette insieme dati e analisi storica per dimostrare che la povertà non dipende da caratteristiche nazionali, condizioni climatiche o malgoverno ma è il risultato del “saccheggio” iniziato in epoca coloniale. E l’unico modo per uscirne è cancellare i debiti, cambiare la governance delle istituzioni internazionali e convertirsi alla decrescita, anche con ricette radicali come il divieto della pubblicità per ridimensionare i consumi non necessari.
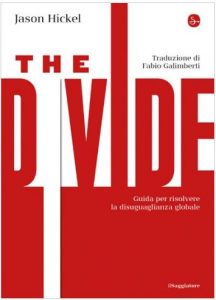 Hickel, che ha insegnato alla London School of Economics e alla University of London, parte dai numeri. Che di per sé non mentono, ma basta metterne in evidenza alcuni e nasconderne altri per stravolgere il quadro finale. Per esempio, basta scegliere di guardare la percentuale di poveri sulla popolazione mondiale e considerare povero solo chi può contare su meno di 1,25 dollari al giorno per rivendicare un dimezzamento della povertà tra 1990 e 2015. Nonostante, in termini assoluti, dal 1981 a oggi non ci sia stato nessun miglioramento: i poveri, nel mondo, sono rimasti circa 1 miliardo. E nonostante quella cifra salga a 4,3 miliardi di persone se si utilizza una soglia di povertà più realistica, cioè 5 dollari al giorno.
Hickel, che ha insegnato alla London School of Economics e alla University of London, parte dai numeri. Che di per sé non mentono, ma basta metterne in evidenza alcuni e nasconderne altri per stravolgere il quadro finale. Per esempio, basta scegliere di guardare la percentuale di poveri sulla popolazione mondiale e considerare povero solo chi può contare su meno di 1,25 dollari al giorno per rivendicare un dimezzamento della povertà tra 1990 e 2015. Nonostante, in termini assoluti, dal 1981 a oggi non ci sia stato nessun miglioramento: i poveri, nel mondo, sono rimasti circa 1 miliardo. E nonostante quella cifra salga a 4,3 miliardi di persone se si utilizza una soglia di povertà più realistica, cioè 5 dollari al giorno.
Ma, sostiene Hickel, “le agenzie per lo sviluppo, le ong e i governi più potenti del mondo” hanno interesse a diffondere la narrazione che grazie agli aiuti dei paesi ricchi la situazione stia migliorando e sia possibile debellare la povertà entro il 2030. Anche se i soldi stanziati per l’assistenza allo sviluppo, circa 128 miliardi di dollari all’anno, sono quasi nulla in confronto a interessi sul debito, profitti che le compagnie straniere riportano in patria, false fatturazioni commerciali “per drenare soldi e distrarli verso paradisi fiscali”, esenzioni fiscali concesse alle multinazionali, pagamenti ai proprietari di brevetti stranieri e squilibri nel commercio internazionale: solo quelli determinati dall’Uruguay round del Wto costano ai paesi poveri “700 miliardi di dollari l’anno in mancati ricavi da esportazione”.
Insomma: “I paesi poveri non hanno bisogno del nostro aiuto, hanno solo bisogno che smettiamo di impoverirli”. Il “saccheggio”, secondo Hickel, è iniziato in epoca coloniale e si è interrotto solo tra il secondo dopoguerra e gli anni Settanta quando molti paesi del Sud del mondo adottarono dazi, misure protezionistiche e controlli sui movimenti di capitali per sostenere l’industria locale. Insomma politiche keynesiane, argomenta l’autore, identiche a quelle adottate con successo in Occidente (vedi il New Deal). Ma quando a metterle in campo è stato il Sud del mondo, limitando le esportazioni delle aziende occidentali e facendo aumentare i salari locali a loro danno, la reazione è stata aggressiva: prima il sostegno ai golpe “per rovesciare decine di leader eletti democraticamente e sostituirli con dittatori sensibili agli interessi economici occidentali, tenuti in sella con gli aiuti allo sviluppo“. Poi, negli anni Ottanta, Usa ed Europa “scoprirono il loro potere di creditori per dettare le politiche economiche ai paesi indebitati del terzo mondo e governarli efficacemente a distanza” attraverso i programmi di aggiustamento gestiti dal Fondo monetario internazionale. Parole d’ordine: privatizzazioni, taglio della spesa per servizi pubblici, deregolamentazione dell’economia e liberalizzazioni.
Così il debito divenne l’arma per “diffondere il neoliberismo in tutto il pianeta”, chiosa Hickel. Che dà conto come quella ricetta, giustificata prospettando aumenti dei tassi di crescita che avrebbero consentito di ridurre il debito, abbia determinato un aumento esponenziale della povertà. Durante gli anni Ottanta e Novanta il numero delle persone che vivevano con meno di 5 dollari al giorno è cresciuto di oltre 1 miliardo. In America Latina il tasso di povertà è salito dal 40% del 1980 al 62% nel 1993 e in parallelo la quota del reddito nazionale destinata ai salari è diminuita in favore di quella che finiva in profitti. Intanto schizzava all’insù anche la disuguaglianza misurata come divario tra il pil pro capite degli Stati Uniti e quello delle varie regioni in via di sviluppo. E’ la prova, conclude l’autore, che il modello economico attuale basato sulla crescita infinita del pil e sullo sfruttamento intensivo delle risorse naturali è fallimentare e per sradicare la povertà serve un sistema “molto più equo e razionale di distribuzione della ricchezza”, che preveda il ridimensionamento dei consumi e un reddito minimo di base per alleviare la disuguaglianza e “sollevare le persone dall’obbligo di lavorare per 40 o addirittura 60 ore la settimana solo per sopravvivere”.

Economia
Disuguaglianza, “il divario si allarga. Colpa di un sistema basato su crescita infinita e saccheggio del Sud del mondo”
In The divide l'antropologo Jason Hickel mette insieme dati e analisi storica per sostenere che contrariamente a quanto rivendicato dalle istituzioni internazionali la povertà è in crescita, così come la distanza tra i redditi pro capite degli Usa e quelli delle aree in via di sviluppo. E non è il risultato di caratteristiche locali o malgoverno, bensì delle ricette neoliberiste imposte dall'Occidente. La soluzione che propone è radicale: cancellare i debiti e convertirsi alla decrescita
Tutto quello che vi hanno raccontato sulla povertà e la disuguaglianza è falso. A partire dal fatto che stiano diminuendo. E l’hanno fatto per convincervi della bontà dell’attuale sistema economico globale, basato sullo sfruttamento delle materie prime e del lavoro a basso costo del Sud del mondo, su politiche commerciali che ne impediscono lo sviluppo e su nocive ricette di “aggiustamento strutturale” imposte facendo leva sul debito. È l’accusa di Jason Hickel, antropologo britannico nato in Swaziland che in The divide – Guida per risolvere la disuguaglianza globale (il Saggiatore) mette insieme dati e analisi storica per dimostrare che la povertà non dipende da caratteristiche nazionali, condizioni climatiche o malgoverno ma è il risultato del “saccheggio” iniziato in epoca coloniale. E l’unico modo per uscirne è cancellare i debiti, cambiare la governance delle istituzioni internazionali e convertirsi alla decrescita, anche con ricette radicali come il divieto della pubblicità per ridimensionare i consumi non necessari.
Ma, sostiene Hickel, “le agenzie per lo sviluppo, le ong e i governi più potenti del mondo” hanno interesse a diffondere la narrazione che grazie agli aiuti dei paesi ricchi la situazione stia migliorando e sia possibile debellare la povertà entro il 2030. Anche se i soldi stanziati per l’assistenza allo sviluppo, circa 128 miliardi di dollari all’anno, sono quasi nulla in confronto a interessi sul debito, profitti che le compagnie straniere riportano in patria, false fatturazioni commerciali “per drenare soldi e distrarli verso paradisi fiscali”, esenzioni fiscali concesse alle multinazionali, pagamenti ai proprietari di brevetti stranieri e squilibri nel commercio internazionale: solo quelli determinati dall’Uruguay round del Wto costano ai paesi poveri “700 miliardi di dollari l’anno in mancati ricavi da esportazione”.
Insomma: “I paesi poveri non hanno bisogno del nostro aiuto, hanno solo bisogno che smettiamo di impoverirli”. Il “saccheggio”, secondo Hickel, è iniziato in epoca coloniale e si è interrotto solo tra il secondo dopoguerra e gli anni Settanta quando molti paesi del Sud del mondo adottarono dazi, misure protezionistiche e controlli sui movimenti di capitali per sostenere l’industria locale. Insomma politiche keynesiane, argomenta l’autore, identiche a quelle adottate con successo in Occidente (vedi il New Deal). Ma quando a metterle in campo è stato il Sud del mondo, limitando le esportazioni delle aziende occidentali e facendo aumentare i salari locali a loro danno, la reazione è stata aggressiva: prima il sostegno ai golpe “per rovesciare decine di leader eletti democraticamente e sostituirli con dittatori sensibili agli interessi economici occidentali, tenuti in sella con gli aiuti allo sviluppo“. Poi, negli anni Ottanta, Usa ed Europa “scoprirono il loro potere di creditori per dettare le politiche economiche ai paesi indebitati del terzo mondo e governarli efficacemente a distanza” attraverso i programmi di aggiustamento gestiti dal Fondo monetario internazionale. Parole d’ordine: privatizzazioni, taglio della spesa per servizi pubblici, deregolamentazione dell’economia e liberalizzazioni.
Così il debito divenne l’arma per “diffondere il neoliberismo in tutto il pianeta”, chiosa Hickel. Che dà conto come quella ricetta, giustificata prospettando aumenti dei tassi di crescita che avrebbero consentito di ridurre il debito, abbia determinato un aumento esponenziale della povertà. Durante gli anni Ottanta e Novanta il numero delle persone che vivevano con meno di 5 dollari al giorno è cresciuto di oltre 1 miliardo. In America Latina il tasso di povertà è salito dal 40% del 1980 al 62% nel 1993 e in parallelo la quota del reddito nazionale destinata ai salari è diminuita in favore di quella che finiva in profitti. Intanto schizzava all’insù anche la disuguaglianza misurata come divario tra il pil pro capite degli Stati Uniti e quello delle varie regioni in via di sviluppo. E’ la prova, conclude l’autore, che il modello economico attuale basato sulla crescita infinita del pil e sullo sfruttamento intensivo delle risorse naturali è fallimentare e per sradicare la povertà serve un sistema “molto più equo e razionale di distribuzione della ricchezza”, che preveda il ridimensionamento dei consumi e un reddito minimo di base per alleviare la disuguaglianza e “sollevare le persone dall’obbligo di lavorare per 40 o addirittura 60 ore la settimana solo per sopravvivere”.
Articolo Precedente
Def, le scommesse del governo: più crescita con pochi investimenti e interessi sul debito quasi fermi
Articolo Successivo
Il Nobel per l’Economia 2018 assegnato agli statunitensi Nordhaus e Romer
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione