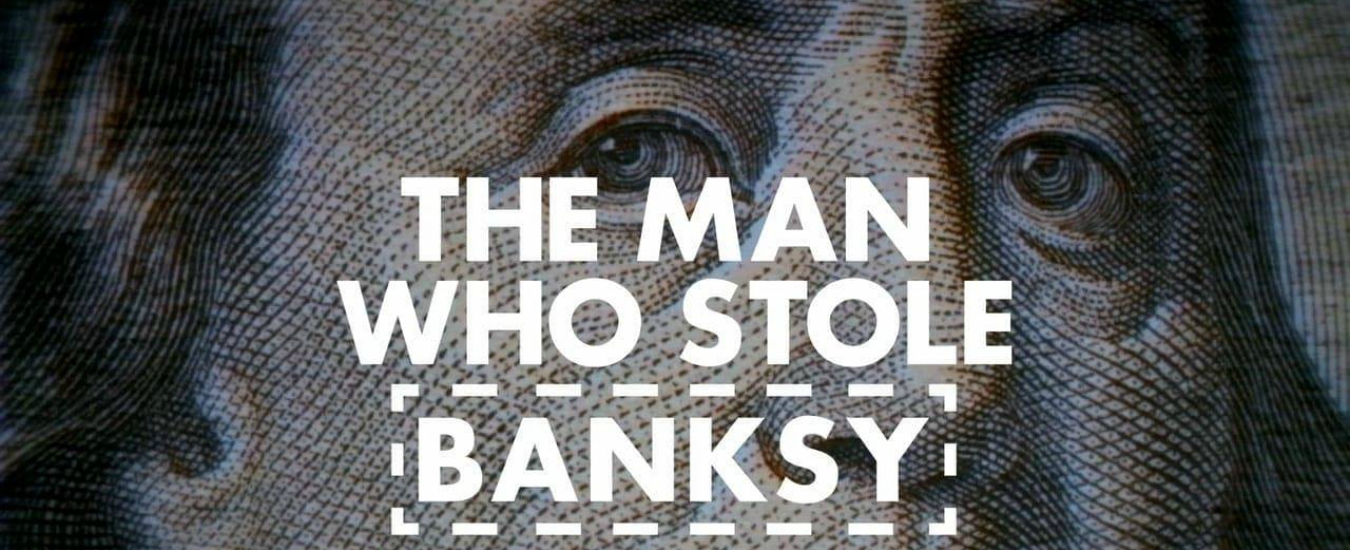Roma, 16 dic. (Adnkronos Salute) - Con il Natale, il calendario indica una pausa dalle lezioni scolastiche, ma in famiglia non arriva automaticamente la calma tanto desiderata dopo mesi di agende piene di impegni, tra scadenze da rispettare, capricci da gestire e voti da recuperare. Sotto l’albero, se non ci si prepara adeguatamente, si rischia di trovare due settimane che mettono a dura prova la relazione genitori-figli, perché il vero problema non è il tempo a disposizione, ma come si gestisce quel tempo insieme. In Italia, secondo un recente sondaggio comparativo realizzato dall’istituto Eumetra nell’ambito del progetto 'Parents', quasi la metà dei genitori (47%) non si sente all’altezza del proprio ruolo educativo, un indicatore di come stress, impegni e carico di responsabilità possano influire negativamente sulla percezione di sé e sulla qualità del tempo dedicato ai figli. Situazione confermata anche dal Cisf Family Report 2025, secondo cui 6 italiani su 10 dichiarano di aver sofferto di ansia o stress lo scorso anno, con ripercussioni inevitabili sulla possibilità di dedicare tempo di qualità alla famiglia.
Cosa può succedere quindi se il tempo delle vacanze non è né strutturato consapevolmente né libero davvero? "Nei figli possono esserci regressioni comportamentali (capricci, atteggiamenti di sfida, gelosie tra fratelli,) e difficoltà a 'staccare' davvero dalla routine talvolta ansiosa legata alla scuola, e il rischio è che al rientro a gennaio siano ancora più stanchi, che i risultati scolastici non brillino, perché il periodo natalizio non è servito a ricaricarsi di entusiasmo ed energie", afferma Federica Ciccanti, pedagogista, pedagogista clinico, mediatrice familiare e autrice di 'Regole facili. Genitori felici (e figli anche)', edito da Vallardi. "Nei genitori, invece, si possono presentare sensi di colpa ('Non sto facendo abbastanza'), frustrazione ('Perché i miei figli non riescono a stare bene insieme senza litigare?') ed esaurimento ('Non voglio più sentir parlare di compiti'). Tutte sensazioni che ledono l’autostima e la capacità di sentirsi 'un bravo genitore' e che si ripercuotono nelle relazioni in famiglia: il filo della comunicazione si assottiglia, i genitori parlano sempre e solo di doveri, prestazioni e comportamenti da correggere e i figli sentono di non essere ascoltati, capiti e si comportano in certo modo solo per evitare rimproveri e non perché capiscono l’importanza di costruire un dialogo sincero con mamma e papà".
Nessun genitore vuole rovinare le vacanze dei figli, ma non sempre sa come affrontare tutti quei giorni di vacanza. C’è chi riempie il loro tempo di impegni, perché vuole che non perdano il ritmo, che non si annoino, che non trascorrano ore e ore parcheggiati davanti a un videogioco e pensa che, anche questa, sia una forma di amore e protezione. C’è chi, al contrario, pur non essendo negligente, 'molla la presa' e li lascia liberi di decidere cosa fare durante il giorno, e spesso lo fa per stanchezza e perché pensa sia sano lasciarli scegliere, almeno quando non c’è scuola. "Non c’è un comportamento giusto e uno sbagliato. In entrambi i casi, quella che dovrebbe essere un’occasione per rafforzare i legami in famiglia diventa fonte di stress, fraintendimenti e distanze. Non si pretendono sacrifici enormi e non si richiede di diventare 'genitori perfetti', ma semplicemente si chiede di essere consapevoli del valore del tempo condiviso. Il regalo di Natale più bello, e spesso più desiderato, è gratuito ed è il tempo insieme", continua Ciccanti. "Le vacanze non sono né un’estensione della scuola né un vuoto da riempire. Sono un’occasione per riscoprire che la relazione genitori-figli è importante e che migliora quando il tempo è lento, ricco di ascolto reciproco e rituali insieme. Ci saranno comunque discussioni, giornate caotiche, momenti di insofferenza, ma investire nel valore del tempo ripaga a breve e a lungo temine".
Ma come riuscirci tra compiti e relax? Ecco 5 consigli pratici della pedagogista per affrontare al meglio le vacanze di Natale in famiglia.
1) Negoziare i compiti, confrontandosi su tempi e modalità. Coinvolgere i figli nel decidere quando fare i compiti, come distribuirli nei giorni di vacanza li fa sentire parte attiva e non semplici esecutori. In questo modo percepiscono vicinanza e ascolto delle loro preferenze ed esigenze. Se sentono che una decisione è anche loro ('Mi alzo prima a fare i compiti, così poi ho il pomeriggio libero') sono più propensi a rispettarla e a portarla avanti in autonomia e vivono quell’impegno in modo diverso rispetto a quando sono costretti a sedersi alla scrivania alle sei di sera dopo una giornata in giro (“Dopo tutto il divertimento di oggi, adesso ti metti a studiare”). Una decisione consapevole e condivisa vince su un obbligo imposto.
2) Proporre piccoli rituali che creano fiducia. Ritagliarsi momenti insieme senza sgridare, controllare che sia tutto perfetto o insegnare qualcosa a tutti i costi, ma stare insieme per il semplice piacere di condividere tempo è uno dei modi più efficaci per nutrire il legame con i figli. Che sia una cena senza telefoni (né dei genitori né dei figli) in cui parlare di tutto tranne che di voti, compiti o modi di fare, o una passeggiata fatta solo per il piacere di camminare uno accanto all’altro, senza fretta e senza mete da raggiungere o, ancora, una merenda in cui siano i figli a condurre la conversazione non è mai tempo perso. È il tempo più prezioso, quello in cui il cervello e il cuore di un figlio registrano sensazioni di sicurezza, attenzione e amore. Sono piccoli rituali che costruiscono fiducia, rafforzano il legame e fanno sentire i figli ascoltati, molto più di qualsiasi spiegazione o lezione.
3) Ritagliarsi momenti insieme. Dire 'mi piacerebbe trascorrere del tempo con te' invece di 'devi finire i compiti' cambia il messaggio trasmesso. Nel primo caso non c’è imposizione, non c’è giudizio, non c’è un compito da portare a termine per meritare la presenza dei genitori. C’è semplicemente una proposta di relazione. Quando i figli sentono che i genitori desiderano stare con loro per come sono, senza dover dimostrare di essere come altri vorrebbero, si rilassano, sono più disponibili ad ascoltare, a collaborare e a mettersi in gioco. La loro motivazione diventa più forte di qualsiasi rimprovero o imposizione. Non si usa la relazione genitori-figli per ottenere un comportamento, ma un comportamento per rafforzare la relazione.
4) Rispettare il bisogno dei figli di 'fare niente'. Dormire un po’ di più, giocare senza uno scopo preciso, gironzolare annoiati finché non trovano da soli qualcosa da fare non sono spreco di tempo, ma spazi preziosi in cui il cervello si riposa, si riorganizza e ritrova equilibrio. Quando i genitori permettono questi momenti senza viverli come una mancanza di disciplina o un cedimento, trasmettono un messaggio importante: il riposo non è un premio, ma un diritto. Concedere la libertà di annoiarsi, di non essere sempre performanti, di prendersi pause significa insegnare loro a riconoscere i loro ritmi, ad ascoltare i bisogni di corpo e mente, e a costruire un rapporto sano con l’energia e il tempo. In un mondo che spinge al fare, concedere il lusso del non fare è uno dei più bei regali che un genitore possa offrire.
5) Parlare delle vacanze come di un 'regalo condiviso', non come di un intervallo. Se i genitori descrivono le vacanze di Natale come 'settimane fortunate in cui possiamo stare insieme senza la solita corsa quotidiana', i figli percepiscono che quel tempo ha valore, che è atteso e prezioso, e il loro atteggiamento diventa più aperto e sereno. Al contrario, quando dicono “Ora vi riposate e poi a gennaio si ricomincia con le cose serie”, il messaggio che si trasmette è tutt’altro: il tempo della famiglia passa in secondo piano rispetto a scuola, impegni e produttività. È come dire, anche involontariamente, che le vacanze sono solo una parentesi, non qualcosa di prezioso in sé. Vivere le vacanze come un dono reciproco, non come una pausa obbligata nel ritmo “vero” della vita, aiuta i figli a sentire che la relazione e la condivisione valgono quanto (se non più) dei risultati e degli obblighi. È questo che dà senso al tempo insieme e che costruisce ricordi che restano.