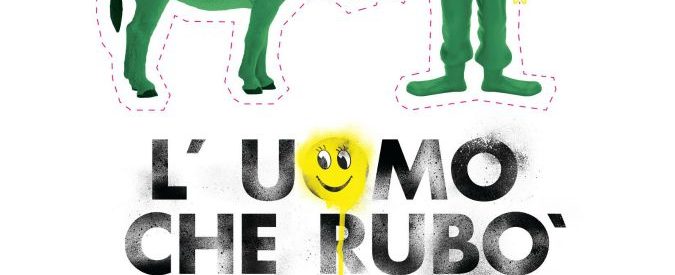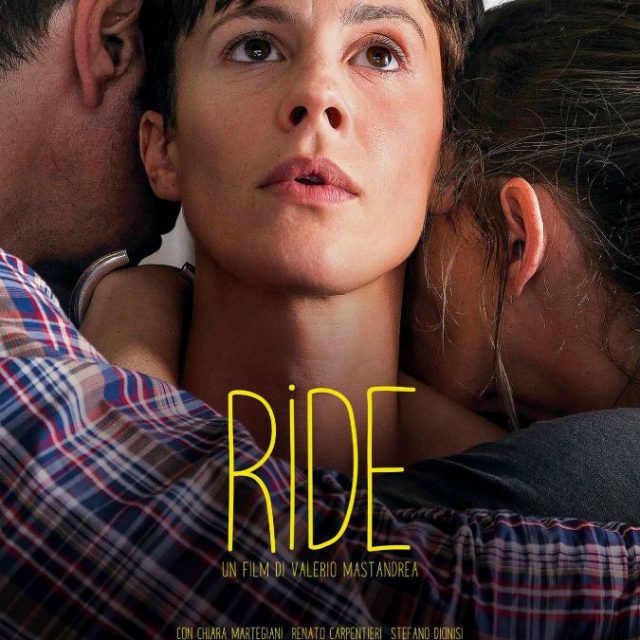Rubare legalmente arte realizzata illegalmente. Che paradosso. Eppure se si tratta di street art la contraddizione calza a pennello, anzi non potrebbe che essere tale. È la voce disobbediente di Iggy Pop a introdurci nella questione, una delle molteplici che animano il denso documentario The Man Who Stole Banksy (L’uomo che rubò Banksy) di Marco Proserpio, ieri nel programma di Festa Mobile al 36° Torino Film Festival.
Ed è proprio il giovane regista a sottolineare che il suo “non è un film sul misterioso nonché geniale artista britannico, il quale ha costituito solo un punto di partenza per raccontare un mondo che ha a che fare – alla fine – con un ritratto della società contemporanea”. Il pretesto è ancorato a un fatto di cronaca avvenuto nel 2007 in Palestina quando il murales realizzato da Banksy a Betlemme presso il varco della West Bank del muro divisorio fu rubato, anzi “smurato” dalla facciata ove poggiava. Mandatario del furto “legittimo” dal suo punto di vista è il proprietario delle mura ove l’artista si è espresso, pitturando il noto due formato da un soldato israeliano e un asino. Convinto che lo street artist più famoso del mondo l’abbia realizzato per il bene del popolo palestinese, tale personaggio si è preoccupato di vendere l’opera al miglior acquirente con l’intenzione di destinare parte degli introiti ai campi profughi. Dallo “smuramento” è iniziato un periplo infinito dell’ “asino di Banksy” e delle sue 4 tonnellate di cemento che lo sorreggono da Betlemme a Londra passando per New York fino a un’asta sempre nella capitale britannica dove è rimasta invenduta. Perché tale, forse, è il suo destino: non essere rimossa dal contesto dove è stata pensata dall’artista nella consapevolezza della sua natura effimera. Ma se questa è l’opinione di Proserpio, che ha impiegato ben sei anni per ultimare il film (nelle sale italiane come evento di Nexto Digital l’11 e 12 dicembre) non è detto coincida con quella dei suoi intervistati, che anzi manifestano convinzioni distanti se non talvolta divergenti sul tema. Se Iggy Pop, perfetto a commentare ironicamente la parabola dell’asino di Banksy, è stata una “prima scelta” e subito ha accettato di prestare la sua voce, dal punto di vista del giovane regista milanese è stata la storia a scegliere di imporsi nella sua vita e non viceversa. “La prima volta che sono entrato in Palestina ho incontrato il taxista Wallid (detto “Wallid la bestia” essendo un accanito fan di body building…) che mi ha raccontato la vicenda di cui mi sono immediatamente appassionato”. Wallid stesso è stato fra gli esecutori dello “smuramento” per conto del proprietario delle mura che poi – con i lauti guadagni – si è aperto il “negozio di Banksy”.
Insomma un circolo vizioso che diventa nello sguardo degli autori (fra essi anche Filippo Perfido e l’artista Christian Omodeo un’acuta e lucida riflessione di filosofia (est)etica sul senso di fare arte oggi, del suo (ormai ricchissimo) mercato, dell’immanenza o della transitorietà della street art, e dunque sulla necessità od opportunità che venga “salvata” e conservata o meno, considerando che per esse non esistono “certificazioni d’autore”. Quanto a Banksy, che mai si vede ma almeno nel doc si sente con una dichiarazione, nessuno sa se abbia visto il film, di certo lo ha visionato il suo entourage che ne ha dato il benestare affinché il misterioso artista potesse almeno “fantasmaticamente” comparire.
 E sull’urgenza di esprimere la propria arte parla anche un altro lavoro visto ieri al festival piemontese, già concorrente all’ultima Berlinale. Si tratta di Dovlatov, eponimico al celebre scrittore russo per mano del talentoso regista suo connazionale Alexej German Jr. Affrontando sei giorni della tormentata esistenza dell’allora giovane scrittore nella Leningrado degli anni ’80, German Jr affresca un’epoca assai particolare della storia sovietica e lo fa con la passione e la competenza di chi l’ha vissuta personalmente. “Tre sono i motivi che mi hanno portato sulle tracce di Sergei: prima di tutto la mia famiglia che conosceva bene i Dovlatov, in secondo luogo perché sentivo il bisogno interiore di tornare nella Leningrado di quegli anni e come terzo motivo, che non è meno rilevante, per raccontare attraverso una figura terza l’esperienza diretta di mio padre che fu vittima negli stessi anni dei medesimi divieti a causa dei quali i suoi film rimasero congelati per circa 15 anni”. Pensato essenzialmente per il pubblico russo (“che lo può capire fra le righe…”) ma acclamato su base internazionale, Dovlatov usa un linguaggio coerente al suo testo, offrendo un linguaggio cinematografico esemplare rispetto al superamento del reale al fine di raccontare il reale stesso. E questo come applicazione del principio seguito da German Jr che “detesta il cinema sociale”. “Io credo – continua il regista russo – che della realtà noi artisti dobbiamo limitarci ad offrire la nostra percezione e non la descrizione in sé. Spero che la mia percezione di tutta l’oppressione sovietica rispetto alla libera espressione artistica e letteraria trovi sfogo nel mio cinema”. Dovlatov col sottotitolo di I libri invisibili uscirà prossimamente in Italia per Satine Film.
E sull’urgenza di esprimere la propria arte parla anche un altro lavoro visto ieri al festival piemontese, già concorrente all’ultima Berlinale. Si tratta di Dovlatov, eponimico al celebre scrittore russo per mano del talentoso regista suo connazionale Alexej German Jr. Affrontando sei giorni della tormentata esistenza dell’allora giovane scrittore nella Leningrado degli anni ’80, German Jr affresca un’epoca assai particolare della storia sovietica e lo fa con la passione e la competenza di chi l’ha vissuta personalmente. “Tre sono i motivi che mi hanno portato sulle tracce di Sergei: prima di tutto la mia famiglia che conosceva bene i Dovlatov, in secondo luogo perché sentivo il bisogno interiore di tornare nella Leningrado di quegli anni e come terzo motivo, che non è meno rilevante, per raccontare attraverso una figura terza l’esperienza diretta di mio padre che fu vittima negli stessi anni dei medesimi divieti a causa dei quali i suoi film rimasero congelati per circa 15 anni”. Pensato essenzialmente per il pubblico russo (“che lo può capire fra le righe…”) ma acclamato su base internazionale, Dovlatov usa un linguaggio coerente al suo testo, offrendo un linguaggio cinematografico esemplare rispetto al superamento del reale al fine di raccontare il reale stesso. E questo come applicazione del principio seguito da German Jr che “detesta il cinema sociale”. “Io credo – continua il regista russo – che della realtà noi artisti dobbiamo limitarci ad offrire la nostra percezione e non la descrizione in sé. Spero che la mia percezione di tutta l’oppressione sovietica rispetto alla libera espressione artistica e letteraria trovi sfogo nel mio cinema”. Dovlatov col sottotitolo di I libri invisibili uscirà prossimamente in Italia per Satine Film.