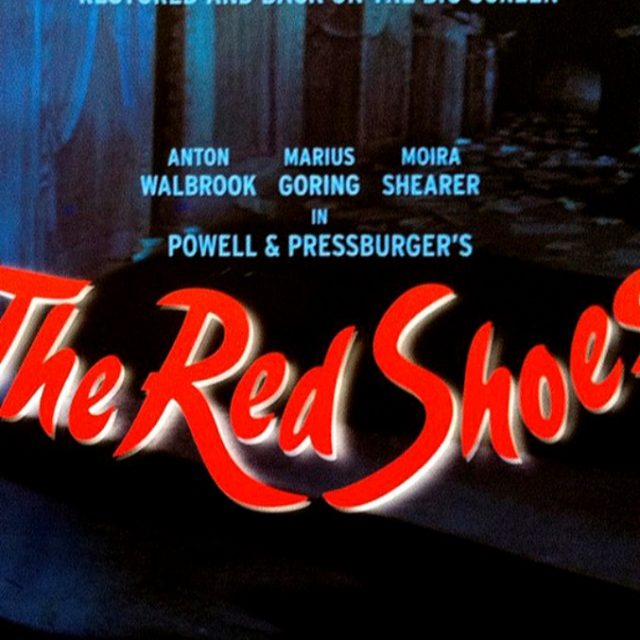Mamma mia c’è Freddie Mercury al cinema. Dopo mille traversie produttive, tra cui il licenziamento del regista Bryan Singer (causa molestie ad un minorenne) e l’abbandono di Sacha Baron Cohen (originariamente protagonista assoluto), Bohemian Rhapsody, il biopic su Mercury e sui Queen uscirà nelle sale italiane il 29 novembre. E se negli Stati Uniti dopo tre settimane i 127 milioni d’incassi lo portano ad essere il secondo biopic su un personaggio musicale più visto di sempre (il primo è Straight Outta Compton sugli N.W.A., il terzo I walk the line su Johnny Cash), Bohemian Rhapsody è uno di quei film che fanno andare in solluchero i fan, ma che si mettono d’impegno a far storcere il naso ai critici.
Intanto al centro del discorso, delle oltre due ore di durata, più che Freddie c’è la “famiglia” dei Queen, e più che i Queen c’è la performance della band e di Freddie al Live Aid organizzato da Bob Geldof allo stadio di Wembley il 13 luglio 1985. Questo per dire che la tensione dell’opera sembra finalizzata ad arrivare e mostrare quello sforzo performativo fin dal prologo. L’attesa dell’evento, il clamore dello slot Queen che fece la storia della musica perché su quel palco di fronte a 100mila persone Mercury, May&Co.furono inarrestabili. Punto e a capo.
Farroukh Bulsara, figlio di immigrati zoroastriani di Zanzibar, scarica valigie ad Heatrow. Siamo nel 1970 a Feltham, sobborghi ad ovest di Londra. Un paio di battute nel salotto di casa (e già si sottolinea il fatto che Freddie non presenta mai ai genitori delle ragazze…) e piombiamo nel retropalco di un mini concertino degli Smile, Brian May e Roger Taylor (John Deacon arriverà dopo). Il “paki” con quattro anomali incisivi per nascita sorprende tutti in fatto di vocalizzi e in men che non si dica diventa il frontman del gruppo. Keep yourself alive, Killer Queen, Somebody to love, i tour, la mezza asta del microfono che rotea in mano a Mercury, i riff di May: dal 1973 al 1978 un album all’anno e concerti annessi (di successo) soprattutto negli Stati Uniti. In mezzo c’è Bohemain Rhapsody, il famoso brano da sei minuti che nessuna radio avrebbe mai trasmesso, la scommessa musicale dei Queen, la giocata che fa saltare il banco.
Da lì non poteva essere che tutta discesa, ma Mercury fa le bizze, il manager amante Paul Prenter lo trascina verso una carriera in solitaria, ma tutto si ricuce in vista del Live Aid nonché della malattia di Freddie, quell’AIDS che se lo porterà via nel 1991. La cavalcata dei successi è rapida, ritmata, elettrizzante. Ma se fai un biopic che ha Mercury in scena praticamente tutto il film non puoi evitare il suo stile di vita fuori dagli schemi, iperbolico, oltre ogni formalità sociale e sessuale. In questo il film ha uno sguardo francamente moralista, abbastanza inatteso. Se dapprima Mercury si innamora e convive con Mary Austin (Lucy Boynton), quella che rimarrà la “persona più importante della sua vita”, la pulsione omosessuale fa capolino, viene confessata alla “moglie”, porta alla separazione (la doppia casa a duecento metri comunicante attraverso le finestre), infine degenera in party/orge con fiumi di cocaina da cui scappano May e soci.
Insomma, è come se l’omosessualità, che poi diventa dissoluzione e abisso personale, fosse la causa mal tollerata della frantumazione della band. In questa lunga parte del film, diciamo quella centrale, la banalità regna sovrana. Freddie è un bimbo cattivo che fa di tutto per non ascoltare i fratelloni grandi, che hanno perfino i capelloni, ma che però sono bravi maritini e padri di famiglia. Viene in mente proprio quello che diceva Baron Cohen sul mancato coraggio di andare in fondo al privato di Mercury, farlo uscire in tutto il suo veemente anticonformismo. Niente. Encefalogramma piatto. Il senso drammaturgico svanisce di fronte a cartoline dal fronte del successo e dalle inquadrature piedistallo delle celebrities. Si vede che producono il film Brian May e Roger Taylor. Si vede che vogliono mostrare primogeniture inattese dei brani (Deacon per Another one bites the dust, May per We will rock you) e dimostrare al pubblico che i Queen sono stata l’unica band al mondo in cui la ragionevolezza pagava e il motto era “tutti per uno e uno per tutti”.
Non pervenuti, insomma, un vero e proprio sguardo e un taglio, un senso al livello drammaturgico che non sia l’esaltazione, ovviamente travolgente, quella buona solo per i fan, dei successi della band. Infine, il classico parametro biopic: la mimetizzazione con l’originale. E anche qui non si va per il sottile. Perché l’obiettivo è l’effetto Madame Tussaud. Gwilym Lee (May) e Joseph Mazzello (Deacon) sono due gocce d’acqua. Rami Malek (Papillon, Old boy) nel rifare Mercury gigioneggia assai nella prima mezz’ora di film, quando ancora i Queen devono diventare celebri, e qua e la ricorda più Frank-n-furter del Rocky Horror che la sagoma irrefrenabile che segnerà i live dei Queen. Sarà per i capelli lunghi e per quella protesi dentale che allarga gli incisivi e appesantiscono credibilità e fluidità motoria, ma Malek entra degnamente in parte nel secondo tempo con il look capello corto, baffi e occhiali da sole, che è poi il marchio iconografico mondiale del leader dei Queen.
Infine ci sono le cinque macroscopiche incongruenze storiche che il biopic cinematografico s’inventa di sana pianta, come segnalato da rollingstone.com. Il primo: nel film Freddie si offre all’improvviso dal nulla alla band di May e Taylor, gli Smile, un attimo dopo che il bassista/cantante Tim Staffell li ha abbandonati con gli strumenti in mano nel retro del locale in cui avevano suonato. In realtà Mercury conosceva bene Staffell e addirittura Brian May gli aveva chiesto più volte di far parte degli Smile. Seconda invenzione (questa piuttosto organica alla prima): Freddie incontra Mary (futura moglie) trenta secondi prima di incontrare May e Taylor nel parcheggio. In realtà la Austin conosceva May e frequentava le serate degli Smile da parecchio e conobbe Freddie tempo dopo. Terzo: nel film Deacon suona il basso nel primo concerto dei Queen nel 1970, ma anche i bimbi sanno che Deacon suonò live la prima volta nei Queen nel 1971. Quarto: il discografico Ray Foster, interpretato da Mike Myers, il tizio che rifiuta Bohemian Rapsody, quello che avrebbe prodotto Dark side of the moon, non esiste. Probabilmente il personaggio si rifà a Roy Featherstone, capo della EMI, che però in realtà era un grande fan della band. Quinto, ma ce ne sarebbero anche un sesto e un settimo: i Queen non si sono mai separati nel 1983 con Freddie che gli dichiara il compenso che ricaverà da cantante singolo, e quindi non è storicamente vera nemmeno la reunion prima del Live Aid, scena topica del film.