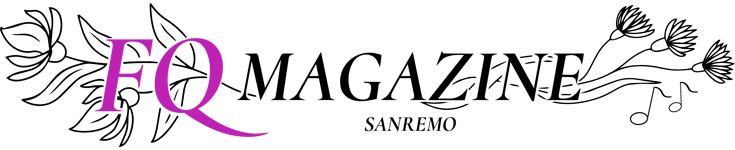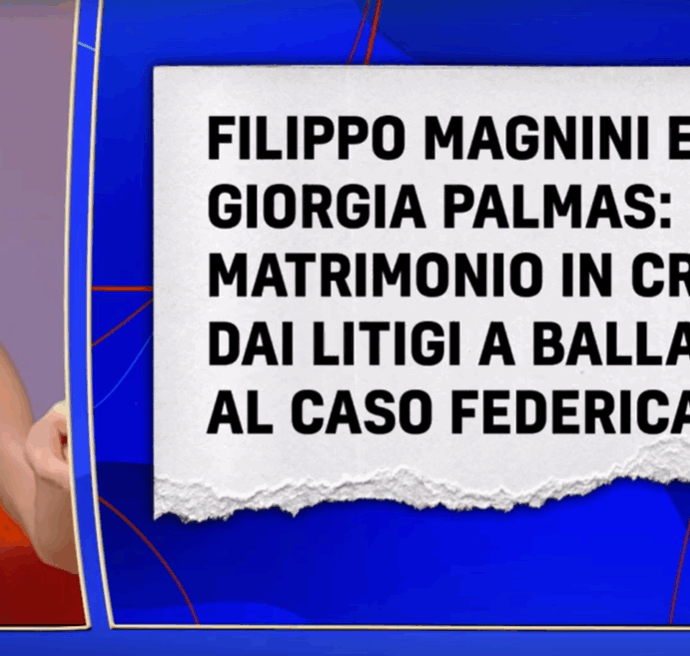Lo chiamavano Agonia. Claudio Baglioni, 67 anni da Centocelle, padre contadino e carabiniere, madre casalinga, sta bello ritto in cima alla prua nazionalpopolare del Festival di Sanremo senza oscillare mai. Oh capitano, mio capitano. Da brutto anatroccolo esistenzialista a maturo figo con classe; da icona piccolo borghese disimpegnata anni Settanta (“mentre voi ascoltavate Baglioni noi ascoltavamo gli Inti-Illimani”) al duetto riparatore prodianveltroniano anni Novanta chez Fazio ad Anima mia con il gruppo cileno; da perfetto sconosciuto di borgata a milionario re Mida della canzone italiana. Fulgida bandiera del pop romantico, compendio poetico del cantautorato divincolato dal contesto socio-politico, Baglioni è l’uomo della provvidenza arrivato al momento giusto nel posto giusto. Uno a cui si affida il timone quando si intravede burrasca.
Dai palla a Claudio, tanto anche se la canzoni del Festival faranno pietà (a proposito chi ha vinto l’anno scorso?), lui un dribbling, una finta, un cucchiaio per portare a casa il risultato te lo fa. Eppure Claudio piccino, adolescente, quasi adulto, aveva paura di non farcela. Signora Lia (1970), brano (bellissimo) non fumato da nessuno, criticato, azzoppato, cancellato. Due anni dopo, il boom. La maglietta fina, quella della futura moglie Paola Massari, quella di Questo piccolo grande amore (1972) che diventa disco più venduto nella storia della musica italiana. Un successo nazionale da ola in curva sud. Claudio, lungo lungo, prima con gli occhialetti scuriti come Nicola di Bari, poi zazzerona modello hippie da pomiciata in riva al mare con chitarra e falò, sfonda e diventa popolarissimo ovunque, dalle Alpi all’Etna. E ancora: permanente vaporosa da copertina anni ’80 per Tv Sorrisi e Canzoni, poi con taglio corto, corretto, maturità tricologica, per l’affermazione definitiva e santificata da vendite milionarie canticchiate sotto la doccia, modello La Vita è adesso e Io sono qui. Infine l’apoteosi del cassero sanremese da cui si dominano nave e orizzonte per un pubblico di massa (che lo adora). Claudio gira perfino lo spot promozionale dove casca e rotola dalle scale, anche se lui, da quella scalinata alla Wanda Osiris, non ruzzolerà mai. Bravissimo nelle moltiplicazioni, disastroso nei temi, spiegò nella sua biografia, perché “non che facessi errori, ma perché scrivevo cose stravaganti, incomprensibili”.
I “viaggi” a vuoto alla RCA, Ruggero Cini pianista di Gino Paoli che punta su di lui, Lucio Dalla che lo consola dopo una prima disastrosa. Baglioni, a dirla tutta, sarebbe il solito incompreso dalle major del disco. Altro che talent. Altro che “per me è un sì”. Ripassi un’altra volta. Grazie lo stesso. Claudione si inventa il “suo” concept album – all’epoca si faceva ed era una gran bella storia – e dentro gli italiani ci trovarono la spensierata intimità di una maglietta fina, come la caciarona e corale Porta Portese, affezionandosene come forse fecero i loro padri con quella Casetta in Canadà, che pare essere il primo brano cantato in pubblico dal nostro. Inquieto, nonostante il successo, Baglioni scappa a Parigi per comporre un’opera rock alla Tommy, incontra Vangelis e piazza il carico di E tu… Mica tanto Who, semmai Baglioni touch puro, in controluce ma già evidente. Un anno dopo è tempo di Sabato pomeriggio (e Poster). Altri cuori, altra spensieratezza, altra gioventù poco bruciata. Baglioni diventato “musicista” ricorda però come quell’epoca tardo Settanta fosse “un periodo nero”. La quadratura del cerchio passa ancora da questa mesta e sfortunata atmosfera con cui Claudio racconta la sua vita. Strada facendo (1980), l’album dell’affermazione reale, venne registrato in Inghilterra, ad Oxford, nei Manor Studios. E lui viene accolto alla dogana inglese come un sinistro profugo. Spogliato di tutti i vestiti. Nudo nello stanzino di frontiera, Baglioni riemerge. Si canta e si racconta, forse con maggiore intimità.
Tra il milione e rotti di copie vendute con Strada facendo e i quattro milioni del 33 giri La vita è adesso, ci sono di mezzo giusto il figlio Giovanni e un Avrai da paura nell’album Alé-oò. Baglioni a metà anni ottanta è il re della canzone italiana. Quando nel 1990 esce Oltre, il disco della scommessa, quello della riscrittura elettronica, ermetica, etnico-naif dell’etichetta baglioniana, il mondo si divide tra ditirambi e infastiditi. “Un disco di confine, pioniere e scellerato, ma non contrabbandiere”, lo definì lo stesso Baglioni. Ancora una volta prova superata. Anche perché il ragazzo di periferia aveva intuito la forza delle dimensione live, del contatto col pubblico, dell’ammirazione popolare dal vivo. Lo racconta lui stesso quando parla della promozione di Oltre, dei concerti che ne seguono, alcuni davvero improvvisati, tanto che il Claudio nazionale, quello degli spot sanremesi travestito da vigile, finisce addirittura su un camioncino che gira per Roma davanti ad un passeggero di un tram. Un concertino al volo solo per questo signore. Io sono qui (1995) è infine l’apoteosi del live. Come delle paure e delle indecisioni di Baglioni. Non più affetto da “baglionismo” (“mi hanno sempre accusato di sermoneggiare, di fare il messia quando canto come se non sapessero che di fronte a 60mila persone in uno stadio sembri il papa anche se dici buona sera”), ma da una nuova vena compositrice, una rinascita artistica e comunicativa. Baglioni si scioglie dal ghiaccio primitivo del romanticismo pop e si fa uomo. Autoironico e definitivo, tra l’altro, proprio nel programma tv Anima mia (1997). Quando Fabio Fazio portava ancora il gilet. Il revival che non t’aspetti. La nostalgia per un passato ancora vicino che si sposa senza troppe fisime alla consapevolezza dei gusti popolari. E Baglioni è lì. Troneggia, spavaldo e sorridente. Duetta di mestiere, e di baglionite, con I cugini di campagna. Gorgheggia baglionescamente introducendo una Un pueblo Unido da brividi degli Inti-Illimani. Il compromesso storico non avvenuto del tutto nel 1978 è su Rai2 vent’anni dopo.
Infine Baglioni e Sanremo. Prima del 2018, prima del reame indiscusso e adorato, un legame fisicamente inesistente. Se non fosse stato per quella traccia da superospite nel 1985. Pianoforte a coda nero, giacchetta d’ordinanza e camiciola azzurro impiegatizia con bottone aperto sul collo. Quattro cinque accordi in scioltezza. Quella sua maglietta fina. La solita A prolungata, vibrante e tremante. Baglioni e Sanremo. Qualche articoletto, sempre in quegli anni, per Il Messaggero. Un Baglioni esperto che discetta di canzonette e di cantautorato. Perfino malinconico. Favolosi questi settanta che non tornano più. Dalla prua dell’Ariston. Con invidiabile coraggio. Cari saluti, firmato Claudio. “A me, anche se ero tra quelli che scrivevano di cose private, di piccole storie e realtà, che l’impegno lo vedevano e lo vedono ancora nel far sempre meglio questo “mestiere” e nello scrivere musica, se possibile, buona, e parole che facciano bene, o anche male, ma senza proclami né slogan, manca un poco quel tempo di grandi voglie e di gran confusione che molti ora rinnegano, ma che ha portato tante buonissime cose”.