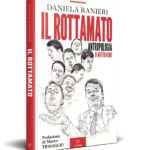Il pacchetto Treu, la legge approvata nell’estate del 1997 dal primo governo Prodi, è considerata il momento in cui il processo di flessibilizzazione del mercato del lavoro italiano ha realmente inizio. La legge era intitolata “Norme per la promozione dell’occupazione” e includeva parte dei contenuti del Patto del lavoro, siglato da governo e parti sociali l’anno precedente. Derogando al divieto di interposizione di personale introdotto nel 1960, la riforma introduceva in Italia per la prima volta il “contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo”. Ovvero, il lavoro interinale. La legge agevolava anche l’adozione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i famigerati co.co.co.
Il pacchetto Treu, la legge approvata nell’estate del 1997 dal primo governo Prodi, è considerata il momento in cui il processo di flessibilizzazione del mercato del lavoro italiano ha realmente inizio. La legge era intitolata “Norme per la promozione dell’occupazione” e includeva parte dei contenuti del Patto del lavoro, siglato da governo e parti sociali l’anno precedente. Derogando al divieto di interposizione di personale introdotto nel 1960, la riforma introduceva in Italia per la prima volta il “contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo”. Ovvero, il lavoro interinale. La legge agevolava anche l’adozione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i famigerati co.co.co.
La riforma del mercato del lavoro avvicinava l’Italia ad altri Paesi europei caratterizzati da forme di precarizzazione analoghe, ma apparentemente moderandone certi tratti più selvaggi. Il lavoro interinale risultava maggiormente regolamentato, e il suo utilizzo più difficoltoso che altrove. Uno dei motivi per cui questo tipo di contratto ha relativamente avuto un’incidenza marginale negli anni Novanta. Solo lo 0,4% dell’occupazione nei primi cinque anni successivi alla riforma sarebbe stato costituito da lavoratori interinali.
La figura del co.co.co era precedente alla riforma, esistendo dagli anni 1970, ma la sua diffusione era più recente. Nel 1996, l’introduzione di un contributo pensionistico obbligatorio del 10% ne aveva fatto emergere quasi un milione. Soltanto nel 2002, i co.co.co erano più che raddoppiati. Gli iscritti nel fondo della Gestione separata dell’Inps ammontavano a 2.392.527. Per lo più donne, per le quali il co.co.co costituiva l’unica forma possibile per entrare nel mondo del lavoro, e spesso la sola per rimanerci, in particolare nell’Italia meridionale. Oltre il 90% lavorava per un solo committente, il che lasciava intendere che i co.co.co fossero in realtà dei contratti di lavoro subordinato mascherati e a bassissimo costo.
Nello spazio di meno di un decennio, dal 1992 al 2000, complessivamente il lavoro atipico era aumentato del 45%, passando dal 10,6% al 15,2% dell’occupazione dipendente totale. Ed era divenuto la forma necessaria per l’ingresso nel mondo del lavoro per i giovani, in alternativa al contratto standard. Nelle due congiunture economiche positive per l’occupazione attraversate dall’Italia negli anni Novanta, tra il 1995 e il 1997, e tra il 1997 e il 2000, rispettivamente il 97% e l’82% dei nuovi occupati era stato assunto con un contratto di lavoro atipico.
Il puntello teorico a sostegno delle politiche del lavoro che adducendo effetti benefici sui livelli di occupazione producevano precarizzazione risiedeva – e risiede – nel più basico dei principi del liberismo. Ogni ostacolo alla regola del mercato del libero incontro tra domanda e offerta, che questo coincida con la legislazione del lavoro ovvero con il ruolo del sindacato, crea inefficienze. Tuttavia, riguardo all’esperienza degli anni Novanta per molti, tra cui per il contesto italiano Luciano Gallino, una relazione causale tra la moltiplicazione di strumenti contrattuali atipici e la riduzione della disoccupazione non è dimostrabile.
Se il pacchetto Treu rappresenta il momento di svolta nelle politiche del lavoro, culturalmente – e non solo – il cambiamento di paradigma risaliva agli anni Ottanta. Era una reazione alle difficoltà generate dalla crisi economica degli anni Settanta, certo. Una strategia volta ad adattare la variabile lavoro alle esigenze del nuovo sistema produttivo postfordista e ad abbassarne il costo di fronte a una competizione economica destinata a diventare sempre più internazionale. Ma era anche legato alla volontà delle imprese di recuperare il potere perso a favore dei lavoratori e del sindacato durante il ciclo di lotte post 1968.
Il cambiamento dal sistema produttivo e dalle politiche pubbliche si è poi progressivamente traslato sul piano antropologico. Divenendo un apparato ideologico pervasivo capace di sussumere la dipendenza dalle esigenze del mercato, con la sua instabilità cronica, e la precarizzazione permanente delle esistenze nei principi di autonomia, libertà individuale e merito, recuperando a suo modo parte del discorso libertario emerso con il 1968.
Negli anni Ottanta il mito della flessibilità ha così cominciato a eclissare la realtà del precariato. Il Psi di Craxi si è allora imposto come il primo interprete a sinistra del nuovo credo. Con il Lodo Scotti del gennaio 1983, e ancor più con l’accordo di San Valentino (1984), per la prima volta la flessibilità diventava ufficialmente oggetto di negoziato tra parti sociali e governo, e si traduceva in politiche pubbliche.
Da allora, i governi Prodi, Berlusconi, Monti, Renzi si sono distinti per aver contribuito all’erosione del lavoro stabile. Proprio Renzi è riuscito con il Jobs act, dove governi di destra e tecnici avevano fallito. In piena stagnazione economica seguita alla crisi del 2008 e con un tasso di disoccupazione record che si attestava attorno al 12%. Il Jobs act rimarrà alla storia come l’ultimo – e decisivo, almeno fino al prossimo assalto – tassello del processo regressivo che ha interessato negli ultimi quarantanni il sistema delle tutele del lavoro subordinato. Modificando radicalmente l’articolo 18, rendendo in questo modo più facili e meno costosi i licenziamenti per ragioni economiche e disciplinari, aumentando ulteriormente la flessibilità in entrata, indebolendo lo statuto stesso del lavoratore subordinato a tempo indeterminato.
Eloisa Betti ha pubblicato per i tipi della Carocci una storia politica e intellettuale del precariato intitolata Precari e precarie, una storia dell’Italia repubblicana. Il libro ha il merito di inserire la questione del lavoro precario lungo tutto l’arco della storia repubblicana. In prospettiva storica, gli ultimi decenni appaiono come un movimento a senso unico che ha reso le frontiere tra lavoro, precariato e disoccupazione sempre più porose e labili e più pressante la domanda di un suo ripensamento critico.
*Massimo Asta è uno storico dell’università di Cambridge
Twitter: @astamassimo