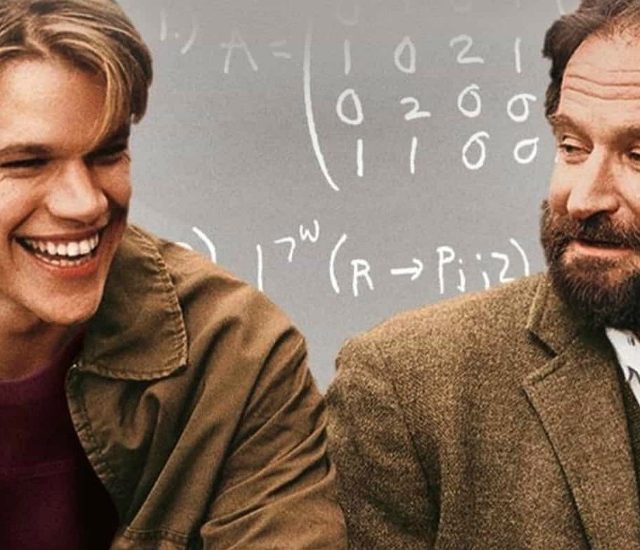Per chi rimase scioccato dalla sua assurda e orribile morte, o anche solo per chi l’ha apprezzato come attore di razza, Love Antosha, è un toccante e onesto biopic sulla vita breve del compianto Anton Yelchin. Direttamente dal Sundance al Biografilm Festival di Bologna, il documentario diretto da Garret Price è la ricostruzione al limite dell’autobiografico (e a breve vi spieghiamo il perché) di una carriera attoriale limpida, fulminea, ma forse mai pienamente e giustamente esplosa, minata da una terribile malattia e rinvigorita da un continuo slancio vitale.

Figlio di una coppia di famosi pattinatori di Leningrado, trasferitisi a Los Angeles a metà anni ottanta, Yelchin esordì nel 2000 a nemmeno undici anni sul set di ER – Medici in prima linea per poi diventare presto una star bambina e infine un ragazzino fragile sballottato da amicizie ed eventi, tra cinema di genere e film generazionali (Cuori in atlantide-Charlie Bartlett-Alpha dog-Porto, per tracciare una possibile linea qualitativa). Infine il franchise di Star Trek che lo rese popolare oltre gli Stati Uniti ma senza mai permettergli quel “taking off” che tanto viene mostrato nello sfoglio di riviste e giornali del settore nel doc di Price.
 Biopic che a dire il vero è però una forma di affettuosità, un omaggio, una pagina di diario delle medie per ritrarre il vulcanico agire, dimenarsi, recitare, cantare, trasformarsi di un attore che fin da bimbo soffrì di fibrosi cistica. Il recupero nostalgico e sgranato di vhs modello home-movies, come di piccoli cortometraggi (perfino ben montati) di Anton bambino che recita Travis Bickle o Anthony Perkins, o che inventa soluzioni stilistiche alla Lynch con l’amico del cuore, è qualcosa che ha più a che fare con la sfera emotiva che quella della classificazione di dettagli per fare numero.
Biopic che a dire il vero è però una forma di affettuosità, un omaggio, una pagina di diario delle medie per ritrarre il vulcanico agire, dimenarsi, recitare, cantare, trasformarsi di un attore che fin da bimbo soffrì di fibrosi cistica. Il recupero nostalgico e sgranato di vhs modello home-movies, come di piccoli cortometraggi (perfino ben montati) di Anton bambino che recita Travis Bickle o Anthony Perkins, o che inventa soluzioni stilistiche alla Lynch con l’amico del cuore, è qualcosa che ha più a che fare con la sfera emotiva che quella della classificazione di dettagli per fare numero.
 Anzi in Love Antosha, con le figure iperpresenti di mamma e papà Yelchin (soprattutto mamma) come compendio descrittivo, in quei filmati amatoriali sembra come riconoscere un filo conduttore sulla raffinata arte di Yelchin vagamente incompreso in tutto il suo potenziale creativo. Poi certo appaiono le testimonianze celebri di Anthony Hopkins e Martin Landau, degli attori di Star Trek (Simon Pegg, Chris Pine, John Cho), la confessione di Kristen Stewart a cui Anton quattordicenne durante le riprese di Gioventù violata “spezzò il cuore”, o le storie professionali di grande affinità con le ancora sconosciute Felicity Jones e Jennifer Lawrence. Il rispetto per il collega e per l’uomo è dato doveroso, ma qui sembra esserci qualcosa di più. Un soffio di gratitudine per quel viso pallido e quel ciuffo riccioluto dedito di continuo a scansare la fatica dell’inazione, a rilanciarsi anche per parti laterali pur di rimanere in piedi e non soccombere alla malattia.
Anzi in Love Antosha, con le figure iperpresenti di mamma e papà Yelchin (soprattutto mamma) come compendio descrittivo, in quei filmati amatoriali sembra come riconoscere un filo conduttore sulla raffinata arte di Yelchin vagamente incompreso in tutto il suo potenziale creativo. Poi certo appaiono le testimonianze celebri di Anthony Hopkins e Martin Landau, degli attori di Star Trek (Simon Pegg, Chris Pine, John Cho), la confessione di Kristen Stewart a cui Anton quattordicenne durante le riprese di Gioventù violata “spezzò il cuore”, o le storie professionali di grande affinità con le ancora sconosciute Felicity Jones e Jennifer Lawrence. Il rispetto per il collega e per l’uomo è dato doveroso, ma qui sembra esserci qualcosa di più. Un soffio di gratitudine per quel viso pallido e quel ciuffo riccioluto dedito di continuo a scansare la fatica dell’inazione, a rilanciarsi anche per parti laterali pur di rimanere in piedi e non soccombere alla malattia.
Ad acuire il senso di (auto)biografia ci sono poi diversi stralci di interviste con la voce nasale fuori campo di Yelchin ad accompagnare le immagini e la voce narrante di Nicholas Cage al posto del fu protagonista che aiuta a ricostruirne i pensieri scritti su diari e bigliettini dell’attore. I buffi aneddoti del mestiere, infine, tra cui l’assurdo accento russo usato in Star Trek, invenzione spiritosa e improbabile che finì per essere accettata da un piccolo genio come J. J. Abrams, delineano definitivamente le doti di un ragazzo esuberante e gentile che ha finito troppo presto la sua parabola di star del cinema a soli 27 anni.